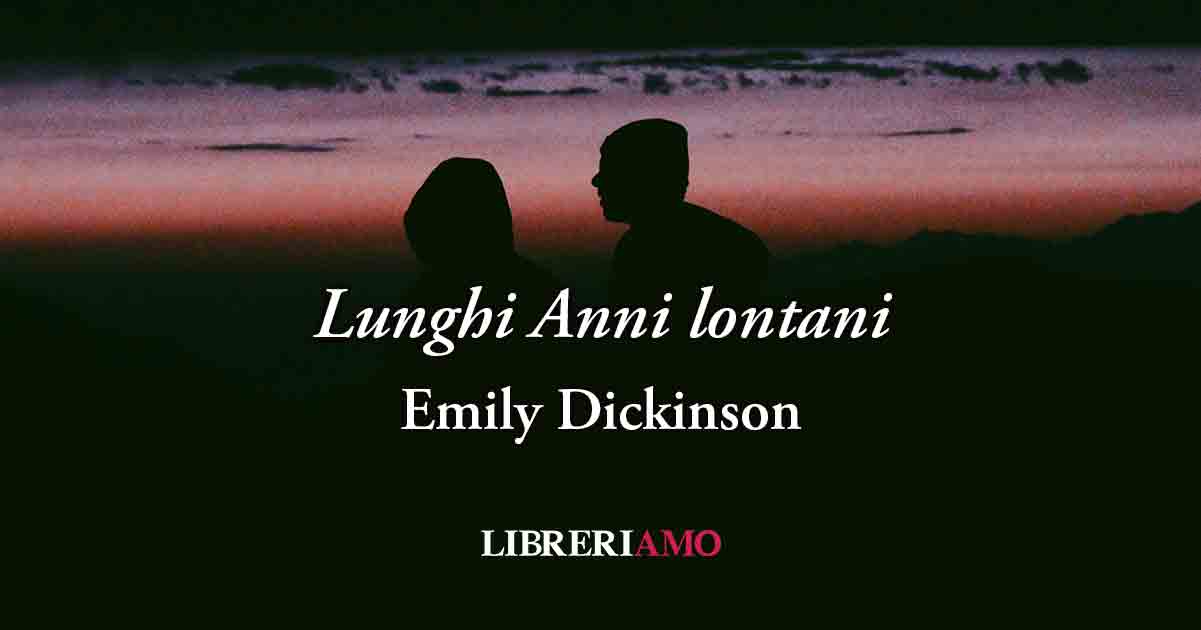La scrittrice, che vive e insegna creative writing a New York, ci presenta il suo nuovo romanzo ”L’amore involontario”, parla della sua vita all’estero e di come siano diverse le abitudini di italiani e americani in fatto di lettura
MILANO – ”Cervello letterario” fuggito all’estero, Chiara Marchelli ora vive a New York, dove insegna creative writing alla New York University – tra gli autori italiani ospiti ai suoi corsi ci sono stati nomi come Chiara Gamberale, Antonio Scurati, Fabio Geda, Mario Calabresi. La condizione di spaesamento in cui sente a volte di vivere si riflette nei suoi personaggi, come Irene e Riccardo de ”L’amore involontario” (Piemme), italiani trasferitisi come lei nella Grande Mela. In questo suo nuovo libro, uscito l’8 aprile, racconta l’intensa storia di due fratelli che, dopo molti anni di silenzio, “si ritrovano”. Accade proprio nel momento più impensato, mentre Irene, scrittrice di successo, è in coma in seguito a un incidente stradale e Riccardo, costretto a starle accanto, inizia a leggere il libro che ha causato il litigio tra i due. Riccardo non era riuscito a perdonare che lei, in quel libro, avesse scritto di lui, di un trauma che aveva vissuto e che non era riuscito a superare. Ora però quelle parole scritte gli riportano la voce di Irene. Chiara Marchelli ci parla del suo romanzo e della sua esperienza da “emigrata”, che condivide con tanti altri italiani.
Com’è venuta l’idea del libro?
Ogni storia ha una genesi lunga e silenziosa dentro di me. Raramente scrivo appunti quando ho un’intuizione; lascio che un’idea sedimenti dentro, che si mescoli con le intenzioni, le pulsioni, la vita che nel frattempo scorre e andrà a impastarvisi. Si può trattare di un magma in muta ebollizione da anni come del sussulto di un attimo, innescato da un incontro, un panorama, un pezzo musicale, una lettura. “L’amore involontario” fa parte del primo gruppo: è una storia rimasta a lungo dentro di me, senza che potessi neppure delinearne i confini, e un giorno – una mattina d’estate all’alba, mentre ero in auto su una strada affacciata sul mare e ascoltavo i Sigur Rós – è venuta fuori, chiara e completa.
Questo romanzo ha due voci forti. C’è una in cui si è più immedesimata? Da quale punto di vista ha vissuto la storia, dalla prospettiva di Irene o di Riccardo?
Da quella di entrambi. È stato un processo interessante, faticoso, a tratti anche doloroso. Entrare nella testa e nelle emozioni dei due personaggi era ciò che volevo e dovevo fare per tentare di offrire veridicità e giustizia a ognuno. Ci sono stati momenti in cui ero talmente dentro uno che non riuscivo a scrivere che di lui, e soltanto dopo, forzandomi a una specie di disintossicazione, riuscivo a passare all’altra. Ma altrimenti è stato un palleggio quasi naturale: i due personaggi si parlano, nel romanzo, e così nel processo di scrittura: prendevano o si lasciavano spazio a vicenda, come se portassero dentro sé l’equilibrio necessario a narrarsi.
La condizione di spaesamento dei due protagonisti, italiani trasferiti a New York, riflette quella che in tanti stanno vivendo ai giorni nostri. Sono sempre più numerose le persone che lasciano il nostro Paese e si costruiscono una vita all’estero, tra cui lei stessa. Può dirci che cosa si prova, quello che ha raccontato attraverso i suoi personaggi?
Vivo a New York da quindici anni e penso di rientrare in Europa da almeno dieci. La mia è una condizione d’irrequietezza cronica, che probabilmente ha molto a che vedere con la mia natura, ma sono innumerevoli le serate spese a parlare di questa voglia, che si fa urgenza acuta a tratti, insieme ai miei amici italiani a New York. Emigrati per scelta (nessuno di noi è arrivato qui con la valigia di cartone), immersi in una società che ha risposto alle nostre esigenze professionali ma, spesso, non alle altre: la corrispondenza culturale, il territorio, le radici per sempre recise e mai più reimpiantate. È una condizione di fortunato esilio, soprattutto per me che ho scelto due cose essenziali: la scrittura e il tempo. Insegnando a NYU, ho tempo per scrivere e rientrare in Italia per lunghi periodi. Ci sono momenti in cui mi pare di avere raggiunto l’equilibrio ideale: un po’ di New York, un po’ d’Italia. Forse è arrivato il momento di accettare il fatto che ho per sempre perso le connotazioni identitarie in cui mi riconoscevo e con cui sono cresciuta per diventare una cosa nuova, che un giorno sarà normale, ma che oggi è ancora una sorta di esperimento, di scommessa pionieristica. (O forse è arrivato il momento di tornare a casa.) Credo che le mie storie riflettano, attraverso le loro ambientazioni, questo.
Irene, in coma, parla attraverso le parole del suo libro, quello che è stato il motivo di discordia con Riccardo. È un modo per dire che i libri sono qualcosa di vivo, per sottolineare una continuità tra la scrittura e la vita?
Può essere certamente così. In questa storia, le parole di un libro hanno sostituito una comunicazione che non era più possibile. Riccardo aveva bisogno di una voce che gli arrivasse in modo diverso per tornare ad ascoltare.
Lei ha modo di osservare le abitudini di un Paese diverso dal nostro. Crede che l’interesse per il mondo dei libri e della lettura sia maggiore lì che da noi, e se sì perché?
Credo di sì, ma non perché gli Stati Uniti siano un Paese che legge così tanto, quanto perché in Italia si legge troppo poco. Ho letto qualche giorno fa nel blog di Stefano Tettamanti che, secondo i dati raccolti dall’Ocse (l’organizzazione internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico), “gli italiani non leggono perché non sanno leggere. Oltre l’80% degli italiani fra i 14 e i 65 anni non è in grado di comprendere il significato di una semplice proposizione scritta (soggetto, predicato e qualche complemento) ed è dunque incapace di orientarsi nella società contemporanea. Tecnicamente non si potrà parlare di analfabetismo vero e proprio, ma definendo gli italiani analfabeti si fotografa con buona e sconcertante approssimazione più dell’80% dei nostri connazionali in età di lavoro”. Possibile?, mi sono chiesta. Tettamanti con molta ironia seda (o fa finta di sedare) la propria frustrazione di fronte a questi dati, ma io rimango con un’insoddisfazione profondissima: tutte le persone che conosco sanno leggere, eppure tante di loro non aprono nemmeno un libro all’anno. Nei libri c’è tutto: ce lo siamo dimenticato?
10 aprile 2014
© RIPRODUZIONE RISERVATA