“Che succede a Baum?” di Woody Allen, il primo romanzo tra nevrosi, segreti e autoironia
A quasi novant’anni Woody Allen pubblica “Che succede a Baum?”, il suo primo romanzo: ironico, nevrotico e diviso tra elogi e critiche nel mondo.
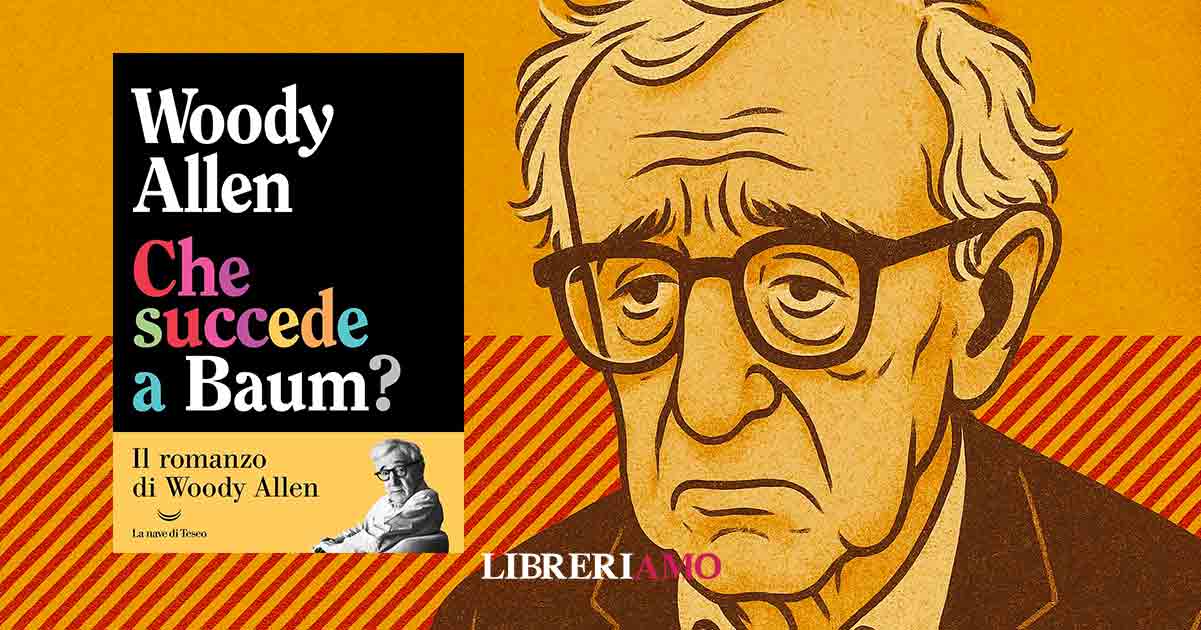
A quasi novant’anni, Woody Allen pubblica il suo primo romanzo, Che succede a Baum? (La Nave di Teseo, 2025), un’opera che riassume tutto il suo universo creativo e umano. Protagonista è Asher Baum, un intellettuale ebreo di mezza età in crisi personale e professionale. Ex giornalista e drammaturgo, è stato abbandonato dal suo prestigioso editore newyorkese e vive un matrimonio traballante.
È la storia di un uomo che cerca disperatamente di trovare un senso in un mondo che non lo ascolta più. È anche il ritratto di un autore, Woody Allen stesso, che a quasi novant’anni si guarda allo specchio e sceglie ancora una volta l’ironia come arma contro la malinconia.
Un romanzo dove tutto è familiare, eppure tutto è diverso, perché Allen non racconta più solo l’amore o la nevrosi, ma la fatica di restare vivi e lucidi in un tempo che cambia troppo in fretta. Un libro che come da caratteristica del suo autore ha diviso la critica e proprio per questo merita di essere letto per farsene una propria idee. Come sempre le critiche nelle opere di tutti i settori della cultura lasciano il tempo che trovano.
Il libro con il titolo What’s With Baum? è uscito negli USA pubblicato da Post Hill Press (distribuito da Simon & Schuster) e nel Regno Unito da Swift Press.
Che succede a Baum? di Woody Allee, la trama del romanzo
Il protagonista del romanzo di Woody Allen è Asher Baum, un intellettuale ebreo newyorkese di 51 anni, ex giornalista e drammaturgo, la cui carriera è ormai in declino. Dopo alcuni romanzi accolti tiepidamente e spettacoli teatrali falliti (uno andato bene solo in Slovenia, come ironizza lui stesso), Baum vive un momento di profonda crisi esistenziale e professionale.
Il suo editore storico lo ha abbandonato, ritenendolo troppo “oscuro e filosofico” per il mercato. Gli si chiede di scrivere qualcosa di più “commerciale”.
Un matrimonio al capolinea
Sul piano privato, la vita di Asher non va meglio. È al terzo matrimonio, con Connie, una donna elegante e distante, cresciuta a Beverly Hills, che ama la loro casa di campagna e il silenzio dei boschi , silenzio che per Baum è solo fonte di ansia e presagi di morte.
In città, tra taxi e sirene, si sente vivo; in campagna, teme che ogni rumore notturno sia l’inizio di una tragedia. Il rapporto con Connie è minato da sospetti continui. Baum è terrorizzato dall’idea che lei lo tradisca con suo fratello Josh, un imprenditore immobiliare più giovane, affascinante e “meno ebreo di lui”, come lo descrive con invidia e ironia.
Un uomo in lotta con se stesso
Mentre tutto attorno a lui si sgretola, Asher comincia a parlare da solo. All’inizio è una forma di sfogo, ma presto diventa un vero e proprio dialogo interiore a due voci, una buona e una cattiva, in cui discute, si insulta e si consola.
È una trovata narrativa che ricorda i monologhi più celebri dei film di Allen, ma qui assume un tono più cupo e surreale: è come se Baum fosse prigioniero della propria mente, un intellettuale che non riesce più a comunicare con nessuno, né con la moglie, né con gli amici, né con la realtà stessa.
La gelosia, il figlio e il “segreto”
La gelosia di Baum esplode quando scopre il legame morboso tra Connie e suo figlio Thane, avuto da un precedente matrimonio. Thane è giovane, bello, arrogante e di successo: il suo primo romanzo è un bestseller candidato al National Book Award, mentre Baum non riesce più a pubblicare nulla.
La rivalità paterna e artistica si intreccia con il sospetto che Connie riversi sul figlio un affetto eccessivo, quasi disturbante, un “Complesso di Giocasta”, lo chiama Baum, con il suo linguaggio ironico e psicoanalitico, ovvero il desiderio sessuale incestuoso che una madre nutre verso il proprio figlio.
Quando poi Thane si fidanza con una ragazza che ricorda in modo inquietante la seconda moglie di Asher, il fragile equilibrio mentale del protagonista crolla del tutto. In questa spirale di paranoia e gelosia, Baum scopre un “segreto esplosivo” che potrebbe distruggere per sempre il suo matrimonio, un tradimento, reale o immaginato, che lo costringe a scegliere: rivelare la verità e affrontare il caos, oppure tacere e convivere con il dubbio.
Lo scandalo e la cancellazione
Come se non bastasse, Baum si trova coinvolto in un piccolo scandalo che mette a rischio la sua reputazione pubblica. Durante un’intervista, compie un gesto ambiguo nei confronti di una giovane giornalista asiatica, forse un tentativo maldestro di flirt, forse un incidente.
Il caso finisce sui giornali e Baum viene “cancellato” dai circoli culturali, travolto dalla stessa ondata di moralismo che il romanzo ironizza con acutezza. Il suo declino professionale diventa così anche un commento sul mondo post-#MeToo, in cui Allen riflette (con ironia e autoironia) sul confine labile tra errore, colpa e giudizio pubblico.
La caduta e la risata
Nella parte finale del romanzo, Baum vaga per le strade di Manhattan parlando da solo, come un moderno Amleto newyorkese. Riflette sull’arte, sull’amore, sulla morte, sul senso della vita — e sul fatto che nessuna di queste domande abbia mai avuto una risposta.
La conclusione, comica e amara, non offre una catarsi ma un sorriso disincantato. Baum rimane intrappolato nella sua stessa mente, ma la sua lucidità nevrotica diventa la sua unica forma di libertà.
La recensione del New York Times a Che succede a Baum?
Il New York Times ha offerto una recensione del libro di Woody Allen firmata da Alexandra Jacobs con il titolo Woody Allen’s First Novel: Funny-ish, but Very Familiar (“Il primo romanzo di Woody Allen: divertente, ma molto familiare”).
Nel suo articolo la giornalista accoglie What’s With Baum? con un tono insieme ironico e distaccato, proprio come il romanzo che analizza. Il titolo della recensione, “Funny-ish, but Very Familiar”, riassume perfettamente la posizione della giornalista riguardo al romanzo. Che succede a Baum? non è un brutto libro, ma un déjà vu letterario.
Jacobs riconosce a Woody Allen la sua maestria comica e la sua penna brillante, ma osserva che ogni pagina sembra risuonare di personaggi, tic e nevrosi già noti. Asher Baum, protagonista del romanzo, è il tipico alter ego alleniano già visto in molti dei suoi film: ebreo newyorkese, intelligente, geloso, ansioso, ossessionato dalla morte, dal sesso e dal fallimento.
Il lettore, nota la critica, “rischia già di sapere tutto”, ma d’altro canto, la forza di Woody Allen è quello per cui si è già fatto apprezzare nei suoi film, riuscendo quindi a strappare qualche risata amara. In poche parole, non c’è niente di nuovo, se non il fatto che Woody Allen merita sempre.
La giornalista coglie l’ironia di Allen quando descrive il mondo editoriale contemporaneo, dove gli editori chiedono più “schmaltz” (sentimentalismo) e meno “wisdom” (riflessione). È, scrive Jacobs, una caricatura sottile della cultura americana. Una società che vuole emozioni facili e diffida del pensiero profondo.
Uno dei passaggi più discussi della recensione riguarda la sottotrama “scandalo” del romanzo. Baum viene “cancellato” dopo un episodio ambiguo con una giovane giornalista.
Jacobs nota come Allen affronti il tema con ironia, alternando autoironia e difesa implicita. L’episodio sembra un riflesso diretto delle polemiche che da anni accompagnano il regista, e la critica lo riconosce apertamente.
Allen dedica il libro alla moglie Soon-Yi Previn, con la frase giocosa “Where did you learn that?” (“Dove hai imparato questo?”, un gesto che Jacobs definisce “una smorfia da Groucho Marx più che una dichiarazione d’amore”.
Il giudizio complessivo è tiepido ma non ostile. “Non è terribile. È… ok. Qualche risata sorda in un weekend ventoso.”
Alexandra Jacobs descrive la lettura del romanzo con un’immagine memorabile, “È come fare una piacevole passeggiata a Washington Square Park e finire per pestare la cacca di un cane.”
Per meglio dire il libro diverte, intrattiene, ma lascia una sensazione di incompiutezza e per certi versi di già visto. Allen, scrive la giornalista, non sorprende, ma “anche messo all’angolo dall’industria dell’intrattenimento, riesce ancora a sfornare un piccolo pezzo di prosa autunnale, come altri giocherebbero a pickleball”.
L’attenzione dei media internazionali
L’uscita di Che succede a Baum? ha riacceso l’interesse mondiale per Woody Allen, ma anche diviso la critica. Da una parte chi ha visto nel romanzo la naturale estensione del suo universo creativo, dall’altra chi lo considera un esercizio di stile, elegante ma prevedibile.
Diversi critici europei, tra cui quelli di The Telegraph e The Standard, hanno definito il libro “un film di Woody Allen da leggere”. Ne apprezzano la scrittura brillante, il ritmo dei dialoghi, la capacità di fondere ironia e malinconia.
Woody Allen, dicono, riesce ancora a tratteggiare personaggi umanissimi, immersi in contraddizioni che diventano specchio di una società smarrita e iper-analitica.
C’è chi parla di “romanzo confessionale travestito da commedia”, dove l’autore affronta i temi della vecchiaia, della cancellazione pubblica e della crisi di senso con una leggerezza disarmante, che solo un artista pienamente consapevole dei propri limiti può permettersi.
The Guardian, nella recensione di Peter Bradshaw, sottolinea che Baum “si legge come una confessione mascherata, ma più coerente di molti film recenti di Allen”, riconoscendo nella prosa un ritorno alla chiarezza e all’autoironia dei tempi migliori.
Nel complesso, la critica internazionale converge su un punto: Che succede a Baum? è un romanzo profondamente alleniano, che non pretende di reinventare l’autore ma di prolungarne la voce. È un libro che diverte e conforta chi ama la sua scrittura, ma che lascia indifferenti coloro che cercano novità o coraggio formale.
Più che un debutto, sembra un epilogo coerente. Un piccolo atto di fedeltà a se stesso, dove Woody Allen trasforma ancora una volta le sue ossessioni, la paura, la gelosia, l’insicurezza, in materia di ironia e sopravvivenza.
Il giudizio dei lettori su Goodreads
Sulla piattaforma internazionale Goodreads, dove milioni di lettori condividono valutazioni e recensioni, What’s With Baum? ha ottenuto un’accoglienza complessivamente positiva, soprattutto tra gli ammiratori storici di Woody Allen.
La valutazione media si attesta intorno a 3,87 stelle su 5, basata su circa 150 voti e 30 recensioni, un numero in costante aumento.
Circa il 65% dei lettori assegna al romanzo un punteggio alto, 4 o 5 stelle, segno che, nonostante la prevedibilità segnalata da parte della critica, il pubblico riconosce nel libro il piacere di ritrovare una voce amata e familiare.
Dalle recensioni emergono due linee di lettura principali: una di entusiasmo, una di delusione.
Cosa amano i lettori
I lettori che hanno amato Baum parlano di un ritorno alle origini. Celebrano l’inconfondibile stile di Allen, i dialoghi arguti, l’umorismo nevrotico e quella miscela di malinconia e intelligenza che da sempre caratterizza i suoi personaggi.
Molti descrivono l’esperienza di lettura come “vedere un film di Woody Allen, ma sulla pagina”: un romanzo capace di evocare su carta le atmosfere di Io e Annie, Manhattan o Harry a pezzi.
Il ritmo è definito scorrevole, brillante, a tratti irresistibilmente comico, con una leggerezza che lo rende una lettura piacevole e accessibile anche per chi non conosce a fondo il suo cinema.
Cosa convince meno
La principale critica riguarda la mancanza di novità. Molti lettori, pur apprezzando il tono e lo humor, rimproverano ad Allen di non essersi spinto oltre i confini del suo immaginario.
Alcuni parlano di una trama “quasi trasparente”, poco più di un pretesto narrativo per i monologhi interiori di Baum, mentre altri osservano che la prosa, sebbene efficace, ricorda più una sceneggiatura che un vero romanzo.
Il risultato, per i detrattori, è una lettura piacevole ma non memorabile, un “Allen minore” che diverte ma non sorprende.
In sintesi
Su Goodreads, Che succede a Baum? divide ma non delude. Chi cerca il Woody Allen più classico, ironico, ipocondriaco, brillante, lo trova integro in ogni pagina. Chi sperava in una svolta letteraria o in un rinnovamento tematico, invece, resta a metà strada.
Ma forse è proprio questo il punto. Baum non nasce per innovare, bensì per conservare una voce unica, quella di un autore che trasforma da sessant’anni la fragilità in arte e la nevrosi in sorriso.