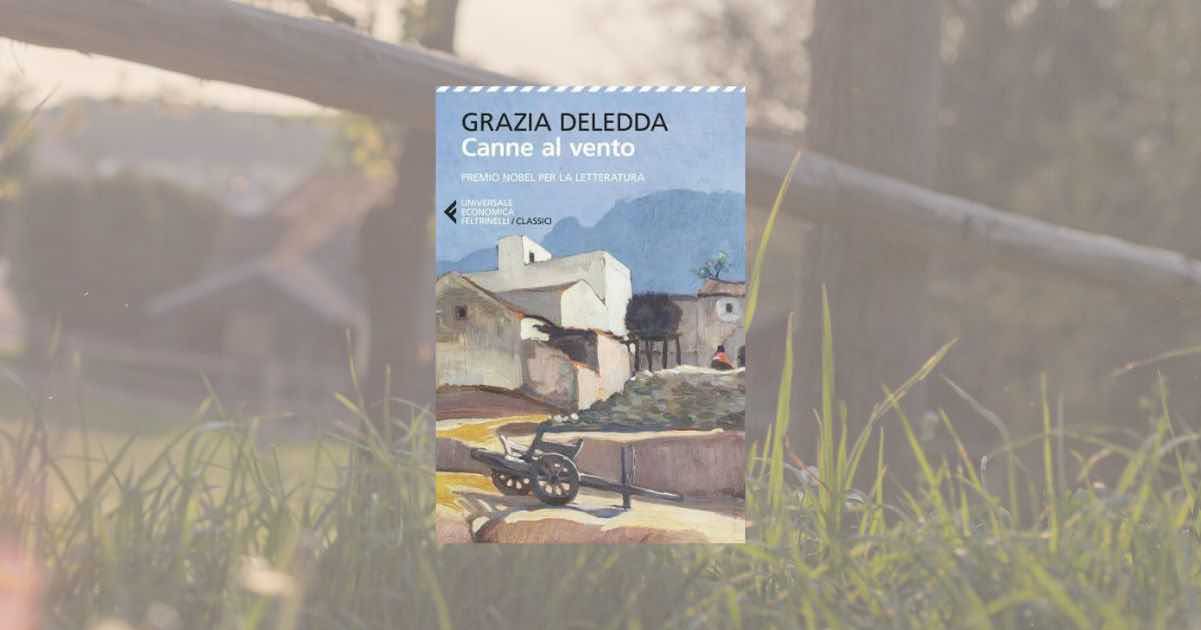Pubblicato nei primi anni del Novecento, “Canne al vento” à l’opera che Grazia Deledda – premio Nobel per la Letteratura nel 1926 – ci regala come come classico dall’ambientazione sarda e la profondità fragile dell’essere umano.
Possiamo cedere sotto la forza degli eventi, ma poi rialzarci
È una riflessione universale sulla colpa, sulla redenzione e sulla capacità degli uomini e delle donne di piegarsi alle avversità senza però spezzarsi: un vero e proprio romanzo sulla resilienza; la metafora del titolo, che paragona gli esseri umani alle canne mosse dal vento, racchiude infatti tutta la filosofia del libro.
Chi sono le canne al vento?
Nel piccolo borgo di Galte, trasfigurazione letteraria di un paese reale della Baronia, vivono le sorelle Pintor: Noemi, Ester e Ruth, discendenti di una famiglia un tempo potente e ormai decaduta.
Con loro c’è Efix, il servo fedele che porta sulle spalle un segreto capace di condizionare le vite di tutti; anni prima, per proteggere la più giovane delle sorelle, Lia, fuggita contro il volere del padre don Zame, ha compiuto un atto che lo tormenta…
L’arrivo improvviso di Giacinto, figlio di Lia, riapre ferite mai chiuse e mette in moto una catena di speranze e rancori.
Tutt’attorno a loro s’intrecciano i temi che hanno reso immortale il romanzo: il peso del destino, la colpa che chiede riparazione, il patriarcato che giudica e isola, la superstizione che convive con la religione popolare.
Grazia Deledda costruisce una trama in cui ogni gesto quotidiano – dalla coltivazione dei campi al custodire una casa, fino ad affrontare i pettegolezzi del paese – diventa simbolo di una lotta più grande: quella per conservare dignità anche quando la vita sembra negarla.
I personaggi del borgo
Ogni personaggio rappresenta una sfaccettatura dell’esistenza: Noemi incarna l’orgoglio e la lucidità, perché rifiuta i compromessi con un mondo che non le ha dato ciò che sperava; Ester, dal carattere più mite, porta in sé la pietà domestica; Ruth, invece, lascia filtrare il rimpianto e la malinconia.
E Lia, infine, pur restando assente nella scena, viene delineata da Deledda come una presenza costante e ribelle che ha osato cercare un destino diverso da quello degli altri.
Tra tutti, però, si risalta Efix, figura commovente di colpevole e devoto, di servo e custode, che vive in uno stato di espiazione permanente. La sua dedizione non è solo affetto: è una penitenza quotidiana, una forma di amore e di resistenza che trasforma il lavoro nei campi e i silenzi della casa in gesti di redenzione.
La colpa è altri temi ricorrenti
Come in “Canne al vento”, la colpa è un tema fondamentale anche in “Cenere” (1904): a tormentarsi di fronte all’implacabilità del destino è Anania, figlio di una donna ripudiata, che si porta dietro uno stigma sociale e interiore – in questo vicino, per certi tratti, al Giacinto del nostro romanzo.
Ne “L’edera” (1908), invece, il conflitto tra religione e passioni proibite richiama la tensione morale che segna Efix: una lotta silenziosa tra ciò che si deve e ciò che si desidera.
Dalla carta alla TV
Il fascino di “Canne al vento” ha superato le pagine scritte ed è approdato sullo schermo. Nel 1958 la Rai ne realizzò uno sceneggiato televisivo in quattro puntate, diretto da Mario Landi, con attori del calibro di Dolores del Río e Lea Padovani.
Un adattamento che portò la Sardegna arcaica e simbolica di Deledda al grande pubblico, fissando per la prima volta le immagini di Galte e delle sorelle Pintor nella memoria collettiva.
Quell’esperienza segnò anche un momento importante per la televisione italiana nascente: portare un classico letterario a un pubblico popolare, trasformando le atmosfere silenziose e drammatiche del romanzo in immagini potenti.
Tra realismo e simbolismo
Uno degli aspetti più affascinanti di “Canne al vento” è la lingua di Grazia Deledda, che intreccia il realismo descrittivo – fatto di paesaggi, usanze, dialoghi concreti – con un forte simbolismo morale e spirituale.
La Sardegna, con i suoi campi, i suoi silenzi e le sue superstizioni, si presta bene al gioco e diventa specchio delle anime dei personaggi, che si piegano e si rialzano.
Lo stile di Deledda, pur ancorato alla sua terra, riesce a toccare corde universali, evocando la fragilità e la forza dell’essere umano, proprio come accade in altri suoi romanzi centrati sul peso del destino – “Cenere”, “L’edera”.
È questo equilibrio tra concretezza e allegoria che ha fatto di “Canne al vento” un classico tanto amato.