Babbo Natale, la vera storia
Baum racconta la storia di Babbo Natale. Un classico del 1902, la biografia di Santa Claus di cui nessuno parla: “Vita e avventure di Babbo Natale”.
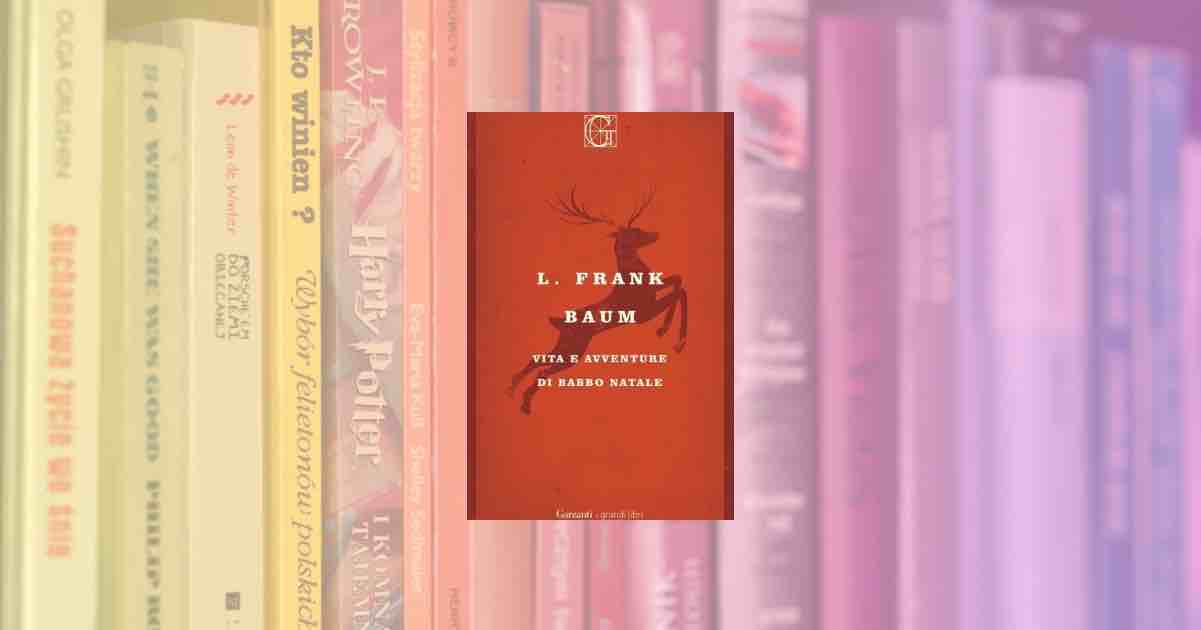
Nel 1902 L. Frank Baum fa qualcosa di molto più moderno del suo tempo: invece di raccontare una storia di Natale, prova a raccontare la storia di Babbo Natale; e in questa non compaiono fantasmi, non ci sono apparizioni né simboli come in quello di Dickens, ma una biografia. “Vita e avventure di Babbo Natale” prende Claus, il nostro Babbo Natale, e lo costringe a diventare persona, con un’infanzia trascorsa in un luogo e un’etica propria.
Un mito che chiede e ottiene una biografia
Nessuno ha davvero visto Santa Claus. È un mito, una tradizione che, a forza di ripetersi, diventa rumore di fondo. A Natale si accendono le luci, si appende la calza, si addobba l’albero, si pronuncia il nome che tutti conoscono… e poi? È così che nasce la curiosità ed è così che Baum, creatore di Oz, si decide a mettere le mani sulla meccanica del mito.
Prende l’immagine universale di Babbo Natale e si chiede cosa ci sia sotto, che infanzia deve avere qualcuno che, ogni anno, torna con la stessa passione e voglia di rendere felici i bambini. Che cosa deve aver visto per trasformare il dono in un’abitudine? Soprattutto, domanda che ci siamo posti tutti da bambini, come si passa dal camino?
E così inizia a raccontare: Claus non nasce in una città, nasce in una foresta…
Crescere fuori dal mondo per capire il mondo
Claus viene trovato e cresciuto nella Foresta di Burzee, adottato dalla wood-nymph Necile, circondato da esseri immortali. È un dettaglio fiabesco solo in apparenza, importantissimo poi. Burzee è il luogo in cui il tempo non esiste, e proprio per questo il tempo umano (crescere, invecchiare) appare come una cosa che non riguarda i suoi abitanti.
Questa impostazione sposta subito il tono. Vita e avventure di Babbo Natale non è una favola “da atmosfera”, ma una costruzione morale. Claus, prima ancora di portare doni, deve diventare qualcuno che sa guardare il mondo senza anestesia; e quando lo guarda davvero, non gli basta più restare al riparo.
La verità scomoda: il bene non è un carattere, una scelta ripetuta
La parte interessante del libro è che non romanticizza la bontà. Non la tratta come un tratto naturale, né come una qualità che “si possiede”. La tratta come una decisione che ritorna, ogni volta, contro le condizioni. Claus comincia a fare regali perché vede bambini che non hanno niente e capisce che l’ingiustizia non si corregge con la commozione: si corregge con un gesto che si ripete, finché diventa affidabile.
E qui Baum fa una cosa quasi spietata: toglie al bene la sua aura, e lo lascia nudo nella pratica. Fare del bene significa lavorare. Intagliare, preparare, organizzare, camminare. Non è l’impennata del momento, è l’ostinazione di qualcuno che, vedendo ciò che manca, decide di non voltarsi dall’altra parte e poi decide di farlo ancora.
Ecco perché la storia non si regge sul “sentimento natalizio”, ma su un principio adulto: un gesto vale davvero solo quando diventa continuità.
La logistica del dono
Baum non si accontenta di dire che Claus porta regali, ma si diverte a spiegare come lo fa: segue Babbo Natale nei capitoli che sembrano rispondere alle domande silenziose del mito (perché le calze appese al camino, l’albero, il viaggio durante la notte) e allo stesso modo affronta i problemi pratici ai quali si trova a far fronte (le case sono chiuse, il tempo che è poco, il mondo terribilmente vasto e il numero infinito di bambini).
Così sopraggiunge anche la risposta del camino, un passaggio accesso che appartiene già alla casa, il punto in cui entra il calore.
In questa parte il libro Baum fa una cosa precisa: trasforma il folclore in racconto causale; e quando una tradizione ha una causa diventa struttura.
Quando il bene diventa bersaglio
A un certo punto la storia si scurisce. Claus non è “simpatico” a tutti. Baum introduce una resistenza organizzata, un conflitto tra forze che vogliono interrompere quella continuità. È una scelta narrativa molto rivelatrice: il bene, quando diventa stabile, crea attrito. Non perché il mondo sia “cattivo” in modo astratto, ma perché un rito che rende felici i bambini è anche un rito che rende le persone meno governabili dalla paura e dalla miseria.
Baum lo mette in scena apertamente, fino a una “grande battaglia” tra bene e male che non è lì per fare spettacolo: è lì per dire che la gentilezza, quando diventa metodo, smette di essere innocua.
Baum dopo Oz: la stessa ossessione per ciò che regge
Se Oz è la storia di un viaggio che costringe i personaggi a scoprire che cosa hanno già dentro, Babbo Natale è la storia di un gesto che costringe un personaggio a scoprire che cosa deve diventare. In entrambi i casi, Baum non si limita a inventare: costruisce un dispositivo.
È questo che rende Vita e avventure di Babbo Natale più interessante di un semplice racconto natalizio: la sua ambizione di “tenuta”. Baum non vuole solo emozionare, vuole far funzionare. Vuole che il mito regga agli urti, alle domande, persino alle obiezioni. E quando un autore scrive così, si capisce perché quel mito poi trovi nuove vite: anche fuori dai libri, anche in televisione, come dimostra l’adattamento animato Rankin/Bass del 1985, esplicitamente basato sul romanzo del 1902.
Essere buoni
Alla fine, questo libro non chiede di credere a Babbo Natale, ma forse di cedere a un qualcosa di più scomodo: la bontà, una caratteristica diversa dalla più semplicistica qualità d’animo a cui siamo abituati a credere sin dall’infanzia. Baum suggerisce che il bene è una scelta che si ripete finché diventa riconoscibile, dunque non coincide solo con l’intenzione, ma con la continuità.
Non basta “essere buoni” una volta, non basta dire “a Natale siamo tutti più buoni” perché l’atmosfera aiuta.
Quante volte si è disposti a tornare, a rifare un gesto giusto anche quando nessuno lo vede, anche quando non conviene, anche quando sarebbe più facile smettere?