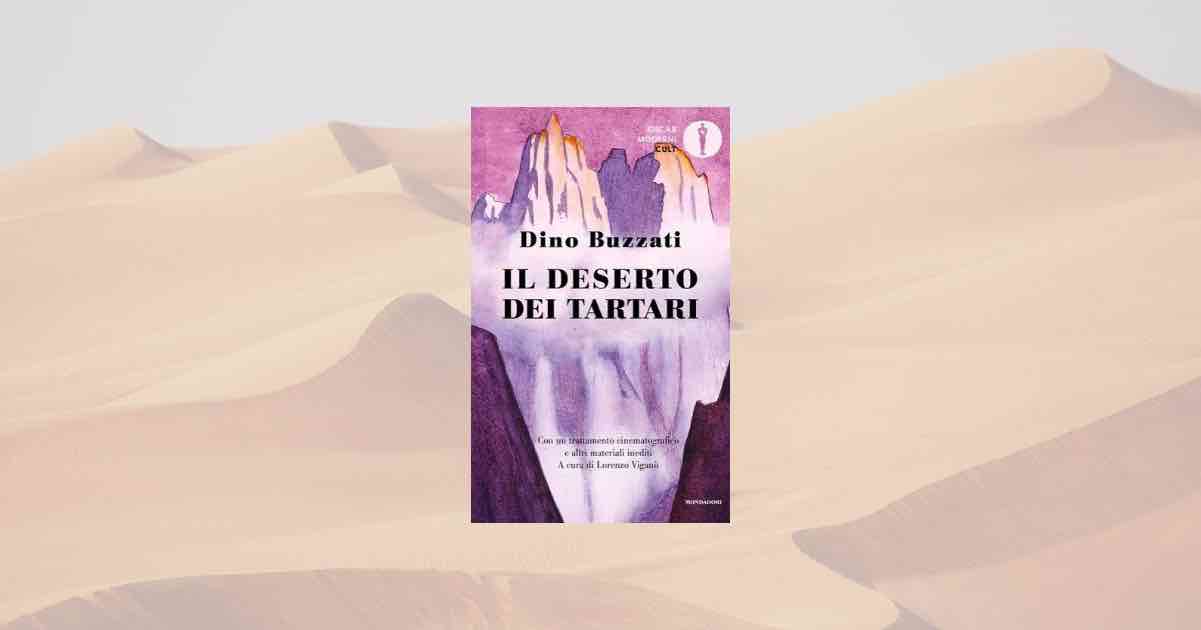“Il Deserto dei Tartari” di Dino Buzzati è un classico dell’esistenzialismo novecentesco, un romanzo che continua a interrogarci sul rapporto che intercorre tra desiderio e tempo, ambizione e rinuncia.
La sua forza non risiede in un intreccio ricco di eventi — al contrario, di eventi ce ne sono davvero pochi —, ma nell’intuizione semplice e terribile che lo attraversa: si può consumare un’intera esistenza aspettando il momento “giusto” — e scoprire che quel momento non arriva mai.
Drogo e la Fortezza Bastiani
Giovanni Drogo, giovane ufficiale, riceve come prima destinazione la remota Fortezza Bastiani, avamposto di un impero senza coordinate certe, affacciato su un deserto da cui — si narra — potrebbero arrivare i Tartari.
All’inizio il protagonista sogna di farsi trasferire: la guarnigione è lontana da tutto, il paesaggio è immobile, il tempo pare stagnare; ma l’ipotesi di un pericolo (o di una gloria possibile) lo trattiene. Così, di rinuncia in rinuncia, l’attesa diventa scelta, poi abitudine, infine destino.
La Fortezza come non-luogo
del tempo umano Buzzati rifiuta riferimenti storici e geografici puntuali: l’impero è immaginario, la topografia indeterminata. Quel vuoto cartografico non è un vezzo fantastico; è la condizione perché la Fortezza Bastiani diventi un non-luogo metafisico, uno spazio in cui il calendario smette di contare e i giorni si somigliano come pietre.
Da quassù il mondo civile è lontano; ciò che resta è un’organizzazione del tempo fatta di turni, di piccoli riti militari, di segnali scrutati all’orizzonte. Il deserto non è soltanto sabbia: è la figura della sospensione, come le piazze rappresentate Giorgio de Chirico, o il deserto di Salvador Dalí.
Attesa, procrastinazione, “occasioni mancate”
Una lettura contemporanea del romanzo porta al centro due domande che toccano chiunque: quanto siamo disposti a sacrificare per un sogno, e quante decisioni rimandiamo contando sul fatto che “ci sarà tempo”?
Drogo incarna la logica del rinvio: quando si apre una via d’uscita, egli la posticipa di poco — un permesso da chiedere, un comandante da attendere, un segnale da verificare — e quel “poco” si trasforma in anni.
Buzzati coglie con ferocia quasi clinica il meccanismo della procrastinazione esistenziale: non l’inerzia colpevole, ma la dedizione a un’idea che legittima ogni rinuncia.
Il sacrificio volontario: dalla dedizione all’auto-esilio
Il romanzo non riduce Drogo a vittima. A un certo punto la Fortezza non lo trattiene più: è lui a sceglierla di nuovo, a trasformare la disciplina in vocazione. Qui sta la nota più amara del libro: la rinuncia non è imposta dall’alto; è un’auto-coercizione nutrita di speranza.
L’orizzonte mitico dei Tartari — evento raro, forse mai accaduto — funge da giustificazione morale: vale la pena sopportare la lontananza dagli affetti, l’occasione sentimentale perduta, la carriera che altrove sarebbe fiorita, se tutto questo un giorno potesse avere un Senso.
Chi sono “i Tartari”?
Buzzati depura i Tartari da ogni storicismo. Sono ciò che attendiamo: l’occasione professionale, la prova eroica, l’amore salvifico, la pagina che ci consacra. Dissolvendo il referente concreto, l’autore universalizza il meccanismo d’attesa: i Tartari diventano un oggetto mentale, una miraggio ordinatore. La narrazione dimostra quanto la promessa di un riconoscimento futuro possa bastare a riempire il presente — e a svuotarlo.
Parentele e antitesi: Kafka, Camus, la “frontiera” italiana
È naturale avvicinare “Il Deserto dei Tartari” al mondo kafkiano: come nel “Castello”, anche qui l’istituzione è opaca e la finalità resta indecifrabile. Con Camus condivide la percezione dell’assurdo e l’ostinazione etica dell’individuo; ma Buzzati non volge mai in saggio filosofico: rimane narratore, fedele alla favola seria e alla densità delle immagini. In chiave italiana, il libro dialoga sotterraneamente con certa epica di confine (da De Roberto a Malaparte), ma la scarta con la sua rinuncia programmatica alla cronaca.
Una politica dell’animo (e della Storia)
L’allegoria non va forzata, ma il romanzo ha spesso parlato anche alla Storia: epoche e generazioni che presidiano confini in attesa di “invasioni” mai giunte; organizzazioni che perpetuano sé stesse per l’inerzia della struttura; classi dirigenti che giustificano la stagnazione in nome di un pericolo imminente. In controluce, tuttavia, la lezione più tagliente è intimista: l’ordine esterno replica l’ordine interiore. Ci si chiude in una fortezza fuori perché già se ne abita una dentro.
Ricezione, adattamenti, eredità
Sin dall’uscita nel 1940, il libro ha avuto una fortuna internazionale costante: Valerio Zurlini ne trasse nel 1976 un film di culto, con Jacques Perrin nei panni di Drogo e un cast europeo (Max von Sydow, Vittorio Gassman, Philippe Noiret). Il cinema colse con sobrietà il tempo minerale della Fortezza e l’ambiguità dell’attesa.
Nella critica letteraria italiana il romanzo è diventato un archetipo, richiamato ogni volta che si parla di carriere “sorvegliate” dall’idea di una prova decisiva o di istituzioni che si auto-alimentano; non a caso “la fortezza Bastiani” è entrata nel linguaggio comune come simbolo di un presidio immobile.
Drogo, la Fortezza e le lezioni di Buzzati
Drogo vive come se da un momento all’altro dovesse arrivare “qualcuno” con cui fare i conti — i Tartari, l’occasione, la prova decisiva. Nell’attesa, però, consuma un lutto silenzioso: quello per le strade non imboccate, per i legami lasciati in sospeso, per i futuri che si chiudono senza clamore. È il dolore di ciò che avrebbe potuto essere e non è stato a causa della sua ossessione, l’idea fissa della gloria che entra in attrito con la responsabilità verso se stesso e verso gli affetti.
Buzzati mostra come il desiderio, se non sorvegliato, possa scivolare in una forma di narcisismo involontario, come Drogo si convince che il sacrificio sia necessario: un comportamento che potrebbe essere comune anche a chiunque, anche a noi. In questo senso si mette la “missione” al centro, si consuma — pur non volendo — chi si ha accanto.
E ancora c’è la cura reciproca mancata. Alla Fortezza ci si copre le spalle, si rispettano i turni, si tengono i bastioni: tutto funziona, ma quasi nessuno si prende davvero cura dell’altro. È la comunità dell’adempimento, non della relazione. Buzzati suggerisce che un ordine fondato solo sul dovere non genera senso: produce soltanto invecchiamento — di corpi, di legami, di speranze. In questo sta l’attualità più tagliente del libro.