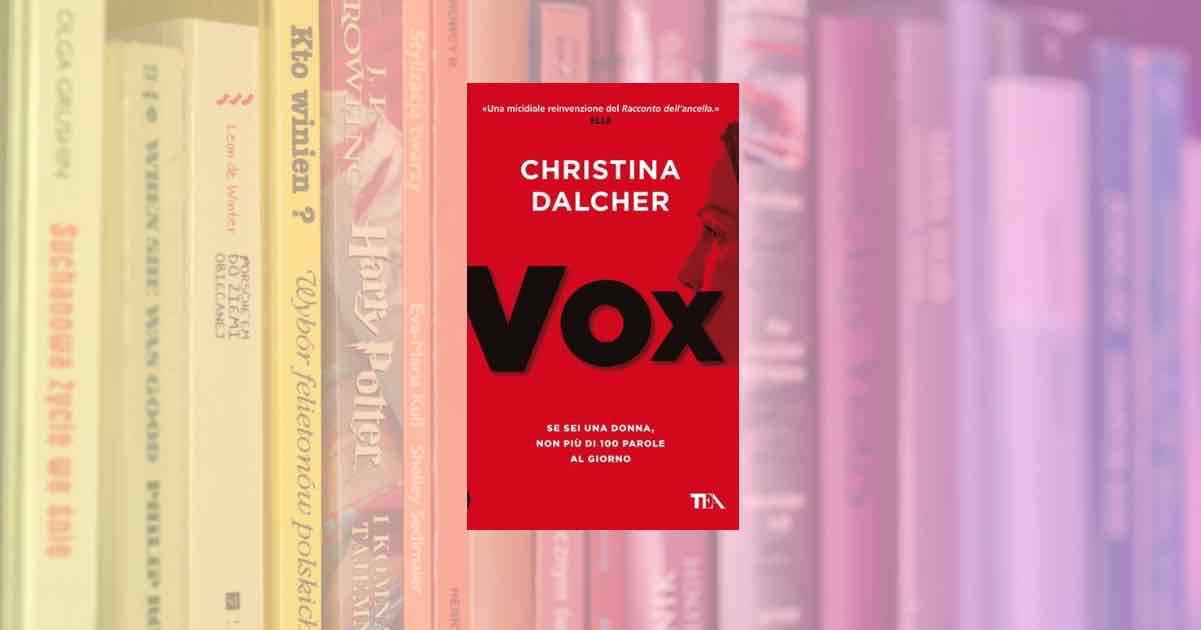Cento parole al giorno: abbastanza per un saluto al mattino, ma non per difendersi, o spiegare cosa accade a un’innocente.
In “Vox” Christina Dalcher trasforma la libertà in un numero che scende di continuo e si resetta giorno dopo giorno su un braccialetto. Pena, una scossa.
Il vero dramma è quando la realtà comincia a somigliare a questa logica. Dall’Afghanistan alle forme più sottili di silenzio imposto, la distopia sembra scivolare via dalla pagina.
Un domani plausibile: “Vox”
“Vox” non inventa un futuro lontano: per questo è un libro tanto speciale. La regressione arriva per gradi, con normalità, e si richiude attorno alle donne finché parlare non diventa un rischio fisico.
L’autrice sceglie una protagonista che non nasce rivoluzionaria, ma che come tutti deve trovare la forza per andare avanti e che proprio per questo funziona. Jean è il tipo di persona che, in qualunque Paese, si sveglia troppo tardi e capisce che il diritto di esistere nello spazio pubblico passa anche da una cosa semplice come l’ascolto.
Il patriarcato non spegne solo i corpi
La cosa più inquietante di “Vox” non è il braccialetto in sé, né la soglia delle cento parole, bensì l’idea che la libertà possa essere ridotta e che nessuno se ne accorga, riducendo il tutto a un’abitudine.
Ecco perché Dalcher si focalizza sulla voce, sul parlare, e fa in modo che la sorveglianza vi sia concentrata.
“Sarebbe una gran bella ragazza, se solo non aprisse bocca”
Il romanzo fa un grande effetto proprio perché questo meccanismo non nasce dal nulla e perché il patriarcato, nella sua forma più esplicita o più “educata”, è da sempre un sistema che decide chi può occupare lo spazio e con quali strumenti: presenza fisica, sguardo, parola, credibilità.
Perché la voce non è solo un suono, è un diritto: diritto di nominare la violenza, l’ingiustizia, la paura e perfino il desiderio; ma quando una società comincia a punire (anche solo simbolicamente) le donne che nominano qualcosa, il passaggio successivo è quasi automatico. Non serve censurarle sempre, basta convincerle che parlare “costa”.
In “Vox” quel costo è immediato — una scossa. Nella realtà spesso è più subdolo: la reputazione, l’isolamento, le ritorsioni sul lavoro e la perdita di sicurezza.
È così che la distopia diventa “vicina”. Molte donne conoscono già la fatica di misurare le frasi, di scegliere il tono “giusto” per evitare discussioni. È un addestramento quotidiano che non sempre si vede, ma che cambia tutta la loro esistenza: un’autocensura che fanno per poter vivere “normalmente” sin dall’infanzia, che hanno imparato per osmosi dalle loro madri e nonne. Non perché manchino di un’opinione, piuttosto perché manca la certezza che nell’esprimerla ad alta voce sia possibile continuare a vivere senza pagare un prezzo sproporzionato.
Quando il silenzio diventa la norma
La voce cancellata dallo spazio pubblico
E poi ci sono i casi in cui la metafora smette proprio di essere metafora. In Afghanistan, dopo l’adozione della cosiddetta legge sulla “propagazione della virtù e prevenzione del vizio” (agosto 2024), istituzioni e osservatori internazionali hanno denunciato restrizioni che mirano a impedire che la voce delle donne venga udita in pubblico, insieme a ulteriori limiti su abbigliamento e presenza nello spazio pubblico.
Ed è qui che “Vox” diventa una realtà più che vicina anche per chi vive altrove, ricordandoci che la voce è il primo bersaglio, quando un potere vuole riscrivere l’ordine sociale.
Non serve più bruciare libri, non negli anni 2000, per rendere impronunciabili le parole che li difendono.
Da Gilead al braccialetto: due modi diversi di costruire la stessa paura
Se “Vox” viene accostato così spesso a Margaret Atwood, non è solo per un motivo “di superficie” (una società che restringe i diritti delle donne). È perché “Il racconto dell’ancella” ha creato un linguaggio mentale con cui, da quarant’anni, riconosciamo la distopia patriarcale: la regressione che arriva come morale pubblica, la legge che entra nel privato, l’idea che il corpo e la voce femminili siano “territori” amministrabili.
E quando Dalcher immagina un’America dove alle donne vengono concessi 100 vocaboli al giorno e ogni parola in più si paga fisicamente, sta scrivendo dentro quella scia — tanto che diverse recensioni parlano esplicitamente di un “effetto Ancella”, dove perfino le mogli non avevano la possibilità di risposta e ribellione.
Atwood, però, non ha mai inteso il suo lavoro come “fantascienza pura”, come Dalcher: preferisce parlare di speculative fiction, cioè una finzione che spinge in avanti ciò che è già possibile nel reale, per precedenti storici o per tecnologie già esistenti. In interviste e interventi pubblici ha insistito sul principio che nel romanzo non abbia inserito nulla che non fosse già accaduto “da qualche parte, in qualche momento” — una regola etica, oltre che narrativa, che rende Gilead inquietante proprio perché non ha bisogno di astronavi per funzionare.
“Vox” adotta una strategia quasi opposta ma complementare. Atwood costruisce la paura per stratificazione: istituzioni, rituali, lessico di Stato, riscrittura dei ruoli, e soprattutto una narratrice che ci accompagna. Dalcher, invece, lavora con un’arma da narrativa contemporanea: un high concept immediato, misurabile, virale. Il braccialetto e il contatore sono l’oggetto-simbolo che resta in testa e che costringe a fare il calcolo se stessi (“quante parole uso al giorno?”).
È la stessa logica che spinge molta critica a leggere “Vox” come un libro potentissimo in avvio, quasi fisico, perché ti fa sentire sulla pelle la contrazione dello spazio; e non a caso c’è chi ha scritto che le prime pagine danno una tensione muscolare simile a quella provata leggendo Atwood per la prima volta.
Le parole
“Vox” ci allena a capire quando un diritto viene trasformato in concessione, quando un’esistenza viene rimpicciolita fino a diventare “accettabile”, quando la parola viene trattata come un eccesso da punire. È un distopico, ma anche un libro che potremmo definire contempooraneo, un libro che scorre, ma che, soprattutto, costringe alla riflessione.