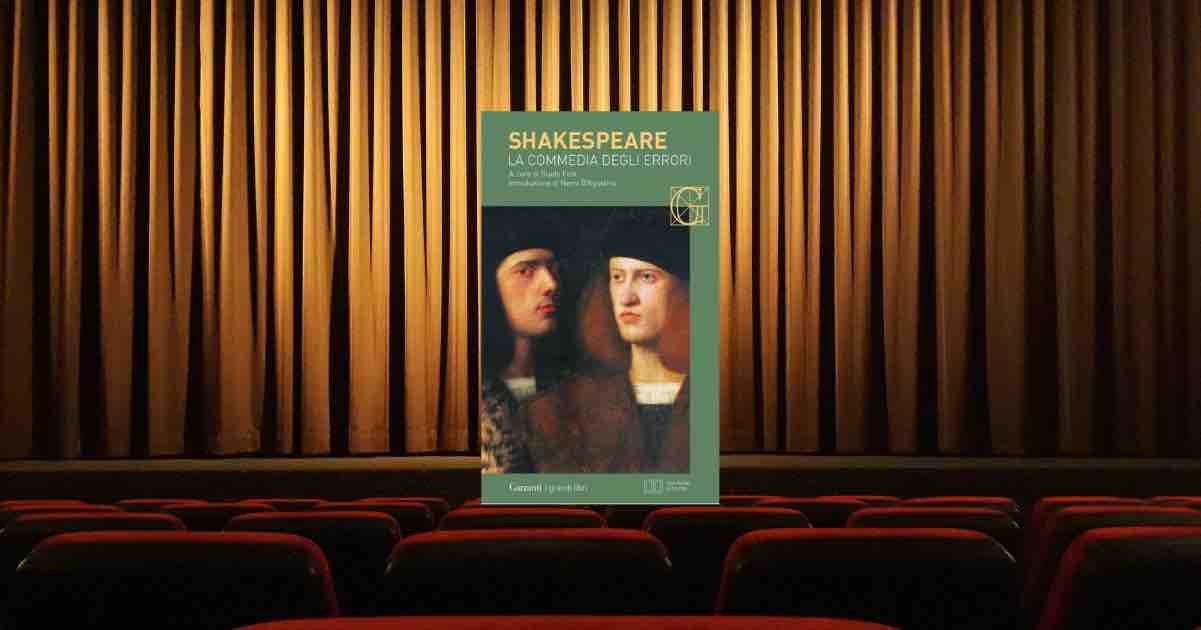Tra tutti i testi di Shakespeare, “La commedia degli errori” è quello che più somiglia a una giostra impazzita: porte che sbattono, personaggi che entrano ed escono trafelati, identità scambiate, coniugi gelosi, mercanti disperati. È anche una delle sue prime opere, la più breve e una delle più farsesche, nata come esercizio di virtuosismo comico e diventata, col tempo, un laboratorio sulla nostra idea di identità e appartenenza.
In questo articolo, noi di Libreriamo proviamo a raccontarla come opera teatrale viva, non come semplice titolo di repertorio: di cosa parla, perché è nata, che cosa dice sotto le gag, come è stata accolta nei secoli e dove continua a essere messa in scena oggi.
Di cosa parla “La commedia degli errori”
Il naufragio e i gemelli perduti
La trama – sulla carta – è lineare. In un lontano passato, un mercante di Siracusa, Egeone, ha due gemelli, entrambi chiamati Antifolo; la famiglia acquista un’altra coppia di gemelli come servi, i due Dromio. Durante un viaggio in mare, una tempesta provoca un naufragio: i gemelli vengono separati, metà famiglia finisce a Efeso, l’altra metà a Siracusa. Anni dopo, uno dei figli sopravvissuti, Antifolo di Siracusa, parte con il suo servo Dromio alla ricerca del fratello perduto.
Arrivati a Efeso scoprono però che la città è ostile agli stranieri di Siracusa: chi viene trovato entro i confini rischia la condanna a morte o una pesante multa. Egeone, giunto anche lui a Efeso, viene arrestato e rischia l’esecuzione se entro sera nessuno pagherà il riscatto.
Un giorno di caos a Efeso
Da qui si innesta il meccanismo comico: a Efeso vive infatti Antifolo di Efeso con il suo servo Dromio di Efeso, identici ai loro fratelli senza saperlo. Tutti, in città, conoscono l’Antifolo “locale”: è sposato con Adriana, corteggia una cortigiana, ha debiti e amici.
Quando Antifolo di Siracusa e Dromio di Siracusa mettono piede in città, vengono continuamente scambiati per i loro gemelli:
- Adriana porta a casa l’Antifolo sbagliato, convinta che sia il marito infedele;
- il vero Antifolo di Efeso si ritrova chiuso fuori di casa e comincia a pensare di essere vittima di stregonerie;
- il gioielliere consegna una catenina d’oro alla persona sbagliata;
- creditori, ufficiali, amici e amanti non capiscono più nulla, tra accuse di pazzia, furto e possessione demoniaca.
Il ritmo è quello della farsa slapstick: botte, rincorse, equivoci a catena. Ma sotto il meccanismo perfetto di entrate e uscite si intravede sempre il rischio del disastro: un matrimonio che si sgretola, un innocente che rischia la tortura, un padre condannato.
Il riconoscimento finale
Solo nel finale, nel monastero di Efeso, tutti i fili si riannodano: appare Emilia, moglie di Egeone creduta morta, che ora è badessa del convento; i due Antifolo e i due Dromio si trovano finalmente faccia a faccia; il Duca di Efeso concede la grazia al mercante e la famiglia si ricompone.
In poche ore, una città intera è passata dalla caccia al “pazzo forestiero” alla celebrazione di un ricongiungimento familiare. Un happy ending che, però, lascia il pubblico con una domanda: quanto poco basta perché una comunità perda la testa?
Quando nasce: una delle prime follie del giovane Shakespeare
Gli studiosi considerano “La commedia degli errori” una delle opere più antiche di Shakespeare, scritta probabilmente tra il 1592 e il 1594, più o meno in contemporanea con La bisbetica domata e poco prima di Romeo e Giulietta.
La fonte principale è la commedia latina “Menaechmi” di Plauto, che racconta anch’essa di due gemelli scambiati, a cui Shakespeare aggiunge elementi da un’altra commedia plautina, Amphitruo (il doppio, la confusione fra mariti e amanti, le accuse di infedeltà). Ma la rielaborazione è tutt’altro che scolastica: raddoppia la coppia di gemelli (non solo i padroni, ma anche i servi), sposta l’azione nella città biblica di Efeso e inserisce un prologo quasi romanzesco con il naufragio e il racconto di Egeone al Duca.
La prima stampa del testo arriverà solo nel First Folio del 1623; ma le prime tracce sceniche sono molto più antiche.
La prima pièce: una notte di Natale a Gray’s Inn
La prima rappresentazione documentata risale al 28 dicembre 1594, durante le feste natalizie del collegio legale di Gray’s Inn, una delle antiche “Inns of Court” londinesi. Lo sappiamo grazie a un resoconto dell’epoca, il Gesta Grayorum, che descrive l’allestimento come parte di una serata di intrattenimenti per studenti e giuristi.
Il testo racconta di un evento caotico: sala affollatissima, ospiti scontenti per i posti, gente che se ne va rumorosamente. Una sorta di “commedia degli errori dentro la commedia degli errori”, che annuncia da subito il destino del testo: legato al periodo delle feste, perfetto per serate in cui la serietà delle aule di giustizia lascia spazio alla sospensione delle regole.
Non è un caso che alcuni studiosi abbiano collegato il play alle celebrazioni dell’Innocents’ Day, la festa dei Santi Innocenti, in cui la tradizione permetteva rovesciamenti d’ordine, scherzi, travestimenti: il terreno ideale per un testo che si regge su scambi di persona, caos e provvisorio trionfo del disordine.
Oltre la farsa, una città che ha paura dello straniero
A lungo “La commedia degli errori” è stata considerata quasi solo un esercizio di bravura comica, e in parte lo è: Shakespeare mette alla prova la sua abilità nel gestire entrate, uscite, intrecci di dialoghi e giochi di parole.
Ma c’è di più. Il primo monologo di Egeone non è affatto una scena leggera: un uomo, straniero in città, viene condannato a morte in base a una legge contro i forestieri di Siracusa. Ha un giorno di tempo per trovare il denaro del riscatto; se fallisce, sarà giustiziato.
Dietro l’equivoco farsesco, il pubblico elisabettiano vedeva anche un riflesso del proprio mondo:
- l’Inghilterra degli anni 1590 era attraversata da Paure per i conflitti religiosi e politici sul continente, in particolare la lunga guerra in Francia citata en passant nel testo;
- a Londra cresceva il numero di stranieri – mercanti, artigiani, rifugiati religiosi – spesso percepiti come concorrenti e sospetti.
Efeso, con le sue leggi dure e la diffidenza verso chi arriva dal mare, è una città che ha paura dell’altro. La commedia mostra quanto sia facile scambiare lo straniero per folle, posseduto, criminale, semplicemente perché non rientra nelle categorie note.
Al tempo stesso, Shakespeare sembra divertirsi a “punire” il pregiudizio con la comicità: ogni volta che un personaggio si mostra troppo sicuro di sé – il Duca, i mercanti, il medico-esorcista Pinch – la macchina dell’errore lo smentisce.
Dall’ombra al riscatto critico
Per secoli, “La commedia degli errori” non è tra i testi più celebrati: è troppo breve, troppo farsesca, offre pochi ruoli “monumentali” per gli attori-star del Settecento e Ottocento.
La svolta arriva nel Novecento, quando registi e studiosi cominciano a valorizzarne:
- la precisione del meccanismo teatrale, quasi da vaudeville;
- la capacità di trasformare un impianto plautino in qualcosa di modernissimo;
- il tono sorprendentemente tenero del finale, con i fratelli che si ritrovano e i servi che si riconoscono come alter ego.
Critici come Harold Bloom o Stanley Wells ne hanno sottolineato la “maestria di craft” e la funzione di vero banco di prova del talento comico di Shakespeare.
Come e quanto viene riproposta oggi
Dalla RSC al Globe: un classico del repertorio
Dal punto di vista teatrale, “La commedia degli errori” è oggi un classico molto frequentato. La Royal Shakespeare Company ne ha fatto un cavallo di battaglia, con produzioni che vanno dal 1938 – quando il regista russo Theodor Komisarjevsky la rimette “sulla mappa” – alle versioni più recenti, fino alla celebre messinscena del 2000 con David Tennant nei panni di Antifolo di Siracusa.
Al Globe Theatre di Londra, la regia di Sean Holmes ha riportato la commedia in scena nel 2023 e 2024 con grande successo: le recensioni parlano di uno spettacolo “pieno di energia e invenzioni fisiche”, capace di tenere insieme la risata facile e una sorprendente profondità emotiva, soprattutto nel finale della reunion familiare.
Festival, tournée, accademie
Non si tratta solo di grandi istituzioni:
- il Hudson Valley Shakespeare Festival negli Stati Uniti ha programmato The Comedy of Errors per l’estate 2025 come uno dei titoli di punta della stagione open air;
- la Guildford Shakespeare Company in Inghilterra l’ha inserita in un ambizioso dittico comico insieme a una nuova commedia contemporanea, “A Company of Rascals”, pensata come dialogo-specchio con il testo elisabettiano;
- l’Old Globe di San Diego ha annunciato una nuova produzione per il 2025, presentandola come “commedia di errori, identità smarrite e ritrovate sul molo di un porto brulicante”;
- l’opera compare nei programmi di scuole e accademie come la Guildhall School of Music & Drama di Londra, che la usa come palestra perfetta per giovani attori alle prese con tempi comici, ensemble e fisicità.
Persino le stagioni universitarie americane la scelgono per aprire i cartelloni: il nuovo WestRep Stage del Connecticut ha annunciato The Comedy of Errors per l’autunno 2025, a fianco di titoli contemporanei come American Psycho – The Musical o POTUS, segno di quanto il testo sia percepito come ancora “parlante” al pubblico di oggi.
Perché i teatri continuano ad amarla
Da regista, “La commedia degli errori” è un regalo e una sfida insieme. È breve, ha una struttura diurna compatta (tutta l’azione in un solo giorno), permette grandi invenzioni sceniche con pochi elementi: una piazza, qualche porta, un convento, una casa.
Allo stesso tempo richiede:
- tempo comico perfetto: se gli ingressi non sono millimetrici, il meccanismo si inceppa;
- un forte lavoro di ensemble, perché nessun personaggio domina la scena da solo;
- un occhio contemporaneo sulle tematiche di fondo: il rapporto con lo straniero, la fragilità dell’identità, il confine tra follia e normalità.
Per le compagnie, è un titolo che consente aggiornamenti di regia quasi infiniti: c’è chi ambienta Efeso in una metropoli globalizzata piena di migranti, chi in un luna park anni ’50, chi in un porto moderno con container e smartphone. Il cuore resta lo stesso: un mondo in cui basta un dettaglio – un nome, una faccia – per cambiare completamente il modo in cui gli altri ti trattano.
Oggi, dove vederla
Non esiste ovviamente una mappa completa delle rappresentazioni, ma guardando alle stagioni recenti si nota che “La commedia degli errori” è onnipresente:
- nei grandi teatri shakespeariani, come RSC e Globe;
- nei festival estivi all’aperto, spesso accostata ad altre commedie “di compagnia” come Sogno di una notte di mezza estate;
- nelle stagioni universitarie e dei teatri indipendenti, che ne apprezzano la leggerezza apparente e la capacità di far lavorare gruppi numerosi.
Per il pubblico italiano, vale la pena tenere d’occhio anche le rassegne estive dedicate a Shakespeare (nei festival in anfiteatri antichi, nei parchi cittadini, nei cartelloni delle compagnie che lo propongono in traduzione o in lingua originale): “La commedia degli errori” è spesso uno dei titoli prescelti quando si vuole un Shakespeare più fisico, più musicale, più adatto alle famiglie rispetto ai drammi storici o alle tragedie.
Una commedia di errori… molto contemporanei
Parlare oggi di “Commedia degli errori” significa fare i conti con un paradosso: il meccanismo comico nasce da un mondo in cui le persone si riconoscono solo di vista e di voce. Bastano due gemelli per mandare in tilt un’intera città.
Nel nostro presente iperconnesso, in cui identità, password, avatar e profili social si moltiplicano, l’idea di essere scambiati per qualcun altro – per un omonimo, un account hackerato, un volto simile in un video – non è poi così lontana. Efeso, con le sue porte che si aprono e chiudono, assomiglia in fondo al caos delle nostre notifiche.
Forse è anche per questo che registi e spettatori continuano a cercarla: dietro la risata per gli equivoci c’è il brivido di riconoscere quanto sia fragile la nostra idea di “io”. E quanto, a volte, il solo modo per sopportare questa fragilità sia farne… una commedia.
“La commedia degli errori” in Italia
- Una produzione di Fabio Grossi ha allestito lo spettacolo al Silvano Toti Globe Theatre di Roma (Villa Borghese) in estate, con giovane cast e messinscena moderna.
- Nel 2019, a Zavattarello (Pavia) è andata in scena una versione con due soli attori diretti da Eugenio Allegri, che puntava a enfatizzare il tema del doppio e dell’identità.
- Anche in contesti scolastici viene riproposto: ad esempio l’Istituto “Casimiri” ha realizzato uno spettacolo con studenti sull’opera nel teatro Don Bosco.