La frase di Siddhartha che insegna ad accettare la vita per vivere la felicità
Scopri le 7 lezioni per trovare la felicità grazie alla frase di Siddhartha, il romanzo capolavoro di Hermann Hesse simbolo di tutte le generazioni.
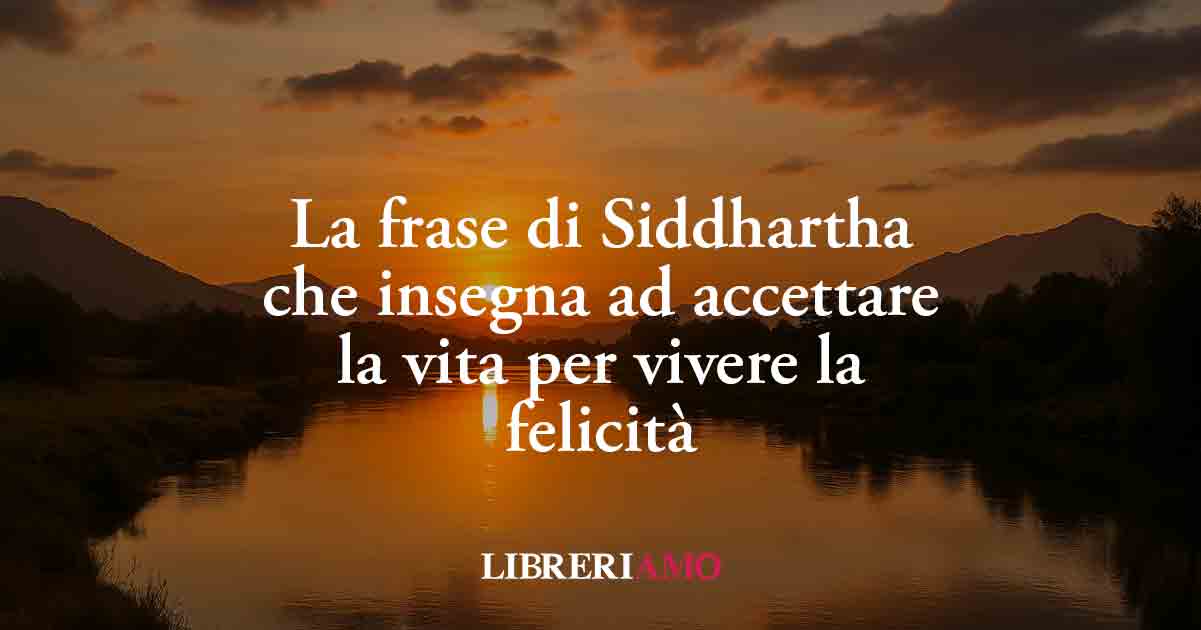
Una frase di Siddhartha, il libro capolavoro di Hermann Hesse ci dona una delle lezioni di vita più importanti per vivere bene e trovare la felicità. Accettare la vita in tutte le sue forme e godere l’esistenza è l’unica via possibile per il benessere interiore, per affrontare la vita e goderne i benefici che tutti i giorni sa regalare.
Il senso di colpa tipico della della nostra cultura, la critica esasperata, l’autolesionismo che sembra aver conquistato gli umani, le discriminazioni dell’altro, di colui che è diverso culturalmente sono i principali nemici della felicità. Non esistono esperienze inutili, nemmeno il peccato o la disperazione, perché tutto è parte di un disegno più grande. Ed è solo riconoscendo questa unità che si può raggiungere la vera pace interiore.
La meditazione profonda consente la possibilità di abolire il tempo, di vedere in contemporaneità tutto ciò che è stato, ciò che è e ciò che sarà, e allora tutto è bene, tutto è perfetto, tutto è Brahma. Per questo, a me par buono tutto ciò che esiste, la vita come la morte, il peccato come la santità, l’intelligenza come la stoltezza, tutto dev’essere così, tutto richiede solamente il mio accordo, la mia buona volontà, la mia amorosa comprensione, e così per me tutto è bene, nulla mi può far male. Ho appreso, nell’anima e nel corpo, che avevo molto bisogno del peccato, avevo bisogno della voluttà, dell’ambizione, della vanità, e avevo bisogno della più ignominiosa disperazione, per imparare la rinuncia a resistere, per imparare ad amare il mondo, per smettere di confrontarlo con un certo mondo immaginato, desiderato da me, con una specie di perfezione da me escogitata, ma per lasciarlo, invece, così com’è, e amarlo e appartenergli con gioia.
Siddhartha il libro di Hermann Hesse che ha conquistato i lettori mondiali
Siddhartha fu pubblicato per la prima volta nel 1922 in lingua tedesca, presso la casa editrice S. Fischer Verlag di Berlino. L’opera trae ispirazione dal viaggio che Hermann Hesse fece in India nel 1911, da cui trasse ispirazione per ambientazione e riferimenti filosofici. Lo scrittore lo definiva un vero e proprio “poema indiano”, capace di fondere lirica ed epica, meditazione e narrazione, sensualità ed elevazione spirituale.
La versione italiana di Adelphi utilizza la celebre traduzione di Massimo Mila. Questa traduzione è considerata un classico a sua volta, non solo per la sua fedeltà ma anche per l’eleganza dello stile. Massimo Mila, importante musicologo e antifascista, tradusse il romanzo durante gli anni della Resistenza, e la sua versione fu pubblicata per la prima volta nel 1945 dall’editore Frassinelli. Adelphi ha poi acquisito i diritti e ne ha fatto una delle edizioni di punta del suo catalogo.
Il protagonista non è il Buddha storico, ma un personaggio di fantasia che rappresenta “uno dei tanti Buddha potenziali”. Hesse parla di un uomo che, attraverso esperienze di ascesi, peccato e disperazione, giunge all’illuminazione. Il Buddha, con il nome di Gotama, appare come figura secondaria.
Il successo arrivò solo vent’anni dopo la pubblicazione, grazie anche al Premio Nobel per la Letteratura conferito a Hermann Hesse nel 1946. Fu soprattutto la gioventù del dopoguerra a fare di Siddhartha un testo di culto. Un romanzo-manifesto dell’inquietudine adolescenziale e della ricerca di sé, del rifiuto delle convenzioni e della sete di autenticità.
Negli anni Sessanta e Settanta conobbe una nuova stagione di popolarità, legata alla cultura hippie e all’interesse per l’Oriente.
Il mito di Siddhartha entrò anche nel cinema: nel 1972 Conrad Rooks diresse un adattamento cinematografico che contribuì a diffonderne ulteriormente la fama internazionale.
La frase di Siddhartha che insegna a dire sì alla vita
La riflessione che dona Hermann Hesse grazie a questa frase di Siddhartha è collocata nella nell’ultimo capitolo del romanzo, intitolato Govinda. È il momento in cui Siddhartha, ormai anziano barcaiolo illuminato, ritrova l’amico d’infanzia che aveva condiviso con lui i primi passi della ricerca spirituale.
Se Govinda ha seguito con fedeltà gli insegnamenti dei maestri, prima i Samana, poi il Buddha, senza mai raggiungere la piena pace interiore, Siddhartha ha scelto la via opposta: immergersi nel mondo, peccare, disperarsi, per poi rinascere in una nuova consapevolezza.
Il loro incontro non è solo un ricongiungimento affettivo, ma un confronto fra due vie spirituali. Quella dell’obbedienza e quella dell’esperienza diretta.
Ogni parola del passo acquista più forza se pensata come risposta a Govinda, l’uomo che ha cercato la verità fuori da sé, nelle parole di altri. Siddhartha invece gli mostra che la via autentica non è fuggire il mondo, ma abbracciarlo nella sua interezza.
Le 7 lezioni di Siddhartha per vivere felici
1) “Abolire il tempo”, la ferita del confronto si rimargina
Hermann Hesse esordisce attraverso il suo “Io spirituale” Siddhartha:
La meditazione profonda consente la possibilità di abolire il tempo, di vedere in contemporaneità tutto ciò che è stato, ciò che è e ciò che sarà
Hesse descrive uno stato meditativo in cui passato, presente e futuro non sono più blocchi separati ma un unico piano. In questa simultaneità, la vita smette di essere un processo da “aggiustare” e diventa un intero già compiuto: è qui che crolla la radice del senso di colpa (rivolto al passato) e dell’ansia di controllo (rivolta al futuro). Il confronto che ci lacerava (tra ciò che è e ciò che “dovrebbe” essere) perde mordente.
2) Tutto contribuisce alla felicità, anche ciò che ci appare opposto, diverso
e allora tutto è bene, tutto è perfetto, tutto è Brahma. Per questo, a me par buono tutto ciò che esiste, la vita come la morte, il peccato come la santità, l’intelligenza come la stoltezza
Qui Hesse tocca il non-dualismo: vita/morte, peccato/santità, intelligenza/stoltezza non sono poli nemici ma facce della stessa realtà. “Brahma” indica l’Uno che comprende ogni differenza. Per il nostro presente questo significa: smettere di etichettare in modo assoluto e riconoscere che anche ciò che non capiamo ha un posto nell’insieme. È l’antidoto alla critica esasperata e alla discriminazione: l’altro, il diverso, non è un errore da correggere ma parte di un disegno più ampio.
3) Accettare non è rassegnazione
tutto dev’essere così, tutto richiede solamente il mio accordo, la mia buona volontà, la mia amorosa comprensione
Accettare non è rassegnarsi. L’“accordo” di cui parla Siddhartha è un atto attivo, una postura della coscienza: smettere di resistere al reale. L’accettazione non cambia i fatti, cambia chi li vive. È qui che nasce il benessere interiore: quando abbandoniamo la guerra contro ciò che è, l’energia che sprecavamo nella resistenza si trasforma in chiarezza e forza.
4) Sentirsi Invulnerabili, non significa essere indifferenti
e così per me tutto è bene, nulla mi può far male.
Hermann Hesse non parla di assenza emotiva o distacco totale da ciò che circonda. Ma più semplicemente che se non opponiamo più resistenza, il dolore non diventa sofferenza aggiunta (quella creata dal rifiuto, dal rimuginio, dall’odio). È la serenità vigile di chi resta sensibile e responsabile, ma non è più schiavo degli eventi.
5) Sbagliare significa imparare
Ho appreso, nell’anima e nel corpo, che avevo molto bisogno del peccato, avevo bisogno della voluttà, dell’ambizione, della vanità, e avevo bisogno della più ignominiosa disperazione, per imparare la rinuncia a resistere, per imparare ad amare il mondo
Per Siddharta le cadute non sono deviazioni, sono maestre. Vanità, ambizione, voluttà, disperazione, tutto ciò che spesso condanniamo ha insegnato a Siddhartha la rinuncia autentica, non quella imposta, e la compassione. È un messaggio esplosivo contro l’autolesionismo morale: non si tratta di giustificare il danno, ma di trasformare l’errore in conoscenza. Nel nostro quotidiano: smettere di flagellarci per le scelte passate e chiederci che cosa hanno educato in noi.
6) Liberarsi dalla schiavitù della perfezione
per smettere di confrontarlo con un certo mondo immaginato, desiderato da me, con una specie di perfezione da me escogitata, ma per lasciarlo, invece, così com’è
La sofferenza, dice Hesse, nasce dal paragone col mondo immaginato. È la tirannia del perfezionismo: relazioni, lavoro, corpo, città, politica, sempre al di sotto di un ideale. L’uscita? Congedare il mito della perfezione e tornare al reale concreto, dove si può agire davvero. Questo è il punto che parla alla nostra epoca di confronto sociale e feed infiniti: meno ideale astratto, più presenza operosa.
7) La felicità è appartenere al Mondo e alla Vita
Il finale della frase è il sigillo: non basta accettare la vita, occorre appartenere ad essa. L’appartenenza rovescia la postura del soggetto isolato e giudicante: non più un “io” separato che osserva e valuta il mondo, ma un essere che si riconosce dentro il mondo stesso. È qui che nasce la gioia, non come stato momentaneo, ma come condizione di fondo.
Amare ed appartenere significa non soltanto accogliere il diverso come parte della stessa unità, ma anche riconoscere la natura come madre che ci sostiene, accettare gli eventi – persino quelli dolorosi – come passaggi necessari del nostro cammino, e saper apprezzare il quotidiano in ogni sua manifestazione. Un gesto semplice, un incontro inaspettato, un errore, un silenzio: tutto diventa parte di un mosaico che ci comprende e ci sorregge.
Quando Hermann Hesse scrive che bisogna “amare il mondo e appartenergli con gioia”, ci invita a comprendere che l’armonia non si raggiunge fuggendo dalla realtà o immaginandone una migliore, ma immergendosi nella vita fino a riconoscere che nulla ci è estraneo. Il mondo non è solo l’altro uomo, ma l’intero paesaggio della nostra esistenza: persone, natura, tempo, memoria, possibilità.
La vera appartenenza nasce nel momento in cui smettiamo di considerarci estranei o padroni del mondo e impariamo invece a sentirci parte integrante di esso. Allora l’amore diventa autentico e la gioia scaturisce spontanea, perché nulla è più percepito come nemico, ma come frammento del grande insieme di cui siamo parte.
Un’immagine concreta di cosa dovrebbe essere vivere felici
È questo lo sguardo che Siddhartha consegna a Govinda nell’ultima pagina del romanzo: il sorriso sereno e luminoso che racchiude la sua intera illuminazione. Un sorriso che non giudica, non esclude e non resiste più, ma che dice soltanto sì al mondo. In quel gesto silenzioso, Govinda riconosce finalmente la verità che aveva cercato per tutta la vita: la pace nasce dall’amore che ci lega al tutto.
Il viaggio di Siddhartha non si conclude in un concetto astratto, ma in un’immagine concreta, quella del sorriso che illumina il suo volto nell’ultimo incontro con Govinda. È il simbolo di una verità che non ha bisogno di parole: la felicità nasce quando si smette di lottare contro il mondo e lo si accoglie nella sua interezza. In quel sorriso si racchiude la pace di chi non cerca più perfezioni immaginate, ma si lascia abbracciare dalla vita così com’è. Ed è proprio questo lo straordinario dono che Hermann Hesse consegna a ogni lettore: la certezza che la gioia non è altrove, ma qui, nell’appartenenza al tutto.