Una frase di Roberto Vecchioni spiega il senso del destino e perché accadono certe cose
“Ma perché proprio a me?” Scopri la risposta a questa domanda grazie alla frase di Roberto Vecchioni tratta dal libro “Il mercante di luce”.
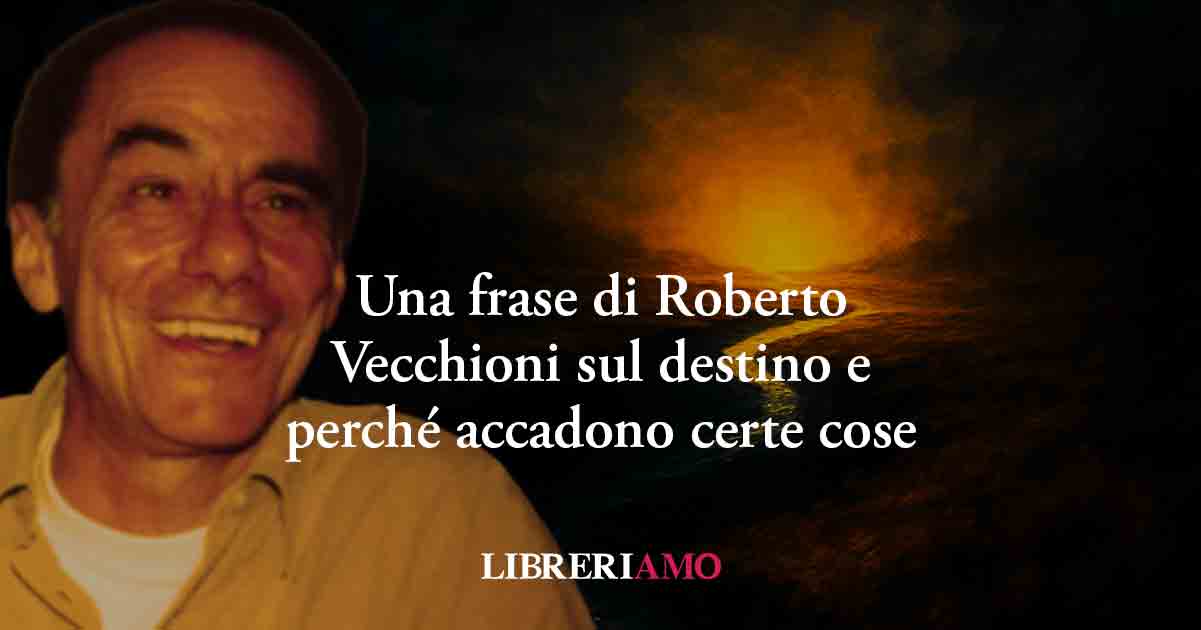
C’è una frase di Roberto Vecchioni che dona una bellissima definizione del destino, tra l’altro rifacendosi alla letteratura greca antica, distinguendolo dal caso. Una frase di grande significato che spinge ad una riflessione profonda sulla vita e sul perché accadono certe cose nel percorso della propria esistenza.
Il destino è un fiume sotterraneo che scorre parallelo alla vita: ogni tanto emerge e allora ci sommerge e ci chiediamo «ma perché proprio a me?»: oh, sí, solo a te, perché quel fiume è il tuo, e c’era anche quando non lo vedevi.
Parole che tolgono il fiato, soprattutto quando si è costretti nella vita a dover affrontare degli eventi o dei momenti non felici, terribili, dove la vita incontra la malattia, la disabilità, la povertà, l’oppressione, la violenza, il male. È in quei momenti che quel fiume invisibile sembra travolgerci, riportando a galla la domanda più antica del mondo.
La frase di Roberto Vecchioni è tratta dal libro Il mercante di luce, un romanzo psicologico pubblicato da Einaudi nel 2014.
Una frase di Roberto Vecchioni che dona una lezione sul destino
Nella sua frase, Roberto Vecchioni offre una concezione del destino che si si allontana dall’idea di caso o di sfortuna casuale, per abbracciare una visione più intima e personale. Il il destino non è un incidente di percorso, ma il percorso stesso, anche nelle sue parti più nascoste e dolorose. L’uomo saggio non è colui che evita il fiume, ma colui che, quando questo emerge, riconosce che gli appartiene e trova la forza e la bellezza per affrontarne la piena.
Quando accade qualcosa che finisce per cambiare l’esistenza, anche molto difficile d’affrontare, serve la forza di cambiare il punto di vista e adottare tutti i meccanismi affinché l’esperienza negativa possa diventare virtuosa.
Ma per capire meglio questa lezione del professor Vecchioni bisogna inquadrare il contesto del romanzo e l’occasione in cui questa frase prende vita.
La frase di un padre al figlio malato
Il mercante di luce è un libro che esplora il rapporto tra un padre e un figlio di fronte alla caducità della vita, trovando rifugio e salvezza nella bellezza senza tempo della letteratura greca.
Al centro della narrazione, ambientata nel nostro tempo, vi è Stefano Quondam Valerio, un professore di lettere classiche, e suo figlio diciassettenne Marco, affetto da progeria, una rara malattia che accelera drasticamente l’invecchiamento. Con il tempo che scorre inesorabile per Marco, Stefano intraprende una corsa contro la morte per donare al figlio l’eredità più preziosa che possiede, la “luce” della conoscenza e della poesia, quella fiamma che i grandi autori greci hanno acceso secoli fa e che continua a illuminare l’esistenza umana.
Il romanzo si dipana attraverso un dialogo intimo e profondo tra padre e figlio, in cui le lezioni di greco diventano lezioni di vita. Omero, Saffo, Sofocle ed Euripide non sono semplici nomi su un libro di testo, ma diventano compagni di viaggio, le cui parole offrono a Marco una prospettiva diversa sulla sua condizione, sull’amore, sul dolore e sul significato stesso di vivere.
Stefano, il “mercante di luce”, cerca di vendere a suo figlio non beni materiali, ma la bellezza immortale dei versi che hanno attraversato i millenni.
Quondam è un personaggio centrale e complesso che ha dedicato la sua vita interamente allo studio dei classici, che per lui non sono solo materia di insegnamento, ma una vera e propria lente attraverso cui interpretare il mondo e l’esistenza. Nonostante la sua profonda cultura, Stefano è anche descritto come un uomo con i suoi difetti, un “Don Chisciotte” che lotta contro la superficialità del mondo moderno, sentendosi spesso fuori posto e incompreso.
In sostanza, Stefano Quondam rappresenta la figura del padre che, di fronte al dolore più grande, si aggrappa alla cultura e alla bellezza come unico strumento per dare un senso alla vita e per illuminare gli ultimi giorni del figlio.
La paura della notte e il significato del destino
Nell’ambito del romanzo la frase è pronunciata da Stefano come reazione alla confessione di Marco di aver paura della notte. Il padre sembra rincuorarlo dicendo di aver portato i dadi per giocare insieme, come rifacendosi all’Iliade di Omero, facevano gli Achei durante l’assedio di Troia.
Giocano a dadi gli achei, rassicurati da un tempo che tra una strage e l’altra si misura fermo. C’è nella notte come una tregua dal male. L’uomo traghetta la sua infelicità tra un giorno doloroso e un altro che lo sarà. Là, in fondo, prima della ragione, il destino solo questa intercessione concede, e gli uomini accendono fuochi come a imitare le stelle e ringraziarle.
La vicenda epica permette al professore di poter offrire al figlio una definizione chiara del destino e la distinzione rispetto al caso.
Il destino è ben altra cosa dal caso. Il caso, la tyche, è qualcosa d’imponderabile, inimmaginabile, inaspettato. I greci, cosí sicuri che esistesse un’armonia nel mondo, dettata dai numeri, e un primato della ragione e del pensiero, dietro il caso ci persero la testa e il fegato, per venirne a capo. E fu sempre sconfitta. Il destino, la móira, non è casuale. È lí, intrufolato nel nostro dna, ha tutte le sue premesse nel carattere (dáimon); se si compie è perché, sconosciuto o no, aveva già una ragione di compiersi.
Da qui nasce la citazione che è il centro della riflessione che Vecchioni propone.
Il destino è un fiume sotterraneo che scorre parallelo alla vita: ogni tanto emerge e allora ci sommerge e ci chiediamo «ma perché proprio a me?»: oh, sí, solo a te, perché quel fiume è il tuo, e c’era anche quando non lo vedevi.
Il figlio allora chiede per aver certezza di aver capito:
Cioè una combinazione ai dadi è un caso e, mettiamo, un incidente in moto è destino?
E il padre conferma
Sí, anánke per i greci, cioè necessità, perché prima o poi si compie.
Allora il figlio svela di aver capito perché ha paura della notte.
Forse è per questo che ho cosí paura della notte, perché nasconde in sé tutti i destini. E il mio destino.
Allora, Quondam per rassicurare e trasferire al figlio la necessaria sicurezza offre parole di rara bellezza:
No, la notte è tutt’altro. La notte in sé è bellezza e silenzio. Siamo noi a riempirla di fantasmi. La notte non è la somma dei destini, è la somma delle attese e delle speranze.
Il dialogo riportato trasferisce un tesoro di parole enorme a chi lo legge. Riesce a donare un pizzico di forza a coloro che purtroppo da protagonisti o da accompagnatori sono costretti a vivere la paura della notte.
Ma la lezione del Professor Vecchioni sul destino merita di essere approfondita di più.
Il destino vive dentro di noi, bisogna solo saperlo ascoltare
Nella sua frase, Roberto Vecchioni descrive il destino come un fiume che scorre nel profondo dell’essere umano. Non qualcosa che viene da fuori, ma una corrente che attraversa la vita di ciascuno e la accompagna in silenzio. È una forza che non si vede ma che esiste, e che ogni tanto riaffiora con la potenza di un richiamo.
Quando afferma che il destino è un fiume sotterraneo che scorre parallelo alla vita, Vecchioni offre una visione in cui ogni esistenza è attraversata da una linea invisibile che la guida. Non è una minaccia né un caso fortuito, ma una presenza che definisce il senso stesso del vivere. Il destino, in questa prospettiva, non è qualcosa da temere o da subire, ma da riconoscere.
E quando quel fiume emerge e ci sommerge, la frase tocca il punto più alto del momento in cui si prende coscienza di vivere la tragedia. È l’immagine della prova, del dolore, dell’imprevisto che sconvolge l’ordine quotidiano. Di fronte a quell’onda, la domanda più umana e più vera arriva spontanea: “Perché proprio a me?”
Sembra di ascoltare queste parole nella vita di tutti i giorni, nelle voci di milioni di persone costrette a vivere l’imprevedibile, l’inaspettato, come una mancanza di giustizia divina, come una forza cosmica punitiva che colpisce lasciando tramortiti.
Una domanda a cui bisogna saper dare una risposta, e che Vecchioni, rivolgendosi a un tu ipotetico, scioglie con lucidità: “Sì, proprio a te, perché quel fiume è il tuo, e c’era anche quando non lo vedevi.”
In queste parole non c’è rassegnazione, ma una forma alta di conoscenza. Significa che ogni persona porta dentro di sé un cammino unico, intrecciato alle proprie origini, ai propri limiti, alla propria forza. Il destino non è qualcosa che accade per caso, ma ciò che rivela chi si è davvero quando la vita mostra il suo lato più difficile.
Il padre non vuole consolare il figlio, vuole prepararlo, sostenerlo, motivarlo. E questa frase, allo stesso modo, parla a tutti coloro che hanno bisogno di capire, a chi si trova nel momento in cui la disperazione sembra aver cancellato ogni possibilità di reagire.
Roberto Vecchioni, con le sue parole, offre gli strumenti per affrontare la paura, per non perdersi di fronte all’inevitabile. Insegna che la vita non si difende fuggendo dal dolore, ma attraversandolo, affrontandolo senza timore, perché ciò che si vive è parte dell’esistenza. Il destino, per quanto duro, è ciò che fa di un uomo un essere consapevole, capace di resistere, di comprendere e di andare oltre.
Così il fiume non è più soltanto una metafora, ma diventa un modo per guardare la vita con coraggio. Ciò che accade non è mai completamente estraneo. Scorre dentro, e nel momento in cui riaffiora, chiede solo di essere affrontato con dignità, con intelligenza, con la luce che la conoscenza può dare.
Il destino vive dentro ogni essere umano come una forma di verità, la più profonda e irriducibile. Chi impara a riconoscerlo smette di temerlo e comincia, finalmente, a vivere.
Non resta che ringraziare il professor Roberto Vecchioni per questa stupenda lezione di vita. Non risolve il buio di chi è costretto a vivere la notte, ma può aiutare qualcuno a trovare la luce delle stelle.