Una frase di Niccolò Ammaniti insegna agli adulti ad ascoltare le paure dei bambini
In occasione di Halloween scopriamo la frase di Niccolò Ammaniti da “Io non ho paura”, una vera lezione per aiutare i piccoli a vincere le paure.
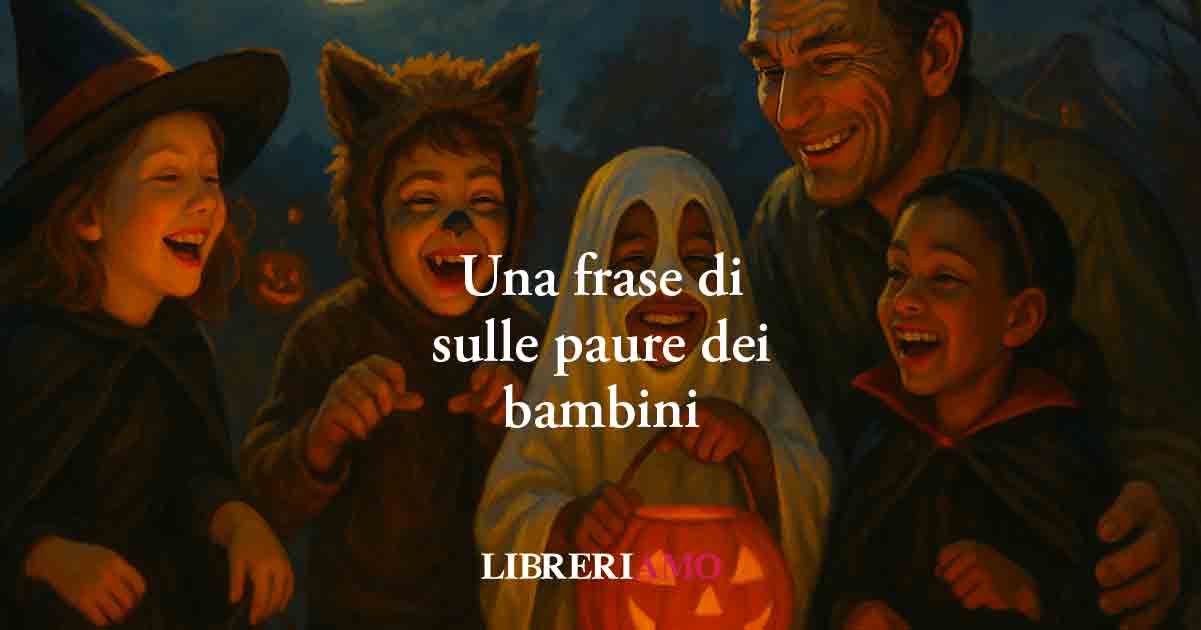
In occasione di Halloween abbiamo scelto una frase di Niccolò Ammaniti, tratta da uno dei suoi libri di maggior successo, Io non ho paura, che è diventato il soggetto anche per l’omonimo film. Una citazione che offre una riflessione molto importante sull’importanza di prestare molta attenzione al linguaggio dei bambini, soprattuto mostrando particolare attenzione ai loro mostri, ai loro personaggi fantastici, perché possono aiutare a capire le loro paure e aiutarli a superarle.
Piantala con questi mostri, Michele. I mostri non esistono. I fantasmi, i lupi mannari, le streghe sono fesserie inventate per mettere paura ai creduloni come te. Devi avere paura degli uomini, non dei mostri.
La frase di Ammaniti mette in luce una grande verità: ogni bambino ha i suoi mostri. Alcuni li immaginano nascosti sotto il letto, altri li sentono respirare nel buio o nel vento che soffia dietro la finestra. Sono immagini che cambiano forma ma raccontano sempre la stessa cosa, il bisogno di essere ascoltati.
Banalizzare o rendere “adulte” le loro richieste di ascolto non li aiuta. Anzi, spesso dietro la fantasia di un mostro si nasconde una verità che chiede di essere capita.
Per comprendere fino in fondo la forza delle parole di Niccolò Ammaniti bisogna guardare al momento in cui vengono pronunciate nel romanzo.
Contesto della frase di Niccolò Ammaniti
La frase compare nel secondo capitolo di Io non ho paura e viene detta dal padre del protagonista, Pino Amitrano, in uno dei passaggi più intensi e drammatici del libro.
La storia è ambientata nell’estate del 1978, nel piccolo e isolato paese immaginario di Acqua Traverse, nel Sud Italia. Durante un gioco con i suoi amici nei campi di grano, il piccolo Michele, nove anni, fa una scoperta che cambia la sua vita. In un casolare abbandonato, in fondo a una buca, trova un bambino prigioniero, sporco, denutrito e terrorizzato.
All’inizio Michele crede di trovarsi davanti a una visione, una di quelle figure spaventose che abitano le paure infantili. La mente non riesce a distinguere se ciò che ha visto è reale o frutto dell’immaginazione. Confuso e impaurito, prova a confidarsi con suo padre, cercando di spiegare quella mostruosità che ha visto davvero, ma viene frainteso.
Il padre, convinto che stia raccontando le solite fantasie da bambino, reagisce con durezza e pronuncia la frase che è diventata il simbolo del romanzo.
Con quelle parole Pino chiude ogni possibilità di ascolto e nega la verità che il figlio sta cercando di comunicargli. Ma, paradossalmente, proprio mentre cerca di zittirlo, dice la verità più profonda. I mostri non esistono nella fantasia, esistono negli uomini. Michele, invece, lo aveva già capito, solo che non aveva ancora le parole per dirlo.
È il momento in cui l’infanzia si scontra con la realtà e l’immaginazione si infrange contro il mondo adulto. Michele comprende che il male non è un’invenzione, ma qualcosa che può vivere nelle persone che ama. La fantasia dei mostri diventa allora il suo modo innocente di dare forma a ciò che non riesce a spiegare, di raccontare con il linguaggio dell’immaginazione la verità più difficile da accettare.
La lezione della frase tratta dal libro Io non ho paura
La frase di Niccolò Ammaniti racchiude un doppio insegnamento che riguarda il mondo dei bambini e la responsabilità degli adulti.
Quando Pino, il padre di Michele, dice “I mostri non esistono”, crede di liberare il figlio dalle sue paure, ma in realtà compie l’errore più grande perché nega la realtà emotiva che il bambino stava cercando di comunicare.
Il linguaggio dell’infanzia non è mai diretto. È simbolico, immaginativo, fatto di figure che traducono ciò che non si riesce a dire. I mostri dei bambini non sono semplici invenzioni ma metafore dell’ignoto, rappresentano il buio interiore, l’ansia di perdere l’amore dei genitori, la paura dell’abbandono o del dolore.
Ascoltare un bambino significa accettare che la sua verità possa essere raccontata in modo fantastico. Ogni volta che un adulto risponde con un “non esistono”, chiude la porta del dialogo e interrompe un racconto che aveva un senso profondo.
Le parole di Pino, apparentemente logiche, sono dunque un fallimento d’empatia. Non si accorge che Michele non gli stava parlando di streghe o fantasmi, ma di una mostruosità vera, vista con i suoi occhi e filtrata dall’immaginazione per poter essere sopportata.
I mostri come linguaggio dell’anima infantile
Per i bambini la paura non è solo una sensazione ma un modo di conoscere il mondo. Il mostro è la forma che l’anima sceglie per esprimere ciò che non comprende.
Attraverso le figure del buio, delle ombre o degli esseri fantastici, il bambino costruisce un ponte tra l’invisibile e il reale. Il compito degli adulti è attraversare quel ponte insieme a lui, senza smontarlo.
Il grande psicologo Jean Piaget spiegava che la paura è una tappa necessaria dello sviluppo cognitivo perché consente al bambino di dare ordine all’esperienza e alle emozioni.
Bruno Bettelheim, nel suo celebre saggio Il mondo incantato, sosteneva che le fiabe e le immagini spaventose aiutano i bambini a rappresentare e a vincere i propri conflitti interiori. Per Gianni Rodari la fantasia non è fuga dalla realtà ma uno strumento per entrarci dentro con occhi più liberi.
Quando un genitore si ferma ad ascoltare e a giocare con i mostri del figlio non alimenta la paura ma la trasforma. Giocare con la paura significa renderla visibile e condivisa, portarla fuori da sé, darle un nome. È un gesto che libera, che restituisce fiducia e che insegna la cosa più importante, non esistono emozioni da nascondere ma solo emozioni da capire.
Halloween e la pedagogia del coraggio
Halloween, nella sua forma più autentica, è molto più di una festa in maschera. È un momento collettivo in cui la comunità, attraverso il gioco e la condivisione, mette in scena il rapporto tra paura e conoscenza.
Sotto la superficie del divertimento si nasconde un messaggio educativo importante che non elimina la paura, ma invita a riflettere su di essa e a darle voce.
Halloween non è la cura, ma il promemoria di una possibilità: imparare a guardare le proprie paure da vicino, senza giudicarle, senza fuggirle. È un’occasione simbolica che ci ricorda quanto sia importante accogliere la paura, non negarla, e farne uno spazio di crescita.
Imparare a guardare la paura
In occasione di Halloween, è utile la riflessione di Niccolò Ammaniti per comprendere che per i bambini, travestirsi da mostri, streghe o scheletri è un gesto di conquista. Significa entrare nella paura per poterla addomesticare, ridere del buio, trasformare l’angoscia in un linguaggio condiviso.
Bruno Bettelheim lo chiamava il potere catartico della fantasia, la possibilità di trasformare il male in racconto per poterlo affrontare. Jean Piaget ricordava che la paura fa parte dello sviluppo e aiuta il bambino a dare un ordine emotivo al mondo. Quando la paura si racconta o si gioca, smette di essere pura minaccia e diventa conoscenza.
Il gioco come spazio del coraggio
Il filosofo Walter Benjamin descriveva l’immaginazione infantile come un laboratorio dell’esperienza, dove i bambini imparano a dominare il mondo invece di subirlo.
Nel gioco di Halloween questo laboratorio prende vita. Il piccolo vampiro che ride della sua ombra, la bambina che si traveste da strega, il gruppo che va di porta in porta compiono un piccolo rito di liberazione.
Carl Gustav Jung vedeva nei mostri e nelle figure del buio il simbolo dell’Ombra, la parte di noi che va riconosciuta e integrata.
Quando un bambino gioca con le sue paure, compie un gesto di conoscenza profonda. Trasforma l’ombra in qualcosa di comprensibile, come accade in Monsters & Co. di Disney Pixar, dove i mostri imparano a convivere con i bambini e a scoprire che la risata è più potente del terrore. Non a caso, quel film è diventato una metafora universale della paura come energia da trasformare, non da rimuovere.
L’adulto deve ascoltare e accompagnare, questo è il modo più giusto per spiegare
Maria Montessori sosteneva che il bambino non deve essere protetto dalle emozioni, ma accompagnato nella loro scoperta.
In questa prospettiva, Halloween diventa una piccola palestra di coraggio, un’esperienza in cui l’adulto partecipa, ascolta, gioca, ma non banalizza. Partecipare al gioco della paura non significa ridurla a spettacolo, ma stare accanto ai bambini mentre la vivono, aiutandoli a capire che anche il buio può avere una luce.
Gianni Rodari diceva che non c’è nulla di più serio del gioco dei bambini, perché è il loro modo di imparare a vivere. Quando un genitore gioca con un bambino, quando entra nel suo mondo, gli insegna che la paura può essere attraversata insieme e trasformata in coraggio.
Il coraggio come eredità dell’ascolto
Nella luce tremolante delle zucche, nella risata che rompe il buio, nella mano di un adulto travestito da mostro buono che accompagna quella di un bambino, si compie un gesto semplice e profondo.
È il gesto del coraggio che nasce dall’ascolto, dal gioco e dall’amore. Un coraggio che non cancella la paura, ma la trasforma in consapevolezza.
Proprio come Michele, nel romanzo di Niccolò Ammaniti, impara a guardare il male senza smettere di credere nel bene, anche ogni bambino può imparare che la paura non è un nemico da combattere, ma una verità da attraversare.
Halloween ci ricorda ogni anno che il coraggio nasce dal riconoscere i propri mostri e dal saperli guardare con dolcezza.