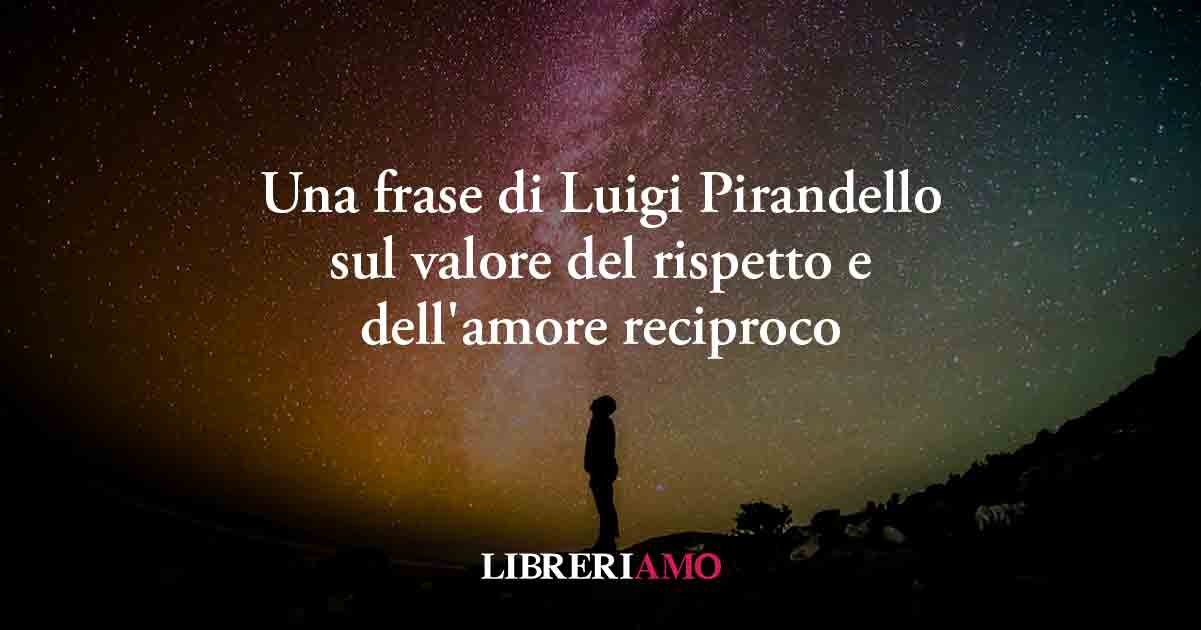Il conflitto, la rivalità, lo scontro, l’odio, la sopraffazione, la nostra storia, individuale e collettiva, sembra costruita su queste parole. Una frase di Luigi Pirandello sembra mettere in guardia l’umanità che sarebbe auspicabile avere un approccio alla vita che tenga conto delle reciproche fragilità per sostenersi e affrontare la vita superando insieme le difficoltà. E, invece no, il contrasto e la divisione emergono per terre, idee, simboli, persino per piccoli dettagli insignificanti. Il Mondo sembra popolato da “atomi impazziti” alla ricerca della reciproca distruzione. Ma basterebbe spostare lo sguardo di qualche grado, alzarlo verso il cielo, per capire quanto siamo piccoli.
E dimentichiamo spesso e volentieri di essere atomi infinitesimali per rispettarci e ammirarci a vicenda, e siamo capaci di azzuffarci per un pezzettino di terra o di dolerci di certe cose, che, ove fossimo veramente compenetrati di quello che siamo, dovrebbero parerci miserie incalcolabili.
Questa frase di Luigi Pirandello è tratta dalla Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa del suo libro Il fu Mattia Pascal, il celebre romanzo del grande genio siciliano Il fu Mattia Pascal fu pubblicato per la prima volta a puntate sulla rivista Nuova Antologia fra il 16 aprile e il 16 giugno 1904, con cadenza quindicinale. Lo stesso anno venne ricavato dai vari fascicoli un estratto autonomo, che costituì la prima pubblicazione in volume del romanzo.
Il contesto della frase di Luigi Pirandello ne Il fu Mattia Pascal
Il fu Mattia Pascal non si apre direttamente con la storia del suo protagonista, ma con due “premesse” che Luigi Pirandello utilizza come cornice e, allo stesso tempo, come dichiarazione d’intenti. La seconda, quella che ci interessa, porta un titolo eloquente: Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa. Non è un vezzo letterario, ma una scelta precisa: prima di raccontare, Pirandello sente il bisogno di riflettere e di giustificarsi, di spiegare perché scrivere un romanzo in un tempo in cui l’uomo ha perso le sue certezze.
Mattia Pascal, voce narrante, racconta di aver trovato l’ispirazione alla scrittura della sua storia in una chiesetta sconsacrata, accanto al reverendo don Eligio Pellegrinotto, intento a riordinare la biblioteca del defunto Monsignore Boccamazza. Tra volumi sacri e testi licenziosi accostati per errore, Mattia osserva con ironia il lavoro del bibliotecario e si lascia andare a una riflessione che travalica la situazione concreta.
Il bersaglio polemico è Copernico. Con la sua scoperta, l’uomo non è più al centro dell’universo, ma relegato su un pianeta qualunque che gira nello spazio senza scopo apparente. Per Pirandello questa è una ferita esistenziale: “Maledetto sia Copernico!”, dice Mattia con ironica disperazione. Prima, quando la Terra era considerata immobile, l’uomo poteva sentirsi grande, al centro del cosmo, degno di raccontare in dettaglio la propria vita e le proprie imprese. Ora invece non resta che constatare la sproporzione tra la piccolezza umana e l’infinito che lo circonda.
È qui che appare l’immagine della “trottolina invisibile”. La Terra come un granello impazzito che gira senza scopo, e gli uomini ridotti a “vermucci” che si agitano senza sapere perché.
Siamo o non siamo su un’invisibile trottolina, cui fa da ferza un fil di sole, su un granellino di sabbia impazzito che gira e gira e gira, senza saper perché, senza pervenir mai a destino, come se ci provasse gusto a girar così, per farci sentire ora un po’ più di caldo, ora un po’ più di freddo, e per farci morire – spesso con la coscienza d’aver commesso una sequela di piccole sciocchezze – dopo cinquanta o sessanta giri? Copernico, Copernico, don Eligio mio, ha rovinato l’umanità, irrimediabilmente.
Bisognerebbe comprendere che è un passaggio ironico e amaro insieme in quanto la vita umana si consuma su questo piccolo pianeta che non ha meta, che alterna caldo e freddo, e che alla fine ci lascia morire dopo “cinquanta o sessanta giri”, spesso con la coscienza di aver commesso solo una serie di sciocchezze.
E proprio questa la fragilità che gli umani dovrebbero percepire e agire in modo opposto rispetto a ciò che invece avviene.
La lezione di Pirandello che dovremmo tutti imparare
“E dimentichiamo spesso e volentieri di essere atomi infinitesimali…” La frase che Luigi Pirandello ha donato all’umanità è dovremmo impararla tutti a memoria e fare in modo che il suo contenuto spinga ad agire pensando più alla solidarietà reciproca, al rispetto e alla amore, dal dialogo armonico, anziché continuare invece a farsi guidare dall’odio, dalla sopraffazione, dal conflitto, dalla discordia.
Il senso è che, pur avendo perso l’illusione della centralità, non abbiamo imparato nulla. Si continua a litigare, a dividersi, a combattere per “pezzettini di terra” o per questioni insignificanti. È una diagnosi dell’umano che ha acquisito la consapevolezza della sua piccolezza cosmica, ma non la applica nella vita quotidiana.
Questa premessa, quindi, non è marginale. È il manifesto filosofico del romanzo Il fu Mattia Pascal, e con lui l’uomo pirandelliano, ovvero un individuo smarrito, minuscolo, sospeso tra il desiderio di essere libero e la constatazione della propria irrilevanza. La frase sugli “atomi infinitesimali” diventa allora un monito universale. Se fossimo davvero consapevoli di ciò che siamo, cambierebbe radicalmente il nostro modo di vivere insieme.
Il grande drammaturgo siculo in poche righe riesce a stimolare la riflessione su:
1. La condizione cosmica dell’uomo
Luigi Pirandello parla di “atomi infinitesimali”: siamo particelle minuscole, invisibili se rapportate all’universo. È un’immagine che richiama la scienza, ma soprattutto serve a ridimensionare il nostro orgoglio. Di fronte all’infinità del cosmo, l’uomo non può che riconoscere la propria fragilità e precarietà.
2. L’etica del rispetto e dell’ammirazione reciproca
La consapevolezza della nostra piccolezza dovrebbe portarci a un atteggiamento opposto a quello che vediamo nel mondo: non arroganza, ma umiltà; non sopraffazione, ma rispetto. Pirandello scrive che, se ci sentissimo davvero “compenetrati di quello che siamo”, dovremmo imparare ad ammirarci a vicenda, riconoscendo in ogni persona la stessa condizione fragile e provvisoria. La piccolezza, in questo senso, non è una condanna, ma una possibilità di incontro.
3. La sproporzione dei nostri conflitti
Eppure, osserva Pirandello, accade il contrario. Ci azzuffiamo “per un pezzettino di terra”, ci tormentiamo per questioni minime, e trasformiamo in tragedie quelle che sono in realtà “miserie incalcolabili”. La forza della frase sta proprio nel contrasto: mentre la nostra condizione cosmica ci suggerirebbe solidarietà e fraternità, le nostre azioni quotidiane mostrano rivalità, divisioni e odio.
In questo senso, la frase di Pirandello è una lezione di prospettiva: invita a guardare dall’alto le nostre rivalità per riconoscerne l’assurdità. E soprattutto a sostituire l’orgoglio e l’odio con due gesti semplici e rivoluzionari: rispettarci e ammirarci a vicenda.
Questa diagnosi, scritta all’inizio del Novecento, sembra descrivere perfettamente anche il nostro tempo. Guerre combattute per confini, ideologie che dividono popoli e comunità, rancori personali amplificati dai social e dai media. Ovunque vediamo la sproporzione tra la grandezza dei nostri conflitti e la piccolezza della nostra condizione.
Riscoprire la nostra piccolezza come fondamento di una nuova umanità
La frase di Luigi Pirandello non è soltanto un invito morale, ma un monito filosofico che tocca le radici della nostra convivenza. Dire che siamo “atomi infinitesimali” significa riconoscere la nostra contingenza. Gli umani non sono i padroni dell’universo, ma creature che vivono in un equilibrio fragile, provvisorio, continuamente esposto al caso e all’imprevisto.
Questa consapevolezza, lungi dal generare disperazione, può diventare la condizione per una nuova etica sociale. Se comprendiamo di essere piccoli e vulnerabili, allora nessuna lotta per il dominio, nessun conflitto di potere, nessuna pretesa di superiorità può avere giustificazione. La fragilità condivisa diventa il fondamento della solidarietà.
Sociologicamente, Pirandello ricorda che le società si sfaldano quando dimenticano la comune misura umana e si irrigidiscono su identità, confini e simboli. Filosoficamente, invita a relativizzare le nostre ossessioni per riscoprire il valore più grande della vita, ovvero l’”altro”, che è fragile come noi e che proprio per questo merita rispetto e ammirazione.
La frase non chiede di rassegnarci alla nostra piccolezza, ma di trasformarla in forza collettiva. Riconoscere che siamo nulla di fronte al cosmo e proprio per questo tutto gli uni per gli altri. È questa la lezione che Luigi Pirandello lascia all’umanità. Il vero antidoto all’odio e alla distruzione non è la grandezza, ma la coscienza della nostra comune fragilità.