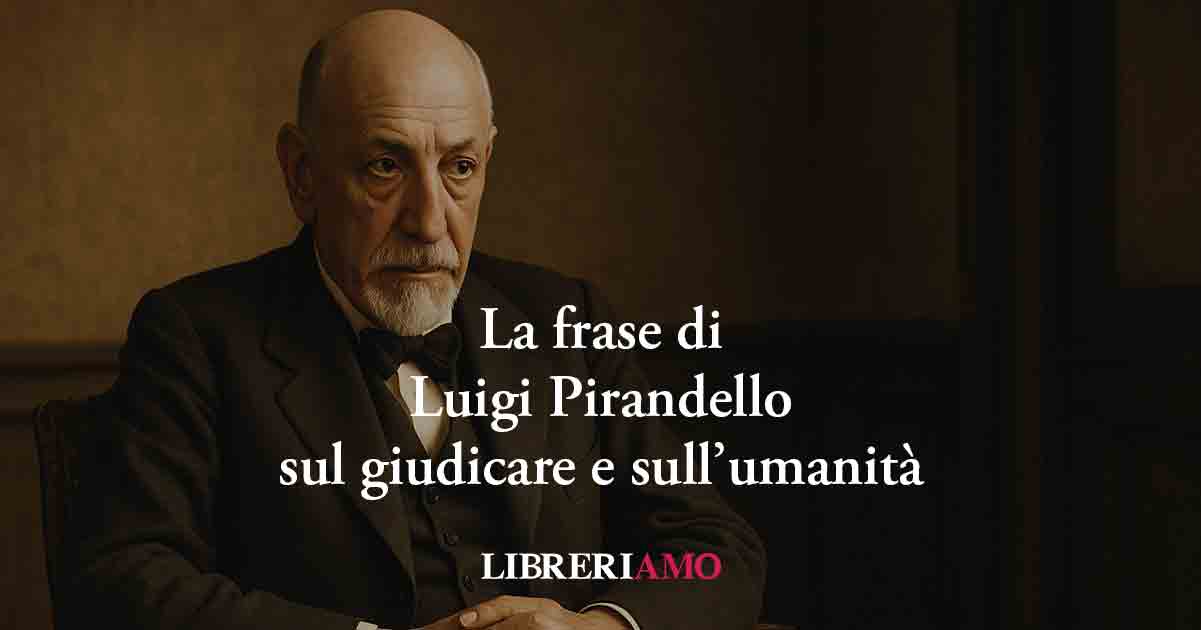Che valore ha davvero il giudizio degli altri? E in che modo definisce ciò che chiamiamo umanità? Una frase di Luigi Pirandello permette di affrontare la questione non attraverso un saggio teorico, ma dentro una vicenda teatrale fatta di scandali, pettegolezzi e coscienze tormentate. Nel primo atto di Ciascuno a suo modo (1924), la protagonista Delia Morello pronuncia parole che ancora oggi spiazzano per la loro ambiguità e lucidità:
“Sapete che cosa significa amare l’umanità? Significa soltanto questo: essere contenti di noi stessi. Quando uno è contento di sé stesso, ama l’umanità. Quando uno è contento di sé stesso «ama l’umanità». Pienissimo di questo amore – oh, felice!”
È un passaggio che nasce da un contesto preciso. Delia Morello è la protagonista femminile della commedia di Luigi Pirandello. È un’attrice al centro di uno scandalo, accusata di aver tradito il giovane pittore Giorgio Salvi, che per lei si è tolto la vita. Figura fragile e controversa, è giudicata dal mondo borghese più per il corpo e per la sua fama che per la coscienza o la persona che è davvero. Attraverso di lei Pirandello mette in scena il peso del giudizio sociale e l’ambiguità del concetto stesso di umanità.
Per Umanità intendiamo il concetto di solidarietà umana, di comprensione e di indulgenza verso gli altri uomini. Quindi, il concetto di aprirsi agli altri senza pregiudizi e o preconcetti. Oggi, purtroppo, sembriamo assediati dai giudizi altrui, che prendono forma attraverso commenti, recensioni, video, semplici simboli come gli emoji. Oggi più che mai tutto diventa oggetto e soggeto di giudizio, in barba all’umanità, al rispetto degli altri, alla solidarietà.
Proprio per questo la frase di Luigi Pirandello è meritevole di condivisione, il grande genio siciliano aiuta a riflettere sul sempre più difficile e molte volte discordante rapporto tra giudizio personale o sociale e umanità.
Il contesto teatrale della frase
La frase di Luigi Pirandello non nasce in astratto, ma dentro la trama di un dramma che intreccia vita privata e spettacolo pubblico. Ciascuno a suo modo è il secondo capitolo della trilogia del “teatro nel teatro”, composta da Sei personaggi in cerca d’autore e Questa sera si recita a soggetto.
Il libro di Luigi Pirandello prende spunto da un fatto di cronaca. Il suicidio del giovane pittore Giorgio Salvi, che si toglie la vita dopo aver scoperto il tradimento della sua promessa sposa, Delia Morello, innamorata del futuro cognato Michele Rocca. Una vicenda privata che diventa subito materia di scandalo, pettegolezzo, giudizio sociale.
La scena della frase avviene nel primo atto, che si apre nel salotto borghese di casa Palegari, dove si discute animatamente del diverbio scoppiato il giorno prima tra Doro Palegari e Francesco Savio. Doro aveva difeso Delia, Savio aveva sostenuto le ragioni dell’uomo tradito.
Ma le posizioni improvvisamente si ribaltano, generando un paradosso che esaspera Doro fino all’insulto al’amico Safio, apostofato come “Pulcinella”. Proprio in quel momento entra in scena Delia, decisa a ringraziare Doro Palegari di averla difesa, ma segnata da un’inquietudine che tradisce una presa di coscienza sul suo ruolo nella tragedia. È in questo scenario che pronuncia la celebre frase sull’umanità, capace di spostare il discorso dal piano della cronaca a quello universale.
La frase di Luigi Pirandello tra giudizio individuale e rispetto degli altri
Dentro questa costruzione complessa, la frase di Delia Morello spicca per forza e ambiguità. Non è un aforisma isolato, ma una reazione a un contesto di accuse, sospetti e maldicenze. È la difesa di una donna travolta dallo scandalo, ma anche una riflessione che trascende la sua vicenda personale.
Amare l’umanità, dice Delia, significa innanzitutto essere contenti di se stessi. Non c’è amore per gli altri se prima non si raggiunge una forma di riconciliazione interiore. È un pensiero che sembra anticipare temi della psicologia contemporanea: l’autenticità e l’autoaccettazione come condizioni per relazioni sane e sincere.
Pirandello mette così in tensione due dimensioni opposte. Da un lato, il giudizio individuale, il bisogno di trovare dentro di sé un equilibrio indipendente dagli altri. Dall’altro, il rispetto degli altri, che non può essere cancellato, perché ogni coscienza si forma e si misura inevitabilmente nello sguardo sociale.
È proprio in questa frattura che si colloca la battuta di Delia. È un gesto di difesa personale che, inserito nel gioco pirandelliano, diventa anche una maschera, un modo per ribaltare ma non dissolvere il potere del giudizio collettivo.
La coda finale, quel “Pienissimo di questo amore – oh, felice!”, introduce un tono ironico e quasi grottesco. L’umanità di Delia è un amore che rischia di trasformarsi in autocompiacimento, un narcisismo che si traveste da sentimento universale. Pirandello lascia volutamente aperta la domanda: è una rivelazione o una beffa? Una conquista o l’ennesima maschera?
Il pensiero che muove Delia nasce da una condizione più profonda. I suoi tradimenti, così come l’inquietudine che la attraversa, derivano dal fatto che tutti sembrano interessati a lei soltanto per il corpo, mai per la coscienza, mai per la sua interiorità. Gli uomini la guardano, la desiderano, la giudicano, ma non si chiedono chi sia davvero.
La sua reazione, la frase sull’umanità, è allora il tentativo disperato di vedere riconosciuta la sua persona per quello che è, al di là delle apparenze. Ma dentro il gioco pirandelliano Delia finisce per cadere nello stesso paradosso che denuncia: nel momento in cui rivendica la centralità della propria coscienza, si concentra solo su di essa, mostrando lo stesso egocentrismo che rimprovera agli altri.
La voce di Doro Palegari, che smaschera la fragilità del giudizio
La figura di Doro Palegari è fondamentale nella riflessione che sviluppa Luigi Pirandello. Doro incarna il luogo stesso in cui il giudizio si forma, si ribalta e si dissolve, agendo come catalizzatore delle tensioni sociali. È il personaggio che porta in scena la logica contraddittoria del pettegolezzo e della discussione borghese.
Doro Palegari non è un personaggio ambiguo né oscillante: la sua posizione è chiara e netta. È colui che si espone con forza, difendendo Delia Morello non per convenienza, ma perché percepisce l’ingiustizia del linciaggio morale che la circonda. Proprio questa fermezza diventa l’elemento che incrina il meccanismo del giudizio sociale. Doro rivela che ogni opinione, dietro la maschera della moralità, è mossa da interessi personali, da calcoli di opportunità, da egoismi nascosti.
La scena con Francesco Savio è decisiva. Qui si misura la contraddizione del giudizio collettivo. Savio, che la sera prima aveva sostenuto con fermezza le ragioni dell’uomo tradito, cambia improvvisamente atteggiamento, ritirando la sua condanna. Non per un’autentica revisione di coscienza, ma per mera convenienza, per non compromettere la sua amicizia con Doro. È in questo rovesciamento che la rabbia di Palegari esplode: lo insulta chiamandolo “Pulcinella”, simbolo di incoerenza, figura che rappresenta la leggerezza e la falsità del giudizio che oggi condanna e domani assolve.
Il ruolo di Doro, dunque, non è quello del difensore fragile che si lascia trascinare dalle contraddizioni, ma del personaggio che, con la sua coerenza, porta allo scoperto la natura arbitraria del giudizio sociale. In lui Pirandello mostra come il giudizio, se fondato su calcoli di opportunità e non su autentica convinzione, si trasformi in barbarie, in un atto che non rivela la verità ma la maschera. È proprio grazie a questa funzione che le parole di Delia sull’umanità acquistano forza: emergono da un contesto in cui il giudizio non solo ferisce, ma rivela la sua intrinseca inconsistenza.
Il ruolo della coscienza nella voce di Diego Cinci
Il vero cuore del pensiero pirandelliano sul senso dell’umanità prende vita attraverso Diego Cinci, filo rosso che collega l’inizio e il cuore del dramma. Già all’inizio del primo atto, discutendo nel salotto Palegari, Diego sposta l’attenzione sul tema della coscienza, che sta alla base di ogni giudizio.
Non si può non considerare che l’umanità preveda la comprensione degli altri. Ecco perché il ruolo della coscienza è determinante. Diego afferma che non si può mai parlare di una coscienza “nostra” in senso assoluto, perché essa è sempre contaminata dal giudizio esterno. “Tu credi che la tua coscienza sia tua? Non è vero. È fatta degli sguardi che ti pesano addosso, delle voci che ti giudicano.” Non è un faro autonomo, ma un tribunale collettivo che abita ogni individuo.
In un altro passaggio Diego osserva: “Tu ti fidi della tua coscienza perché non vuoi sentirti solo. E allora ti figuri che altri, al tuo posto, avrebbero fatto come te.” È un meccanismo di auto-consolazione: immaginiamo che le nostre azioni siano condivise dagli altri, ma in realtà restano chiuse nella singolarità di ogni esperienza.
Queste riflessioni preparano la battuta più celebre del secondo atto:
“Finché crediamo che l’umanità consista nella così detta coscienza – o nel coraggio che abbiamo dimostrato una volta, invece che nella paura che ci ha consigliato tante volte d’esser prudenti…”
Qui Diego porta a compimento la sua visione: la coscienza non è segno di autenticità, ma un gioco che ci illude di essere migliori di ciò che siamo. Esaltiamo un atto di coraggio e dimentichiamo le innumerevoli volte in cui la paura ha guidato le nostre scelte. La coscienza diventa un meccanismo di difesa dalla solitudine, che inventa un consenso immaginario per non lasciarci soli con le nostre colpe.
La sua voce diventa il contrappunto necessario a quella di Delia. Lei parla di un’umanità che nasce dalla pace con se stessi; lui smonta la possibilità di una coscienza autentica. Due prospettive che non si annullano, ma si richiamano, offrendo l’immagine di un’umanità sempre divisa tra aspirazione e illusione, tra bisogno di autenticità e paura di guardarsi davvero dentro.
Il vero senso dell’umanità tra individuo e società
Luigi Pirandello, attraverso Delia Morello, Diego Cinci e Doro Palegari, non consegna due verità contrapposte ma la rappresentazione di una tensione che appartiene ancora alla nostra società. Da un lato, la necessità di un riconoscimento individuale, il bisogno di vedersi per ciò che si è davvero e non per come gli altri ci riducono. Dall’altro, la consapevolezza che nessuna coscienza è mai del tutto “pura”, perché abita sempre dentro un orizzonte di giudizi e sguardi esterni.
Il dialogo che Pirandello costruisce è attualissimo. Oggi il giudizio sociale non passa più soltanto per i salotti borghesi o i corridoi di teatro, ma per i social network, piazze digitali in cui l’identità si misura a colpi di like, commenti e reputazioni pubbliche. È lì che la coscienza individuale viene destabilizzata, esposta a un confronto permanente con l’approvazione o la condanna degli altri.
La frase di Delia, che lega l’amore per l’umanità all’essere contenti di sé stessi, anticipa il dibattito contemporaneo sull’autenticità e sull’auto-accettazione. Ma il sarcasmo di Diego ci mette in guardia dal ridurre questa ricerca a un rifugio individualista: la coscienza non basta mai da sola, è un gioco che ci illude di essere liberi mentre restiamo dipendenti dal consenso esterno.
L’umanità, per Pirandello, non è un concetto astratto né un ideale consolatorio. È il risultato instabile dell’incontro tra individuo e società, tra desiderio di autenticità e inevitabile dipendenza dagli altri. Guardarsi dentro non basta, perché non siamo mai soli. Eppure senza questo esercizio di coscienza, fragile, illusorio, condiviso, non potremmo nemmeno tentare di definire chi siamo.
In questo paradosso sta la modernità di Luigi Pirandello. L’umanità è allo stesso tempo ricerca di sé e specchio sociale, equilibrio interiore e maschera esteriore, libertà e condizionamento. Amarla significa accettarne le contraddizioni, riconoscere che non esiste al di fuori del giudizio degli altri e che proprio in questo spazio instabile si gioca la possibilità, fragile e provvisoria, di essere davvero uomini.