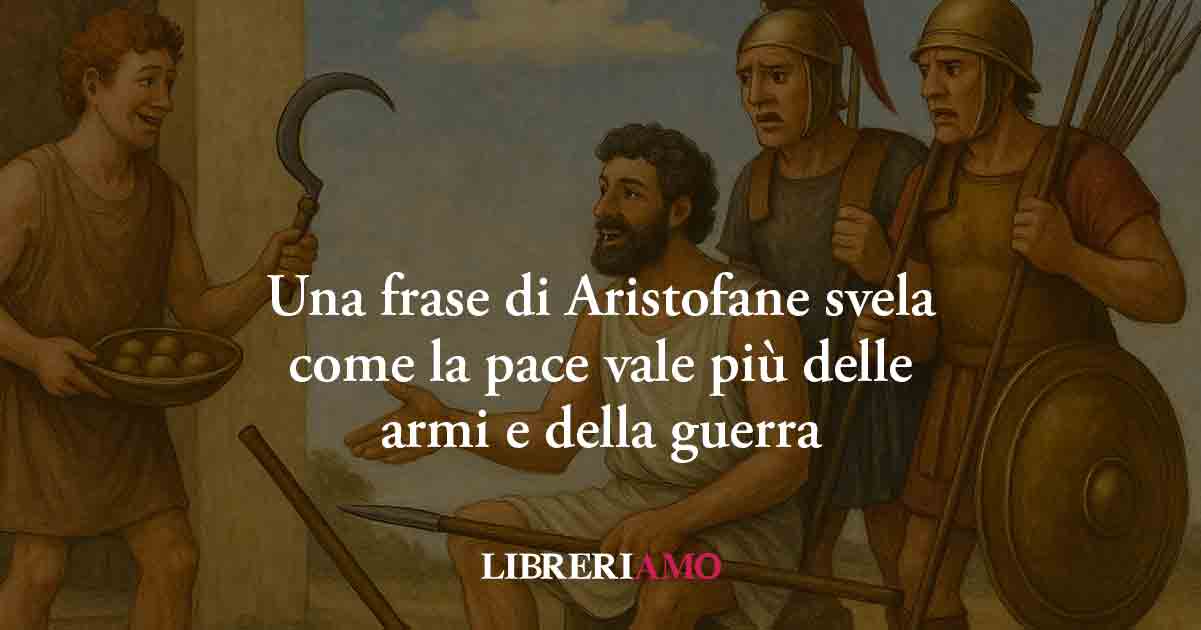C’è una frase di Aristofane che attraversa i secoli come una piccola verità pratica: letta nel tempo difficile che viviamo, offre una lezione che dovremmo prendere sul serio. Le armi sono strumenti di distruzione; la pace è invece la condizione che permette alla vita di prosperare per il maggior numero di persone. Il potere della pace ha un valore collettivo e duraturo che supera di gran lunga quello effimero della guerra.
Il dialogo che il commediografo greco mette in scena è semplice e terribilmente efficace. Non è retorica, è pratica. È la satira che diventa politica popolare, è la risata che smaschera gli interessi che vivono dei conflitti. È un messaggio che parla a tutti: cittadini, intellettuali, politici.
TRIGEO: E, no che a lui gli compero le lance!
MERCANTE D’ARMI: E quanto m’offri?
TRIGEO: Se le sega per mezzo, glie le pago una dramma ogni cento: ci farei dei pali per le viti!
In questa citazione di Aristofane c’è un programma civico, trasformare gli strumenti di morte in sostegni per la vita. Trigeo offre in modo ironico un’idea di come riciclare le armi. Taglia la lancia e la rende utile alla coltura della vite. Abbatte la funzione simbolica bellica e quindi distruttiva, restituendola al lavoro, alla cura, al futuro, alla pace. È un atto che smonta la retorica del profitto bellico e rimette il valore dove conta davvero nella cura dei bisogni primari degli umani.
Il contesto storico che dà vita alla frase di Aristofane
Lo stralcio del dialogo è tratto dalla parte terza di una delle sue commedie più celebri di Aristofane, La pace (Εἰρήνη) . Il titolo trae il nome da Eirene, dea della pace. L’opera fu messa in scena per la prima volta nel 421 a.C. alla vigilia della pace di Nicia, che pose fine (anche se solo per breve tempo) alla guerra del Peloponneso tra Atene e Sparta.
Per un periodo, i Greci credettero davvero nella possibilità di un futuro pacifico. Ma la tregua si rivelò presto illusoria. Pochi anni dopo, la guerra riprese, svelando quanto fosse fragile la fiducia negli uomini e nei loro accordi.
La trama de La Pace di Aristofane
In questo contesto sospeso tra fiducia e disincanto, Aristofane scrive una commedia che segna una svolta nella sua poetica, consegnando all’umanità un manifesto sulla pace.
Il protagonista, Trigeo, un umile vignaiolo, decide di raggiungere l’Olimpo per chiedere agli dèi di fermare la guerra. Per farlo, alleva uno scarabeo gigante nutrito con sterco, che diventa il suo bizzarro mezzo di trasporto verso il cielo. È un’immagine simbolica e comica al tempo stesso. Un uomo semplice, spinto dal desiderio di pace, che osa volare verso gli dèi su un animale nato dalla terra e dal lavoro.
Giunto sull’Olimpo, Trigeo scopre che gli dèi hanno abbandonato l’umanità, lasciandola nelle mani di Polemo (la Guerra) e del suo servo Tumulto. Il loro piano è folle, distruggere le città greche gettandole in un grande mortaio. Ma quando Polemo si allontana, Trigeo raduna i Greci per liberare Eiréne, la dea della Pace, rinchiusa in una grotta.
Solo i contadini, rappresentanti del popolo laborioso, riescono nell’impresa, ricordando che a loro appartengono la forza e la concordia necessarie per riportare la serenità. Liberata la Pace, vengono liberate anche Opora (l’Abbondanza) e Teoria (la Festa), simboli del ritorno alla vita serena, alla fertilità e alla gioia.
La commedia si chiude con un matrimonio e una festa campestre, il trionfo della vita quotidiana sulla follia della guerra.
È in questo clima e in questo contesto che nasce la celebre scena con il mercante d’armi, accompagnato da un “collega”, disperato perché, finita la guerra, nessuno compra più lance ed elmi.
Trigeo lo deride con ironia contadina e buon senso, facendosi scherno dei loro strumenti di morte, con un linguaggio che ancora oggi appare attuale, ironico e satirico. In un attimo, la retorica eroica e bellica si dissolve nel gesto pratico della quotidianità che non ha nessun bisogno delle armi. Anche il loro riciclo finisce per non dare i risultati sperati.
La geniale attualità della frase di Aristofane
La frase di Aristofane prende vita nella terza parte de La pace. La scena è quella del banchetto nuziale che dà vita ad una potente parabola sull’economia della guerra e sull’intelligenza della pace. Aristofane fa entrare due figure simboliche, da una parte il mercante di falci e di secchie, dall’altra i mercanti d’armi.
Nel mezzo, Trigeo si muove con la disinvoltura di chi sa riconoscere la vera utilità delle cose e degli uomini.
Il mercante di falci arriva allegro e riconoscente. Si avvicina a Trigeo con gratitudine: “Prima non arrivavo a vendere una falce, neppure per un soldo! Ora le vendo per cinque dramme”. La pace, insomma, ha riattivato il lavoro, ha rimesso in moto il mercato e la vita. Condivide persino i frutti del suo guadagno: “Abbiamo prelevato dal frutto della vendita questi regali per le nozze tue!”. È un momento luminoso per le persone, la produzione torna utile, la ricchezza torna circolare, la festa diventa il simbolo di una comunità che si ritrova.
Il tono e l’approccio cambia improvvisamente con l’arrivo dei mercanti d’armi, carichi di elmi, corazze, lance e trombe. Uno di loro irrompe gridando: “Trigeo, m’hai messo in mezzo a una strada!”, e in quella frase c’è già tutto, ovvero la disperazione di chi prosperava sulla guerra e non sa vivere di pace. Il tono si fa patetico, ossessivo. Il mercante mostra i cimieri e si lamenta: “Oh, questo usbergo a garbo? Dieci mine valeva! Guarda un po’ come combacia!”. Trigeo lo zittisce con l’ironia del coltivatore che conosce il mondo meglio dei potenti e, con un gesto teatrale, trasforma la corazza in oggetto domestico: “Cedilo a me, pel prezzo che ti costa: ché per cacarci pare fatto apposta!”.
Da quel momento, ogni arma viene reinterpretata e ridicolizzata. Gli elmi diventano spolverini da tavola, “Mi può servire a spolverare il tavolo!”, la tromba si trasforma in un utensile agricolo, “Versa un po’ di piombo nella campana e ti diventa un còttabo perfetto”, e perfino i caschi si possono rivendere “in Egitto, per misurar sirmea”.
In questa catena di invenzioni, Aristofane fa qualcosa di straordinario. Smonta la retorica della guerra con la forza del riso, e mostra come la creatività contadina valga più della tecnica militare. Tutto culmina nella battuta più celebre, quella che chiude la scena e concentra il senso di tutta la commedia:
Se le sega per mezzo, glie le pago una dramma ogni cento: ci farei dei pali per le viti!.
È una frase apparentemente comica, ma in realtà contiene una visione del mondo. Trigeo smonta tutta la forza, il potere, la tecnologia delle armi, svalutandone economicamente il loro valore e collocandoli come rifiuti da riciclare e riconvertire. Da strumenti di morte le armi in sostegni per la vita, ma non come essenziali, ma come qualcosa da adattare. Nella sua ironia, c’è una forma di intelligenza politica, la pace non è solo un’idea morale, ma una pratica concreta, fatta di gesti che cambiano il destino delle cose.
Mentre il mercante di falci incarna l’economia della pace, che genera lavoro, ricchezza condivisa e festa, il mercante d’armi rappresenta l’economia della guerra, sterile, chiusa, incapace di reinventarsi.
L’uno porta doni, l’altro pretende risarcimenti. L’uno ringrazia, l’altro accusa.
E nel mezzo, Trigeo ride e inventa. Suggerisce nuovi usi, nuove misure, nuovi sensi. È la saggezza del popolo che smonta la logica del profitto e restituisce dignità alle mani che producono per la vita.
Per questo la frase di Aristofane è di un’attualità sorprendente.