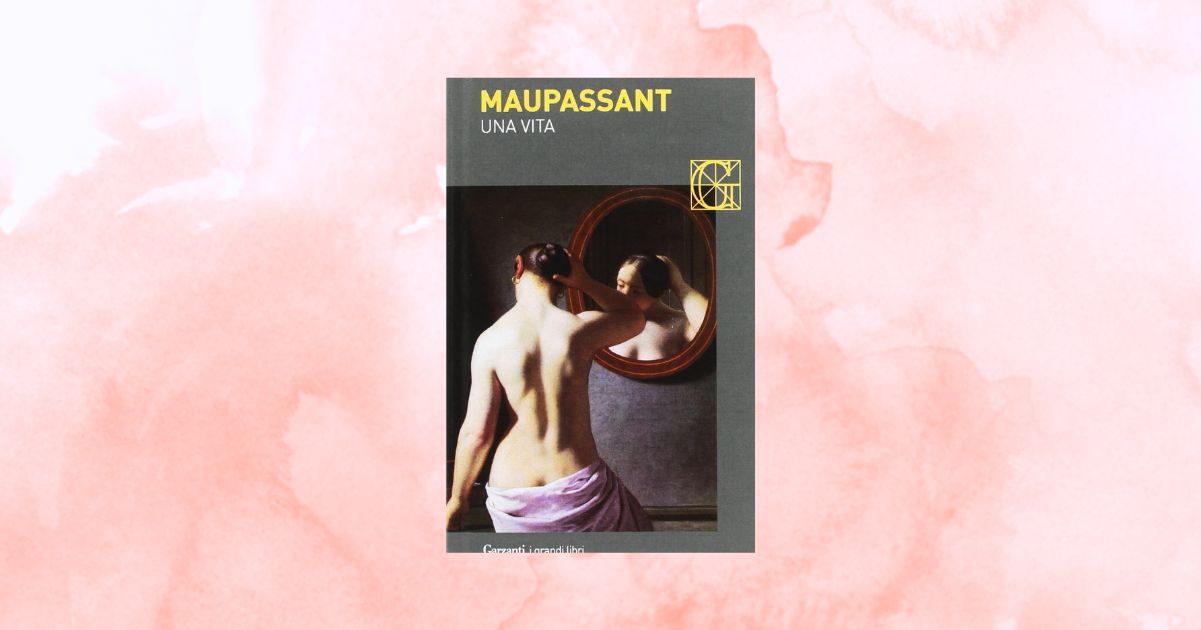MILANO – Per Carlo Bevilacqua fare fotografia non significa semplicemente documentare, ma è qualcosa di più: è il costruire una storia, il dare testimonianza, lo scoprire, attraverso l’obiettivo, realtà che non avremmo mai pensato potessero esistere. La sua é una fotografia che fa riflettere e che dimostra una grande passione, oggi più che mai necessaria per poter vivere di questo lavoro. Dopo aver descritto il suo ultimo reportage, per il quale ha ricevuto due menzioni d’onore all’International Photographic Awards 2011, fino ad arrivare alla prestigiosa partecipazione alla National Portrait Gallery di Londra per il Taylor Wessing Prize 2011, Bevilacqua esprime tutte le sue perplessità sulla situazione culturale italiana e riflette sul destino dei giovani fotografi, ai quali consiglia di aspirare ad un riscontro internazionale. Protagonista fino al 30 settembre del festival “Cortona on the move”, il reportage “Into the silence. Eremiti del III millennio” viaggerà, distribuito worldwide dall’agenzia ParalleloZero, prima a Singapore e successivamente a novembre sarà esposto al Turin Photo Festival.
Come è approdato alla fotografia? Quale è stato il suo percorso formativo?
Mi sono avvicinato alla fotografia in modo piuttosto casuale. A Palermo, dove sono nato, ho trascorso la mia adolescenza con amici che già avevano sviluppato questo interesse e grazie a loro ho iniziato ad occuparmene anch’io. Ero assolutamente inesperto, non conoscevo i grandi autori della fotografia, non ne avevo mai sentito parlare. Semplicemente fotografavo qua e là, il mio interesse per la storia della fotografia arrivò dopo. Prima dei vent’anni poi me ne sono andato, a Parigi per un brevissimo periodo, poi a Milano, dove ho fatto della fotografia la mia professione, dedicandomi al settore pubblicitario e della comunicazione. Alla fotografia ho poi associato la mia passione per la musica, iniziando ad occuparmi della realizzazione di filmati e videoclip per importanti gruppi.
Come è cambiato negli anni il suo approccio alla fotografia?
Quando ho iniziato a fotografare i miei erano solo scatti, immagini catturate qua e là, senza un’intenzionalità particolare. Quello che sento che è cambiato nel corso della mia carriera è il passaggio dall’immagine alla storia. E’ fondamentale per me ora cercare una storia dietro ad ogni soggetto che fotografo.
Quest’anno il Festival “Cortona on the move” ha voluto come tema principale il viaggio, declinato in tutte le sue forme. Lei ha partecipato con “Into the silence”, uno studio sugli eremiti del III millennio, sulle loro condizioni di vita e sulle scelte che li hanno spinti ad intraprendere questo cambiamento così radicale. In che modo è nato questo progetto?
In realtà in maniera piuttosto involontaria. Era un’idea che avevo, molto nebulosa, nella mia mente. Come ogni volta si presentava piuttosto vaga, stava poi a me trovare un modo adatto per svilupparla; e questa è sempre la parte più difficile. Qualche anno fa mi trovavo, un po’ per lavoro un po’ per vacanza, a Filicudi, alla ricerca di una storia per sviluppare un’idea che avevo in mente, ma che non aveva ancora preso completamente forma: quella di occuparmi di persone che, attraverso una scelta radicale, avevano deciso di abbandonare tutto e di rifugiarsi in luoghi solitari e incontaminati. Proprio lì un amico mi raccontò la storia di Gisbert Lippelt, un ex ufficiale di nave da crociera che ormai 35 anni fa decise di abbandonare la sua carriera e di isolarsi in una grotta (scavata con le sue mani) senza elettricità né acqua corrente, e senza nessun’altro confort. Questo è stato l’inizio del mio progetto. Si è poi evoluto grazie all’incontro con la scrittrice Espedita Fisher, che da poco ha pubblicato il suo libro “Eremiti”, proseguendo infine in piena autonomia. Ad oggi esso racchiude una ventina di storie di persone provenienti da tutto il mondo, Francia, Italia, Inghilterra, Stati Uniti e India, che hanno compiuto una scelta simile a quella di Lippelt.
Si può dire che “Into the silence” sia un reportage fotografico dalla forte impronta sociale e antropologica, nel quale vengono mostrati aspetti della società ai quali molte volte non viene prestata la dovuta attenzione. Quali riflessioni nascono dietro ad uno scatto? Quali finalità ci si propone?
Il mio modo di fare fotografia documentaristica consiste nel soddisfare la mia intenzione di creare una storia attorno al personaggio che voglio raffigurare, una storia che sia capace di racchiudere tutti quegli elementi che sono in grado di raccontarlo all’interno di un’immagine, senza mai però discostarmi dalla realtà e dal contesto. Mi ritrovo quindi dapprima a contemplarlo, in modo tale da capire come mi è possibile raccontarlo, per poi documentarlo attraverso ciò che lo circonda, per esempio. E’ proprio quello che ho cercato di fare con Gisbert Lippelt: nel suo caso non mi sono soffermato solo sul suo ritratto, ma ho raccontato dove e come vive, le sue abitudini, il suo essere un ambientalista ante-litteram.
Secondo lei quale spazio ha la fotografia all’interno del panorama culturale italiano?
Questo è sicuramente un buonissimo momento per la fotografia: lo testimoniano le tante rassegne, i festival, le mostre. Si presenta solo un problema, che non può essere trascurato: la difficoltà da parte di noi fotografi di avere un riscontro economico. E questo per due ragioni fondamentali: da una parte abbiamo delle istituzioni sostanzialmente assenti, che non investono minimamente nella fotografia, ma in generale nella cultura, soprattutto nell’ultimo periodo. Sembra che la regola generale sia diventata quella di autofinanziarsi e andare avanti solo grazie alle proprie passioni. L’altra ragione fondamentale è l’assenza di collezionismo: pochi sono quelli disposti ad acquistare i lavori, considerandoli dei veri e propri oggetti d’arte. La soluzione – se di soluzione si può parlare – è quella di inserirsi all’interno di un contesto internazionale: pensare in modo internazionale quando si crea un progetto personale e imparare a promuoversi all’estero.
A proposito dei suoi lavori passati: a quali è più affezionato?
A quello che verrà. Ho in mente di sviluppare il lavoro sull’ermetismo, attraverso una ricerca sulle utopie realizzate. Mi piacerebbe occuparmi di quelle società autogestite, comunità autonome e utopiche, che proclamano tenacemente la propria indipendenza rispetto al governo nel quale sono inserite e si fanno portavoce di una dimensione della vita sostenibile ed ecologica. Ve ne sono in Europa, per esempio la Città Libera di Christiania a Copenhagen, ma anche nel mondo, con la città “sperimentale” di Auroville, in India.
23 settembre 2012