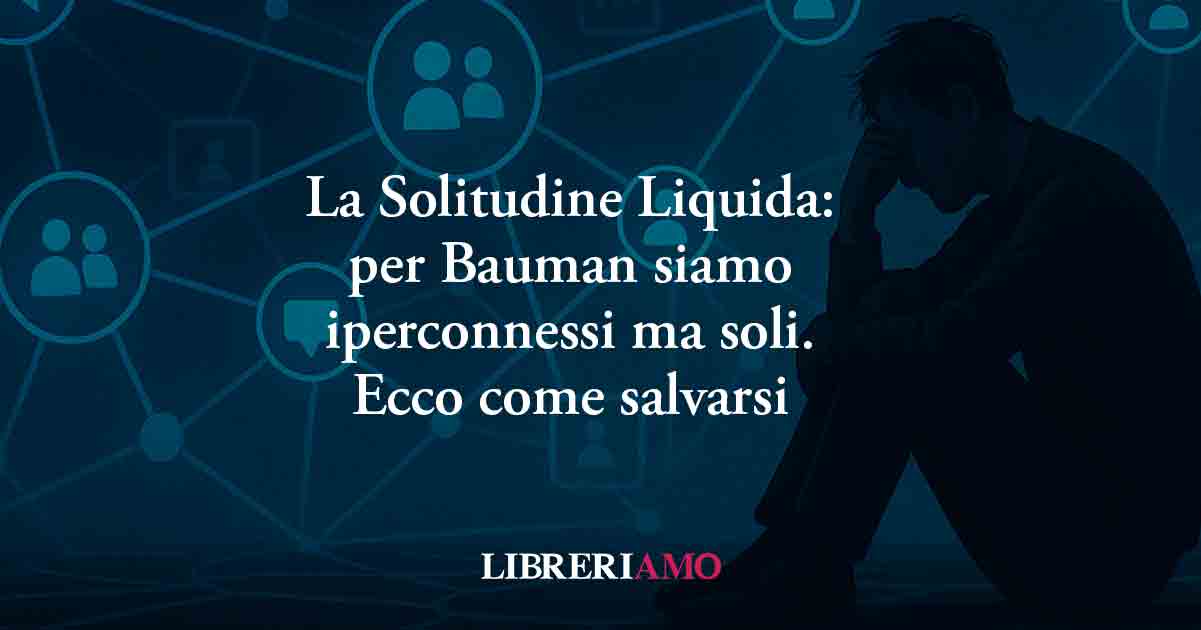Viviamo in una società iperconnessa. Le nostre vite sono un flusso costante di contatti, gruppi, interazioni e commenti. Siamo raggiungibili sempre, ovunque, eppure da questo rumore digitale emerge una sensazione dominante: siamo sempre più soli.
Siamo vittime di un paradosso. L’epoca della connessione totalizzante coincide, di fatto, con quella del massimo isolamento. A questa condizione, che caratterizza la nostra epoca, abbiamo dato un nome, ovvero Solitudine Liquida, facendo riferimento al genio di Zygmunt Bauman e a diverse ricerche che dimostrano come la modernità liquida stia generando la percezione di un diffuso isolamento.
Sia chiaro che anche il concetto di solitudine si sta trasformando, non è l’assenza di persone con cui dialogare, ma è il vuoto che si prova nonostante la presenza di mille connessioni.
Bauman nelle sue opere ha descritto un mondo dove ogni legame solido (lavoro, comunità, relazioni) è stato sciolto, reso precario e temporaneo. Ecco perché cerchiamo nel suo pensiero e in quello di altri grandi pensatori contemporanei gli strumenti per la cura. Ma per capire come salvarci, dobbiamo prima capire come ci siamo ammalati.
La solitudine liquida il male della società iperconnessa
Il nostro concetto di “Solitudine Liquida” si fonda direttamente sulla diagnosi che Zygmunt Bauman ha fatto della società. Non è un’iperbole. Seguendo il suo pensiero, lui ha descritto un sistema in cui i legami umani non possono che sciogliersi.
Il punto di partenza è il suo saggio-capolavoro, Modernità Liquida (Editori Laterza, 2000). Qui, Bauman spiega che siamo passati da una società “solida” (con certezze: il lavoro fisso, la comunità stabile) a una “liquida”.
La “modernità solida”, scrive, era un’epoca in cui le strutture erano date per “durevoli”. La nostra, invece, è definita dalla sua fluidità. È l’epoca, dice Bauman, dello “scioglimento dei solidi“.
Ma quali sono, esattamente, questi “solidi” che si sciolgono? Bauman è esplicito. Sono i legami, le relazioni interpersonali, ovvero le fondamenta della nostra vita collettiva:
I solidi che si stanno ‘scioglendo’ nel momento presente […] sono i legami, interpersonali e collettivi, tra scelte individuali e progetti e azioni collettive.”
(Zygmunt Bauman, Modernità Liquida)
Cosa significa, in parole semplici? Bauman sta dicendo che a sciogliersi non sono solo le cose materiali (come il “posto fisso”), ma le strutture di fiducia che ci tenevano insieme.
Si sciolgono i legami interpersonali (la fiducia che un’amicizia o una relazione duri nel tempo) e i legami collettivi (il senso di appartenenza a una comunità, a un quartiere, a un’azienda).
Il punto cruciale è che è crollato il ponte tra l’individuo e il gruppo. Nella società “solida”, un problema individuale (come la disoccupazione) poteva diventare un’azione collettiva (uno sciopero). Nella società “liquida” di Bauman, i problemi vengono “privatizzati”, ovvero se sei solo o in difficoltà, è un tuo problema da risolvere individualmente.
Ecco il punto. La “Solitudine Liquida” è la conseguenza diretta di questa evaporazione dei legami e di questa privatizzazione dell’ansia. In un mondo dove, come afferma lui, “il cambiamento è l’unica cosa permanente e l’incertezza l’unica certezza”, ogni impegno solido (un lavoro a vita, un legame a vita) non è visto come una sicurezza, ma come un rischio.
Bauman ha dedicato un libro intero, Amore Liquido: Sulla fragilità dei legami affettivi (Editori Laterza, 2004), per approfondire questa specifica conseguenza. È qui che conia la distinzione cruciale che definisce la nostra solitudine. Terrorizzati dall’impegno “solido”, preferiamo le “connessioni”:
I legami sono stati sostituiti dalle ‘connessioni’. Mentre i legami richiedono impegno, ‘connettere’ e ‘disconnettere’ è un gioco da bambini.
(Zygmunt Bauman, Amore Liquido)
Ecco come si è diventati sempre più vittime di questa nuova forma di solitudine dilagante. La “Modernità Liquida” ha sciolto i legami interpersonali, e la nostra società iperconnessa ci ha dato lo strumento perfetto (la “connessione”) per evitare di ricostruirli.
Le ricerche e i numeri che confermano che la Solitudine è realtà
Molte ricerche confermano che la “Solitudine Liquida” è uno dei problemi che emerge nella nostra società. La diagnosi di Bauman non era una profezia, ma una descrizione, una rappresentazione di ciò che si è affermato.
Il dato globale sulla solitudine
Il Cigna Healthcare Vitality Index (l’evoluzione del Loneliness Index) è un report globale che misura il benessere.
I dati più recenti sono inequivocabili. Il report di Cigna “Loneliness in America” (dati raccolti a Maggio-Giugno 2024), quindi ampiamente post-pandemia, mostra che il problema è strutturale:
- Il 57% degli americani adulti si sente solo.
- Il 52% dei lavoratori si sente solo.
Il paradosso che conferma la tesi è generazionale: la Generazione Z e i Millennial, pur essendo le generazioni più iperconnesse della storia, continuano a registrare i tassi di solitudine più alti (dati del 2023 indicano il 71% per la Gen Z) rispetto ai Baby Boomer (44%).
Il tempo della connessione
Il problema è la quantità del nostro tempo “liquido”. Secondo gli ultimi report globali, come DataReportal, l’utente medio di Internet a livello mondiale passa quasi 7 ore al giorno online. Passiamo ore su WhatsApp, social media e piattaforme di lavoro. Ma questo tempo, come avvertiva Bauman, è dedicato a “connettere e disconnettere”, non a “creare legami”.
“Insieme ma soli”
Sherry Turkle, psicologa del MIT, ha fornito le prove empiriche di questo paradosso. Nel suo libro Insieme ma soli: Perché ci aspettiamo di più dalla tecnologia e meno gli uni dagli altri (Codice Edizioni, 2012), dimostra come la tecnologia ci illuda. Preferiamo un messaggio su WhatsApp a una telefonata, e una chat a un incontro faccia a faccia, perché, scrive:
Ci aspettiamo sempre più dalla tecnologia e sempre meno dagli altri.
Turkle dimostra che la tecnologia ci permette di controllare l’interazione: la puliamo, la editiamo, la gestiamo. Ma in questo modo, evitiamo la “confusione” e la “fatica” dell’autentico legame umano.
Lo Smart Working e la “Comunità-Guardaroba”
Lo smart working e il co-working sono l’incarnazione perfetta della “Modernità Liquida”. Il lavoro si è sciolto dal luogo fisico. Il co-working, in particolare, è ciò che Bauman chiamava la “comunità-guardaroba” (cloakroom community): un luogo dove si sta insieme ma soli. Si condivide uno spazio (e un Wi-Fi), non un destino o un impegno reciproco.
Gli effetti della Solitudine alla Mente e al Corpo
La “Solitudine Liquida” non è un’astrazione filosofica. Non è una malinconia passeggera. È una condizione che ha conseguenze concrete e misurabili sulla nostra salute.
Sulla Mente. Il Burnout esplicitato dal filosofo Byung-Chul Han
La prima conseguenza è quella psicologica. Qui, il pensiero di Bauman si salda a quello di un altro filosofo cruciale, Byung-Chul Han.
Se Bauman descrive la società liquida, Han ne descrive il risultato sulla nostra mente: non siamo solo soli, siamo esausti.
Nel mondo liquido, siamo diventati “imprenditori di noi stessi”, costretti a performare 24/7 (sui social, sul lavoro). Non abbiamo più un “padrone” esterno che ci opprime; il padrone siamo diventati noi. Come scrive Han ne La società della stanchezza (Nottetempo, 2012):
In questa società costrittiva ciascuno porta con sé il suo campo di lavoro. La sua particolarità è che si è al tempo stesso prigionieri e guardiani, vittime e carnefici. Così ciascuno sfrutta se stesso.
Questa auto-sfruttamento ci isola (non c’è tempo per l’Altro) e ci porta al burnout, che è la malattia mentale della società iperconnessa.
Ma cos’è esattamente il burnout? Non è semplice stress. È una sindrome complessa (riconosciuta anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come un fenomeno legato al lavoro) che si manifesta in tre fasi:
1. Un esaurimento psicofisico totale
La sensazione di aver “finito la batteria” e di non avere più energie emotive o fisiche.
2. Un distacco emotivo e cinismo
Si diventa distanti dal proprio lavoro e, soprattutto, dai propri colleghi (che non sono più visti come alleati, ma come ostacoli).
3. Un crollo del senso di efficacia personale
La sensazione che nulla di ciò che si fa abbia più senso o valore.
Il burnout è, di fatto, la malattia mentale che nasce dall’incrocio perfetto tra la performance (Han) e la solitudine (Bauman).
Sul Corpo. L’Impatto Fisico secondo la medicina
Ma gli effetti non sono solo psicologici. La solitudine, come dimostrano decine di studi medici, attacca il corpo.
Secondo Vivek Murthy, ex viceammiraglio del Corpo di Sanità Pubblica degli Stati Uniti , che ha prestato servizio come 19° e 21° chirurgo generale degli Stati Uniti dal 2015 al 2017 e di nuovo dal 2021 al 2025, la solitudine cronica, ovvero la condizione “liquida” in cui i legami non si solidificano, è un fattore di rischio sanitario devastante.
- Vivere in solitudine cronica aumenta il rischio di morte prematura tanto quanto fumare 15 sigarette al giorno.
- È associata a un aumento quasi del 30% del rischio di infarto e ictus.
- Aumenta significativamente il rischio di demenza e declino cognitivo.
- Indebolisce il sistema immunitario, rendendoci più vulnerabili.
La “Modernità Liquida” teorizzata da Zygmunt Bauman evidenzia un ambiente sociale tossico, e la “Solitudine Liquida” è l’effetto fisico di quell’ambiente. Ci stiamo letteralmente ammalando per mancanza di legami solidi.
Come reagire alla Solitudine da iperconnessione. La via di Bauman
Se il problema è la “liquidità”, la cura non può che essere la “ri-solidificazione”. ZygmuntBauman, da grande filosofo e sociologo, non offre soluzioni facili (non c’è un’app per risolvere la solitudine liquida). Il suo rimedio è complesso, faticoso, ma è l’unico possibile. È un rimedio etico.
“Salvarsi” significa scegliere attivamente di costruire legami solidi in un mondo che ci spinge a essere liquidi. La proposta di Bauman, sparsa nelle sue ultime opere, si basa su tre pilastri.
1. Staccare la connessione. Iniziare a “Legarsi”
Il primo passo è la consapevolezza. Dobbiamo riconoscere quando stiamo trattando le persone come “connessioni” (oggetti di consumo da usare e gettare) e quando invece stiamo costruendo un “legame” (un impegno reciproco).
Significa resistere alla tentazione della “disconnessione facile” (il ghosting, l’abbandono di un progetto al primo ostacolo, il silenzio su WhatsApp). È una scelta.
2. Recuperare la voglia di dialogare
La connessione è veloce, binaria (like/no-like, muto/non-muto). Il legame, invece, si basa sul dialogo. Il dialogo, per Bauman, è l’unica salvezza. Ma avverte che il vero dialogo non ha nulla a che fare con le nostre “bolle” sui social media.
Come spiega nel libro-dialogo Conversazioni sull’educazione (Erickson, 2011), il dialogo è l’opposto della gratificazione istantanea:
Il vero dialogo non è parlare con gente che la pensa come te. […] il dialogo non è un caffè istantaneo, non dà effetti immediati, perché è pazienza, perseveranza, profondità.
Salvarsi significa avere la pazienza di affrontare il dialogo “scomodo”, quello che richiede fatica e che non dà gratificazione immediata.
3. Riconoscere il “Volto dell’Altro”
Questa è la radice etica più profonda del pensiero di Bauman, che riprende dal filosofo Emmanuel Lévinas. La vera salvezza dalla solitudine liquida è assumersi la responsabilità per l’Altro.
Significa vedere la persona reale dietro l’icona di Zoom, il profilo curato o l’avatar. Il “Volto” dell’altro è ciò che ci chiama a rispondere, ci impone un limite etico e ci costringe a uscire dal nostro narcisismo “liquido”.
La Solitudine Liquida, la crisi invisibile della nostra epoca
Viviamo in un tempo in cui la tecnologia ci ha dato tutto tranne la capacità di stare bene insieme. Abbiamo costruito un mondo connesso, ma non relazionale; istantaneo, ma non intimo; popolato da profili, ma povero di persone.
La “Solitudine Liquida” è la malattia morale e affettiva di questa condizione, Un disturbo collettivo che ci attraversa tutti, anche quando ci sembra di esserne immuni.
Zygmunt Bauman lo aveva intuito. La modernità liquida non è un incidente, ma una metamorfosi. È il passaggio dall’essere “connessi” all’essere “intercambiabili”.
In questo passaggio, il legame perde il suo peso specifico, diventa reversibile, aggiornabile, come tutto ciò che appartiene all’economia dell’attenzione. Così, la relazione da promessa è diventata una funzione. E la solitudine da esperienza interiore si è trasformata in sistema.
La tecnologia non è la causa, ma il sintomo. Ci illude di colmare il vuoto, mentre in realtà lo amplifica. Ogni notifica ci restituisce la sensazione di esistere, ma solo per un istante. Poi torna il silenzio. E in quel silenzio, molti scoprono che non mancano le persone, ma il senso.
È una crisi che non si cura con nuove app o con “disintossicazioni digitali” temporanee. Si cura ricostruendo i ponti etici che ci uniscono come esseri umani. Tornando a vedere nell’altro non un mezzo, ma un fine. Tornando a praticare la lentezza, la vulnerabilità, la responsabilità reciproca.
La Solitudine Liquida è la conseguenza di una società che ha sostituito la parola “insieme” con “connessi”. Ma l’antidoto non è il rifiuto della connessione, bensì il suo riscatto. Connettersi, oggi, deve significare prendersi cura.
Solo così potremo riscoprire la verità più semplice e dimenticata del nostro tempo: che non esiste felicità individuale senza una comunità affettiva che la sostenga. E che la vera libertà non è poter “disconnettere” chiunque, ma scegliere, ogni giorno, di restare.
In fondo, come avrebbe detto Zygmunt Bauman, la solidità non si trova tornando indietro, ma tornando in profondità. La vera sfida, la rivoluzione che ci chiede Bauman, è scegliere, ogni giorno, di usare questi strumenti per costruire ponti solidi. La vera salvezza, oggi, non è essere connessi. È essere impegnati.