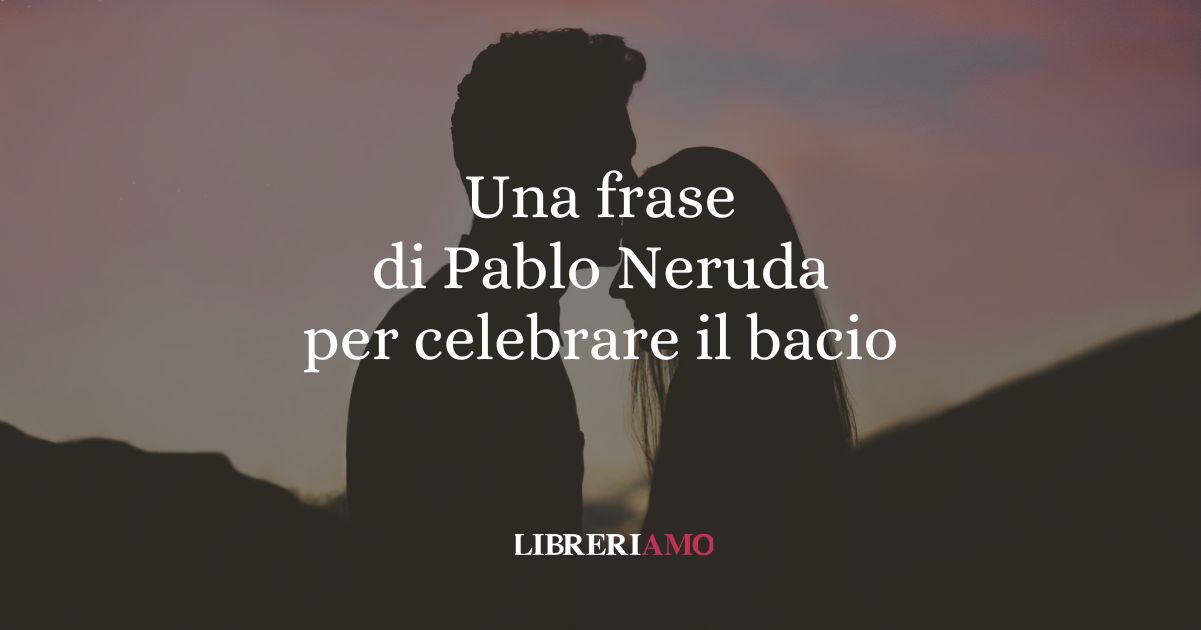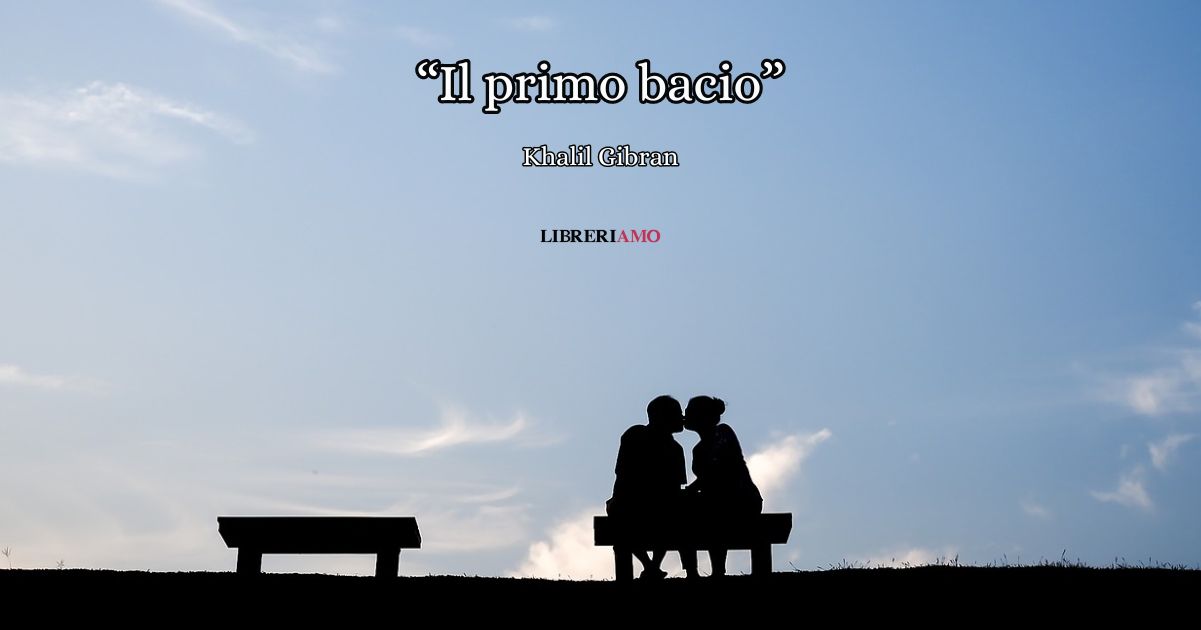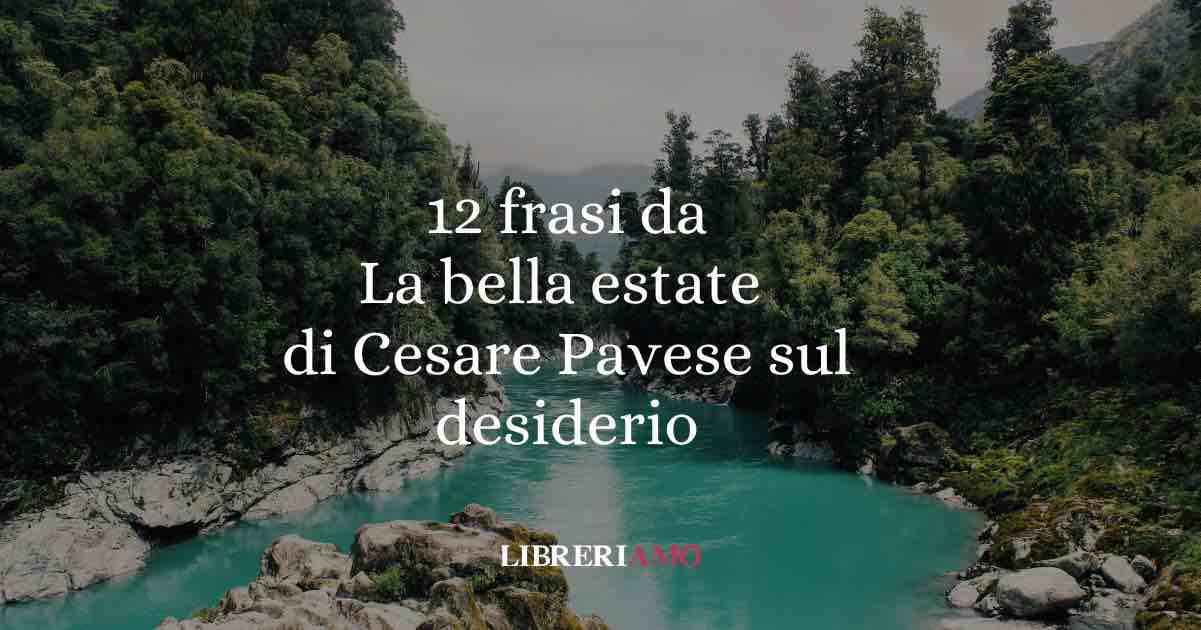“Quant’è bella giovinezza,
Che si fugge tuttavia!
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza’
(Lorenzo de’ Medici, Canti Carnascialeschi, Canzona di Bacco)
MILANO – Oggi il mondo della cultura, della politica e dell’arte, ricordano l’anniversario di morte di uno dei personaggi più noti del Quattrocento, Lorenzo il Magnifico. Politico, scrittore, mecenate e umanista italiano, signore di Firenze dal 1469 alla morte, appartenente alla dinastia dei Medici, Lorenzo fu uno degli uomini politici e degli intellettuali più rilevanti del rinascimento, poeta, statista e membro dell’Accademia neoplatonica.
Amante delle arti, amico di artisti e filosofi, espertissimo e raffinato letterato, talvolta anche genuinamente poeta, Lorenzo contribuì in primo piano al passaggio dell’umanesimo da latino in volgare, che è il fatto storicamente più notevole del secondo Quattrocento.
L’appellativo con cui Lorenzo de’Medici è passato alla storia, cioè quello di Magnifico, ha una forte connotazione filosofica che affonda le proprie radici nella cultura classica greca e latina. Delineata prima da Aristotele nella sua Etica eudemia e poi ripresa da Seneca nel De Vita Beata, la Magnificenza diventa la pratica dell’esercizio della ricchezza personale finalizzata allo sviluppo del bello e dell’utile per la propria comunità, come delineato già dal Ficino e da Cristoforo Landino. Pertanto, la promozione delle arti a Firenze e la sua politica di esportazione dei brillanti artisti, quali Leonardo da Vinci, era una politica di potenza e di splendore che accresceva l’importanza politica di Firenze.
INIZI – Nipote di Cosimo de’ Medici, detto il Vecchio, e figlio di Piero di Cosimo de’ Medici e di Lucrezia Tornabuoni, Lorenzo nacque il 1º gennaio 1449 a Firenze, nel Palazzo Medici Riccardi. Ricevette una profonda educazione umanistica ed un’accurata preparazione politica da maestri del calibro di Cristoforo Landino e Gentile de’ Becchi (per la letteratura volgare), Giovanni Argiropulo (per gli studi su Omero) e Marsilio Ficino (per la filosofia); la sua naturale predisposizione all’apprendimento e la sua grande intelligenza fecero sì che nel 1466, a soli diciassette anni, Lorenzo entrò a far parte della balia e del Consiglio dei Cento, predisponendosi così alla successione del padre che era di salute cagionevole. Già Cosimo il Vecchio, alla morte nel 1463 di Giovanni, suo secondogenito e zio di Lorenzo, era afflitto dal problema della sua successione. Infatti, vista la pericolante salute di Piero, soprannominato proprio per questo ‘il Gottoso’ (dal nome della malattia che lo affliggeva, la gotta), Giovanni era stato designato successore del padre alla guida del banco medici, lasciando invece la gestione dell’eredità politica (ritenuta meno onerosa) al primogenito Piero il Gottoso. Quando però Giovanni morì, pieno di stravizi, nel 1463, il problema della successione si era nuovamente sollevato a Cosimo, il quale ripose le sue speranze nei due nipoti, Lorenzo appunto e Giuliano, come aiutanti e successori del padre infermo. Pertanto, prima di morire, Cosimo raccomandò a Piero loro padre di non trascurare la loro educazione e di considerarli già come uomini, nonostante la loro giovane età.
SIGNORE DI FIRENZE E LA CONGIURA DEI PAZZI – Alla morte del padre, nel 1469, accettò ‘la cura della città e dello stato’, pur restando ufficialmente privato cittadino: da quel momento fu il vero signore di Firenze. Modificati in parte gli ordinamenti di Firenze, per acquistare più saldo e legale potere, divenne membro a vita del potenziato Consiglio dei Cento. Le relazioni col papa Sisto IV, buone fino alla guerra di Volterra (1472), voluta per rafforzare l’unità del dominio, finirono col guastarsi, per le mire di Girolamo Riario, nipote del papa, sopra Imola: fu allora che i Pazzi, rivali anche negli affari dei Medici, accordatisi con l’ambizioso Francesco Salviati, arcivescovo di Pisa, e ordita una congiura, consapevole il papa, uccisero in S. Maria del Fiore il 26 aprile 1478 Giuliano de’ Medici, mentre Lorenzo riuscì a porsi in salvo. La violenta reazione dei Fiorentini mentre Sisto IV lanciava la scomunica contro Lorenzo e l’interdetto contro la città, si tramutò in piena guerra, con l’appoggio di Venezia e di Milano contro il papa e il suo alleato Ferdinando di Napoli. La situazione, fattasi criticissima per Firenze, fu risolta da Lorenzo che, recatosi personalmente a Napoli (6 dic. 1479 – 15 marzo 1480), riuscì a staccare dalla lega nemica il re Ferdinando, costringendo così il papa alla pace. Il successo gli consentì una nuova modificazione degli statuti con incremento della sua potenza. Iniziò allora in Italia, dove era considerato il capo assoluto dello stato fiorentino, una politica di alleanza, di accordi, di equilibrio, rafforzando la sua posizione col rendersi amiche Lucca, Siena, Perugia e Bologna, acquistando Pietrasanta (1484), Sarzana (1487) e Piancaldoli (1488), ristabilendo una normalità di rapporti con Forlì e Faenza, dopo che ne erano stati uccisi i signori Girolamo Riario e Galeotto Manfredi, e soprattutto coltivando l’amicizia con Napoli. Durante la guerra di Ferrara (1482-84) si alleò con Ercole d’Este, il duca di Milano e il re Ferdinando per frenare le mire espansionistiche del papa e dei Veneziani, partecipando anche, come oratore ufficiale di Firenze, alla dieta di Cremona.
GLI AMICI INTELLETTUALI – La salute malferma, l’impegno politico, la cura continua degli affari della sua casa, per l’interesse economico della quale il tesoro pubblico finì col confondersi con le finanze private dei Medici, non gli impedirono di partecipare con gusto e fervore a quella vita tipicamente rinascimentale di cultura, di splendori e di feste, della quale in Firenze fu il solerte animatore. Intorno a lui si formò un circolo di poeti, di artisti, di filosofi che egli sovveniva e di cui era amico: i tre fratelli Pulci, soprattutto il maggiore Luigi, il Poliziano, il Verrocchio, il Pollaiolo, Giuliano da Sangallo, Filippo e Filippino Lippi, Sandro Botticelli, Ficino, Landino, Pico della Mirandola, Benozzo Gozzoli, Benedetto da Maiano, Mino da Fiesole, per ricordare solo alcuni.
GRANDE MECENATE E POETA – Certo il mecenatismo fu per Lorenzo anche arte di governo, oltre che sincero bisogno della sua anima. Ricche la sua biblioteca e la collezione di gemme, cammei, bronzi, statue. Per lui Giuliano da Sangallo costruì la villa di Poggio a Caiano e il castello di Poggio Imperiale. Da lui furono chiamati allo studio di Firenze e di Pisa i più famosi maestri di filologia, filosofia, diritto. Mai Firenze era apparsa così fervida di operosità di studî e d’arti come al suo tempo. Egli stesso, pur tra le molteplici cure di politica e di amministrazione, partecipò a siffatta operosità. La sua intensa attività letteraria fu non già subordinata ma congiunta, come disse Machiavelli, con l’attività politica.
Nel 1476 raccolse antiche rime, specie stilnovistiche, e le inviò a Federico d’Aragona con una lettera critica, quasi certamente opera del Poliziano. Negli anni successivi, probabilmente tra il 1482 e il 1484, raccolse 41 dei suoi sonetti, legandoli insieme con un Comento in prosa, a somiglianza della Vita Nuova: in questo narra come alla vista di una bellissima donna morta (Simonetta Cattaneo) gli si accendesse in cuore il desiderio di un altissimo amore e come dopo qualche tempo s’innamorasse di una donna ancor più bella e gentile dell’altra (Lucrezia Donati).
IL NEOPLATONISMO – Rime e commento sono ispirati alle idee dell’amor platonico filtrate attraverso Petrarca, Landino, Ficino, ma non mancano notazioni psicologiche e motivi poetici originali. Una disputa filosofica con Ficino sul sommo bene sono i 6 faticosi capitoli dell’Altercazione, scritta, almeno nella sua prima redazione, intorno al 1473-74. E un concetto platonico dell’amore è anche alla base delle due vivaci Selve d’amore composte, con ogni probabilità, dopo il 1486: specialmente nella seconda abbondano elementi figurativi e realistici.
LORENZO LETTERATO – Da Ovidio e dal Ninfale fiesolano di Boccaccio trae origine il poemetto Ambra anch’esso composto dopo il 1486, in cui si narra come la ninfa Ambra, amata dal pastore Lauro, inseguita dal fiume Ombrone, sul punto d’esser raggiunta, è trasformata in una rupe, quella su cui sorgeva la villa medicea di Poggio a Caiano. Tutto ricalcato sui classici, ma originariamente rivissuto, è il Corinto, anch’esso scritto forse intorno al 1486, lamento rusticano in terzine in cui il pastore Corinto invita la riluttante Galatea ad amare, perché la giovinezza presto fugge: nella chiusa è la famosa descrizione di un roseto in fiore. Idillio rusticano è la Nencia da Barberino scritta quasi certamente prima del 1470, di cui alcuni gli hanno negato la paternità: qui, però, il modello non è più letterario e classico, ma popolaresco. Ricca di scenette e figure dal vero è l’Uccellagione di starne, essa pure composta assai probabilmente nella prima giovinezza e più nota col titolo di Caccia col falcone; e opera giovanile è anche il Simposio, una rassegna dei più famosi bevitori fiorentini del tempo (il titolo I beoni, o più esattamente Capitoli d’una historia di beoni, sembra dovuto a un copista), dove l’arguzia caricaturale è in generale riuscita. Fresche e vive nella loro leggerezza le Canzoni a ballo, la prima delle quali risale al 1467. Tra i Canti carnascialeschi, alcuni dei quali Lorenzo compose forse prima del 1486, il Trionfo di Bacco e Arianna (1490) è un capolavoro: perfetta è la fusione tra elementi culturali e sentimento vivo della vita che fugge. Vivacissima la novella in prosa in cui narra il tiro furfantesco giocato da un giovane fiorentino a un gonzo senese. Allevato nella religione dalla pia madre e da Gentile Becchi, cui poi procurò il vescovato, scrisse anche Laudi, certamente non mentite, e la Rappresentazione di San Giovanni e Paolo, rappresentata per la prima volta nel 1491, sulla persecuzione dei cristiani da parte di Giuliano l’Apostata fino alla morte di questo.
LA MORTE – Nella primavera del 1492 Lorenzo de’Medici sentì declinare fortemente la sua salute, già minata dalla piaga ereditaria della famiglia Medici, la gotta. Benché non soffrisse quanto il padre Piero, Lorenzo andò incontro prima alla morte a causa della gangrena causata da un’ulcera, complicanza che causò un rapido deterioramento fisico. Infatti, si ritiene che la causa diretta della morte fosse dovuta alla perforazione dello stomaco e ad una peritonite. Trasportato alla Villa di Careggi, Lorenzo il Magnifico si spense all’età di soli 43 anni, circondato dai suoi amici più cari (Agnolo Poliziano, Pico della Mirandola), dai parenti e con i conforti religiosi impartiti proprio dal Savonarola.
9 aprile 2015
© RIPRODUZIONE RISERVATA