Gerhard Richter La grande retrospettiva a Parigi
La Fondation Vuitton dedica una grande mostra a Gerhard Richter: un viaggio tra memoria, astrazione e il potere inquieto della pittura.
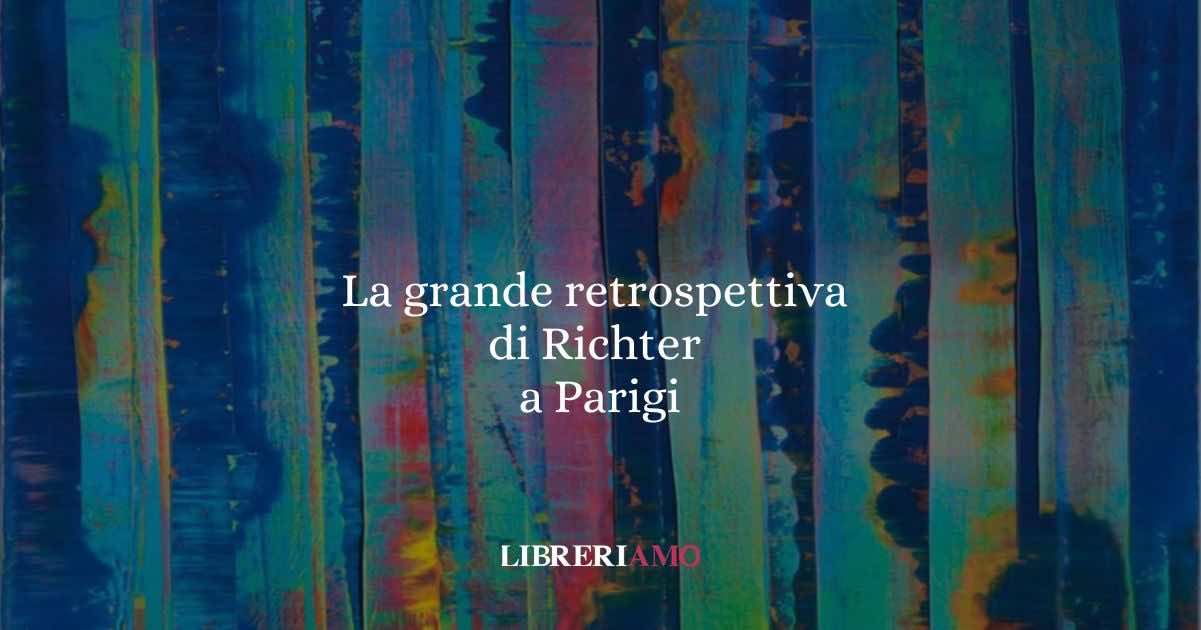
C’è un artista che non dipinge per spiegare, ma per mettere in dubbio. Che non cerca di rassicurare lo spettatore, ma lo interroga. Che non ha paura di contraddirsi, anzi: fa della contraddizione la sua estetica.
Questo artista è Gerhard Richter, maestro tedesco nato a Dresda nel 1932, tra i più influenti e misteriosi del secondo Novecento. Alla Fondation Louis Vuitton di Parigi, dal 17 ottobre 2025 al 2 marzo 2026, si celebra il suo percorso con una straordinaria retrospettiva, curata da Dieter Schwarz e Nicholas Serota, che presenta oltre 270 opere, tra dipinti, fotografie, sculture, vetrate e installazioni, ripercorrendo oltre sessant’anni di sperimentazioni.
Ma chi è davvero Gerhard Richter? E perché la sua opera continua a parlarci oggi, nell’epoca della moltiplicazione infinita delle immagini?
Le opere di Gerhard Ritcher da tenere presenti
Candle (1982) – Iconica e misteriosa, una candela accesa su sfondo scuro: silenzio, presenza, ritualità.
Onkel Rudi (1965) – Ritratto sfocato dello zio in uniforme: storia e trauma familiare che diventano pittura.
Betty (1988) – Forse il suo quadro più celebre: sua figlia girata di spalle, in un gesto di pudore e mistero.
Abstraktes Bild (1986–2000) – Serie di tele astratte fatte con raschiature e sovrapposizioni: pittura come palinsesto.
October 18, 1977 – Il ciclo dedicato alla morte dei membri della RAF in carcere: arte e rimozione della memoria.
Gerhard Richter: la resistenza della pittura in un mondo d’immagini
La mostra alla Fondation Louis Vuitton non è solo un omaggio a uno dei più grandi artisti viventi. È un’esperienza che ci invita a interrogarci sul potere della pittura oggi. In un mondo dominato dall’immagine digitale, Gerhard Richter ci ricorda che dipingere è ancora un gesto radicale. Un modo per resistere. Per sentire. Per pensare.
Dipingere come narrare: una resistenza silenziosa
Gerhard Richter non è un artista da incasellare. Non si è mai legato a un’unica corrente: non è stato espressionista, né concettuale, né iperrealista, eppure ha dialogato con tutte queste correnti.
Ha dipinto candele, marine, volti, paesaggi, fotografie sfocate, strisce di colore astratte. Ha alternato pittura a olio e squeegee, ritratti e superfici vibranti, figurazione e dissoluzione.
Il suo unico vero punto fermo è la pittura. Una pittura che resiste. Una pittura che non ha paura della complessità. Come ha detto lui stesso: “Dipingo per narrare. È come ballare o cantare. È qualcosa con cui conviviamo, qualcosa di umano”.
Dipinge per interrogarci. Per mostrare il visibile, ma anche il suo fallimento. Per trasformare l’immagine in qualcosa di impossibile da fissare una volta per tutte.
Un linguaggio che sfugge, come la memoria
La mostra di Parigi, non è solo un’esposizione, ma un percorso dentro la mente e l’anima di un artista che ha fatto dell’inquietudine la sua poetica.
Le sue immagini non sono mai definitive: si muovono tra presenza e assenza, memoria e oblio, riconoscimento e spaesamento.
Le sue opere più celebri, come: Onkel Rudi (il ritratto sfocato dello zio in uniforme nazista) o le tele dedicate alla RAF ( October 18, 1977 ), non sono “commenti politici”, ma domande etiche sulla rappresentazione della storia.
I paesaggi marini sono visioni silenziose, immobili, quasi sublimi. Le candele ardono di una luce intima, iconica. I ritratti femminili sembrano emergere da sogni o ricordi lontani.
E poi ci sono le grandi tele astratte, realizzate con spatolate, raschiature, gesti improvvisi e controllati insieme: superfici vive, che sembrano respirare.
Un artista contro la dittatura dell’interpretazione
Gerhard Richter ha sempre rifiutato l’idea di un’arte che deve spiegarsi. Per lui, ogni tentativo di fissare un significato è una forma di riduzione.
Il suo lavoro ci invita piuttosto a sospendere il giudizio e ad abitare l’ambiguità. Non è un caso che l’artista sia cresciuto nella Germania orientale, abbia vissuto il trauma della Seconda guerra mondiale e il passaggio al mondo occidentale.
L’ambiguità, in Gerhard Richter, è storica e personale. È il segno di un mondo che cambia continuamente, e in cui la verità non è mai univoca.
L’eredità di Richter: la pittura come esercizio di libertà
Alla Fondation Vuitton, questa complessità viene messa in scena in modo spettacolare. Le opere si dispongono non in senso cronologico, ma per affinità poetiche.
Accanto ai dipinti ci sono fotografie, disegni, esperimenti su vetro, incisioni, filmati. Gerhard Richter non è solo un pittore: è un autore totale, capace di attraversare i linguaggi e le tecniche, senza mai sacrificare la coerenza del suo pensiero.
Uno dei nodi centrali della mostra è il tema del corpo e della visione: il corpo come luogo dell’identità, della fragilità, della trasformazione.
La visione come possibilità, ma anche come limite. Il percorso espositivo, come ha scritto Vincenzo Trione, è anche una vertigine emotiva: non ci dà certezze, ma ci costringe a guardarci dentro.
Un’arte che abita l’inquietudine
Gerhard Richter ha sempre rifiutato di essere “moderno” nel senso lineare del termine. Non ha mai accettato l’idea che l’arte debba “andare avanti” rinnegando il passato.
Al contrario, ha continuato a lavorare sul concetto stesso di pittura, come se ogni tela fosse un tentativo di rianimarla, reinventarla, farla vibrare ancora.
In questo senso, la sua opera è un esempio di resistenza poetica: un invito a rallentare, a guardare, a sentire. A ritrovare, nella materia pittorica, qualcosa che il mondo digitale ci sta togliendo: la profondità del tempo, la forza dell’errore, la bellezza dell’indeterminato.