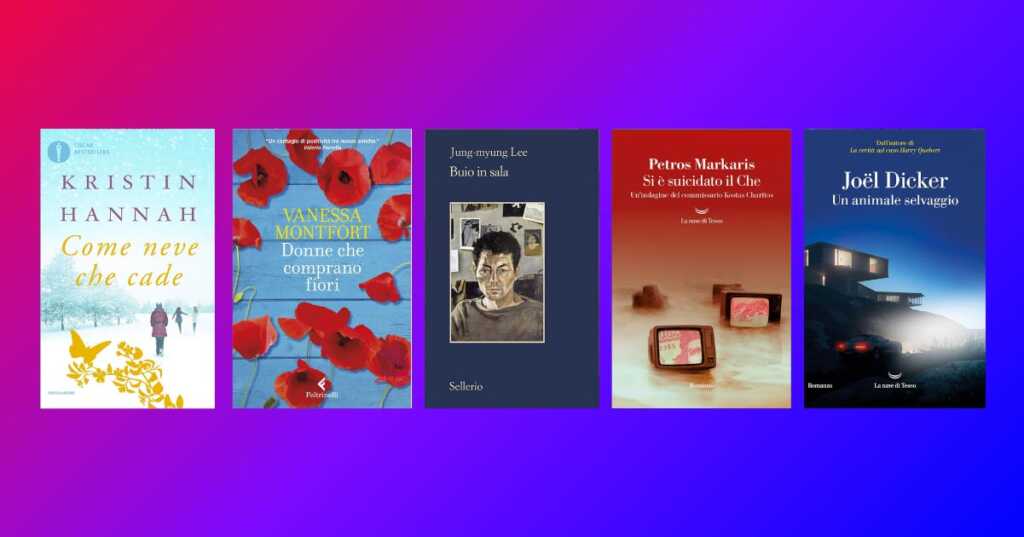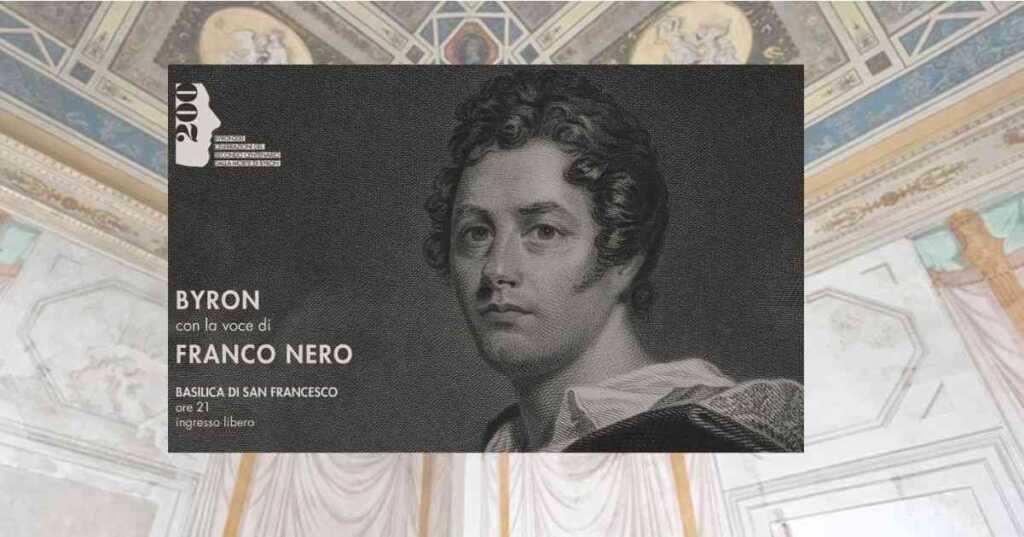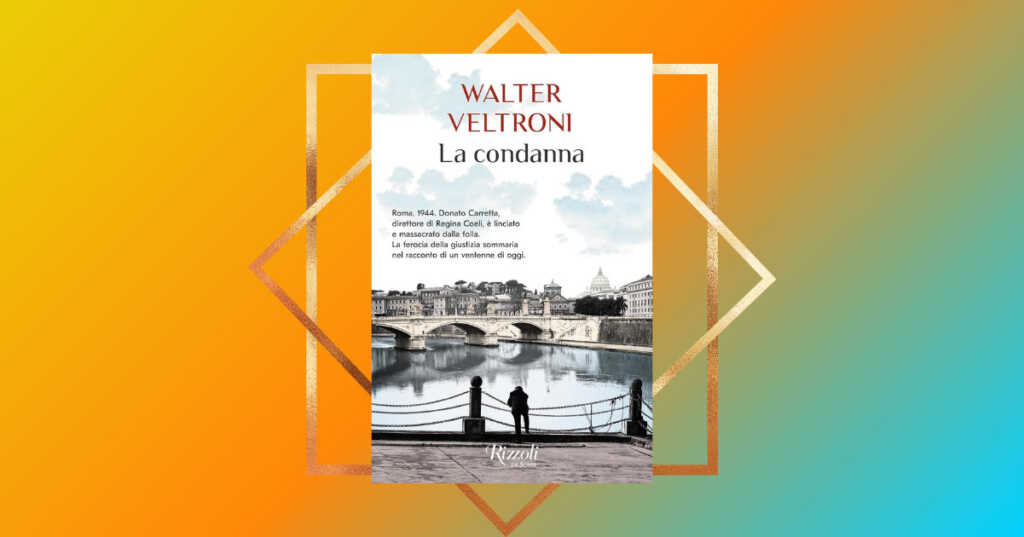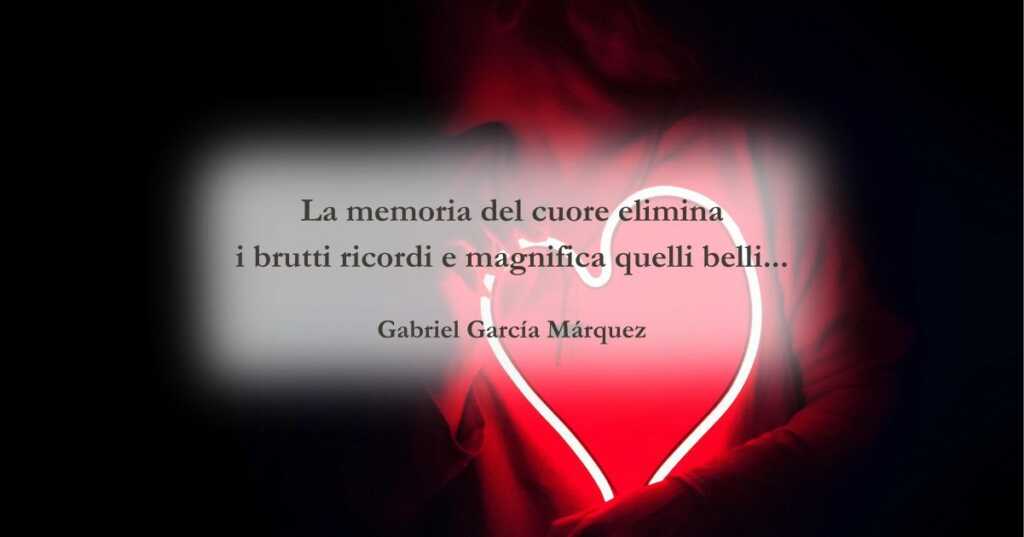Il responsabile di Domenica, l’inserto del Sole 24 ore dedicato alla cultura, illustra gli obiettivi del giornale e parla della situazione culturale italiana
MILANO – Diffondere i temi di un dibattito culturale alto con particolare attenzione alla scienza, da sempre sacrificata dalla tradizione dominante in Italia, e con toni vivaci, pieni di verve, per ridare vitalità alla cultura e affermare l’importanza di questo settore nel guidarci fuori dalla crisi. Questi gli obiettivi che si propone l’inserto domenicale del Sole 24 Ore, come ci spiega Armando Massarenti, giornalista del Sole 24 Ore e responsabile della Domenica.
Come nasce la Domenica, il supplemento del Sole 24 ore?
La Domenica nasce nel 1983 – ha oggi quasi trent’anni – per iniziativa dell’allora direttore del giornale Gianni Locatelli e del condirettore Mario Deaglio. Insieme avevano pensato a un prodotto giornalistico per la domenica legato al Sole 24 ore, puntando molto sulla cultura. Il nostro giornale era a quei tempi molto diverso da oggi, formato da poche pagine: avendo un taglio esclusivamente economico-finanziario la domenica non vendeva come gli altri giorni. L’idea era proprio quella di risollevare le vendite grazie a questo supplemento culturale, che ha avuto in effetti in tutti questi anni un grande successo, a dimostrazione del fatto che esiste un pubblico che ama una cultura di qualità. Il supplemento domenicale ha infatti sempre avuto la caratteristica di proporre direttamente i temi del dibattito culturale nel linguaggio proprio delle varie discipline, dedicando intere pagine agli articoli di esperti. Il punto di forza della Domenica è stato quello di avere dei redattori che erano degli specialisti nelle varie aree. Io per esempio sono laureato in filosofia della scienza, e ho curato per molti anni le pagine di scienza e filosofia, che sono molto caratterizzanti del nostro giornale, pagine in cui non ci si limita a parlare di filosofia, ma si fa filosofia. Lo stesso vale per la letteratura, il cinema, l’arte. Nato da un’esigenza puramente giornalistica, il supplemento è diventato così un importante strumento per tutta la cultura italiana, in particolare nell’ambiente universitario: il mondo della ricerca, sia scientifica sia umanistica, guarda alla Domenica come a un riferimento.
A che tipo di lettore si rivolge la Domenica e qual è il suo intento principale? Si propone un obiettivo educativo-didattico?
Il supplemento domenicale si rivolge a un lettore che non abbia nessuna pigrizia mentale. Si parla di temi di cultura generale, di letteratura, scienza, filosofia, di libri e bibliofilia, di storia e cultura religiosa. Tutti questi argomenti non sono trattati con un atteggiamento educativo o didattico in senso diretto. Non forniamo riassunti in pillole di argomenti predigeriti, ma ci rivolgiamo a degli esperti chiedendo loro di approfondire dei temi attraverso piccoli saggi, quali quelli che redigerebbero per riviste specializzate. Si possono semmai individuare degli elementi pedagogici in alcuni filoni che ci caratterizzano, in alcune idee guida, per esempio quella che la scienza debba fare parte integrante della cultura: qui c’è un elemento didattico, in questa volontà di far assimilare un principio estraneo alla nostra tradizione, da sempre profondamente antiscientifica. È infatti un difetto del nostro sistema educativo non far vedere quanto la scienza sia importante oggi per la cultura: siamo sempre stati dominati da filosofie e classi politiche che hanno messo la scienza in una posizione di subalternità rispetto alla cultura umanistica. In generale, poi, cerchiamo sempre di mettere in evidenza i metodi di lavoro alla base del sapere, e in questo senso facciamo un’opera importante di insegnamento.
I lettori della Domenica sono dunque un pubblico ristretto medio-alto?
Pur adottando il punto di vista di una cultura alta, non intendiamo la Domenica come rivolta a un pubblico ristretto. Vogliamo parlare a tutti, trattando i diversi argomenti con grande verve, in maniera anche molto divertente. Un elemento che io ho aggiunto in maniera molto decisa da quando, da circa un anno, sono diventato responsabile del supplemento, è quello di una scrittura letteraria: privilegiamo quegli autori che hanno una vena comica, che sanno veicolare l’intelligenza attraverso l’ironia, il paradosso. Un esempio su tutti è quello di Ermanno Cavazzoni. L’inverno scorso abbiamo anche riproposto una serie di novelle della tradizione boccaccesca riscritte da vari autori, che non erano mai arrivate al grande pubblico. Un modo per divertirsi attraverso la cultura, ma allo stesso tempo mantenendo il tono della serietà, dell’autorità, della consapevolezza delle potenzialità dei propri strumenti e della fallibilità dei propri strumenti. Una cultura alta infatti non può che essere antidogmatica.
In un momento di difficile crisi economica il Sole 24 ore ha saputo dimostrare un grande nerbo, interpretando le esigenze del momento e intervenendo con operazioni importanti laddove ce n’era bisogno. Il Manifesto della cultura agisce in questo senso, promuovendo e supportando uno dei settori maggiormente sacrificati dai tagli.
È stato il direttore del Sole 24 ore, Roberto Napoletano, a dare il consiglio molto utile e molto efficace di fare questi manifesti, che hanno riguardato in primo luogo l’economia e la politica. Abbiamo poi deciso di fare la stessa cosa con la cultura, con la convinzione che questo settore sia uno degli elementi strategici, importante quanto gli altri, per la crescita nel medio periodo e che un rilancio della cultura sia una necessità altrettanto urgente per uscire dalla crisi. L’intenzione è quella di ridare vitalità alla cultura, vitalità che questa ha perso a causa dell’incuria di una classe dirigente incapace di metterla al centro delle politiche del Paese. All’estero invece c’è la consapevolezza di quanto sia indispensabile, in momenti di crisi, non trascurare questo settore, in particolare la scuola. Uno degli obiettivi del nostro manifesto è convincere che ciò che si spende per la cultura rappresenta un investimento, non una voce di spesa da sottoporre a tagli trasversali.
Come vede la situazione della cultura in Italia?
Ci sono dei segnali positivi. Da una recente indagine Istat, per esempio, emerge come gli italiani ritengano importante la salvaguardia dei propri beni culturali e artistici ai fini di un benessere generale della società. Ci sono però anche dei dati che fanno pensare in termini molto negativi. Nel mondo l’immagine dell’Italia è associata alla Magna Grecia, all’Antica Roma, al Rinascimento, alla figura del genio universale di Leonardo Da Vinci, alla nascita dell’opera lirica. Purtroppo però a questa immagine non corrisponde un’adeguata realtà. Nei secoli passati gli stranieri che venivano in Italia entravano sì in contatto con tutte queste meraviglie, ma anche con un popolo in maggioranza analfabeta. Oggi la situazione è molto migliorata, ma persiste un dato preoccupante: quello dell’analfabetismo funzionale. Le persone sanno leggere e scrivere, ma a questa facoltà non corrisponde la capacità di comprendere a pieno il significato di un testo, anche di un articolo di giornale. Tra i Paesi industrializzati siamo quello che più soffre di questo problema: è vero, c’è una percentuale di lettori forti, ma si tratta di una netta minoranza. Se la classe politica, invece che proporre soluzioni al problema, se ne approfitta per crearsi un bacino di voti proprio tra quell’elettorato del tutto inconsapevole, non riusciremo mai a crescere veramente, resteremo consumatori acritici di cose prodotte da altri.
31 luglio 2012