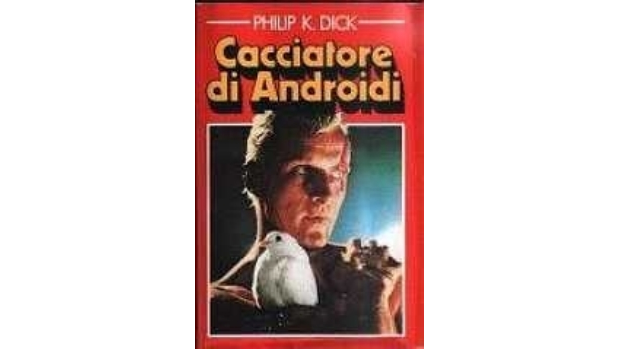Gli androidi sognano pecore elettriche? Che cos”è la realtà?
L’ossessione dell’interrogazione da parte di Philip Dick in “Il cacciatore di androidi“, non ha trovato mai risposte, ma il rinnovarsi della domanda ha generato narrazioni opache, claustrali. In questa forma di autocura che è scrivere, si è trovata l’ossatura delle proprie inquietudini, tale da permettere ad un soggetto incerto una posizione eretta. Il Rick Deckard dickiano non ha niente dell’eroe chandleriano del film “Blade runner”, se non la domanda: chi sono? E’ la domanda a cui è costretta la vita di ognuno, se mai avesse un senso porsela. Di fatto Deckard è stanco di incarnare il significante padrone dell’essere, quell’io sono che solo può essere pronunciato per differenza: non è umano il simulacro non generato per via sessuale, mancando il debito di amore e dolore che si deve -”a vita” fino ”a morte”- a coloro da cui si è stati desiderati.
In Deckard si insinua il sospetto che in realtà non abbia nessun diritto a pronunciare la parola fine per un’altra vita, benchè sintetica, o droide, o replicata sulla scorta di informazioni geneticamente ricreate. Non vuole più essere il braccio armato di un ente che stabilisce chi ha diritto a chiamarsi umano e chi no. Il punto cieco della domanda sta nel ritiro di un droide donna, una cantante lirica, sorpresa nel suo camerino durante le prove de “Il flauto magico”. Il suo nome è Luba Luft: ama cantare, ha una splendida voce, e per estremo paradosso ammira gli esseri umani, il loro incantato sguardo smarrito sul mondo in cerca solo di riconoscimento. Un droide non può provare sensazioni simili: un replicante è una entità isolata, che non aspetta dall’altro nessun messaggio che lo riguardi, tanto da poterne fare a meno con la più infantile delle disinvolture. Luba canta Mozart perchè cerca la propria mancanza dentro la cattedrale musicale di una fiaba, sperando così di poter somigliare, quasi confondersi con un essere umano, carpirne il segreto, per poter anche lei divenire smarrita come loro, impaurita come loro, disperata come loro.
Invece l’unico momento umano che si concede ad un replicante è la morte, giacchè -allo stesso modo degli uomini- amano la vita, benchè se ne sentano esclusi. Sono alla ricerca del padre (ecco un’altra delle pochissime analogie col film), di un essere che legittimi loro come esseri dotati di diritti, degni di amore. In fondo nessuno somiglia più a un replicante di un individuo senza padre né madre; somigliano a quegli adolescenti che all’affacciarsi della pubertà cercano di colmare il buco costitutivo con il sintomo nevrotico della ricerca dei veri genitori, come se da questa potesse venire una risposta appena soddisfacente per vivere con fiducia quanto resta. Anche Deckard è un orfano, come tutti quelli che restano per indugiare sul capezzale della ”madre terra” di fatto già morta; i replicanti invece vi tornano obbedendo all’impulso irresistibile di fronteggiare il proprio padre digitale, e trovare risposta impossibile ad una domanda non tanto ontologica (chi sono?), quanto generativa: sono degno d’amore? Credo proprio che leggerò ancora una volta “Gli androidi sognano pecore elettriche?”. Sono spinto da un impulso irresistibile, assoluto, di frequentare ancora quei tristi capitoli, di scrivere la mia vita appoggiandomi alle parole di Dick, ed estrarre quegli appunti immaginari tra le righe che mi ha suscitato negli anni questo romanzo che mai ha cessato di parlarmi.
Il Deckard del romanzo non ha niente a che vedere con quello tronfio, e con la ben organizzata solitudine del film di Scott, brutta copia dei personaggi dell’hard boiled americana. Certo la produzione mai avrebbe digerito il travet tristemente nevrotico della pagina scritta, costantemente alla ricerca di riconoscimento e di amore, prima dalla moglie, poi dai vicini, dal suo capo, e infine da un”algida androide. Deckard fa il suo lavoro di sbirro per abitudine, per soldi, come un normale impiegato, e con sogni tutto sommato piccolo borghesi che certo non hanno appeal per il gran pubblico che ha voglia di evadere, senza ricadere nelle ben tristi e conosciute frustrazioni quotidiane. Vuole acquistare una pecora vera (la terra è appena uscita da una guerra termonucleare che ha estinto quasi del tutto la specie animale), piuttosto che dedicarsi alla triste cura di una elettrica. Questo lo farebbe stare bene, gli farebbe affrontare meglio i vicini di casa, il capo, il pericolo per il suo lavoro, e il fatto di non essersene andato in una delle colonie extramondo, per restare sulla terra con le polveri sottili a inquinare il suo genoma, con il rischio di vedersi negata la capacità procreativa. Il Deckard di carta si sente poca cosa, come la sua nemesi replicante, un sottoessere, un insetto, con le qualità entomologiche dell”insetto: nascondersi e sopravvivere. Dick è a mio avviso il vero erede di Kafka. Lui solo come il grande praghese, ha saputo fare romanzo di questa disperazione malata, senza riconoscimento nè amore, solo con un dovere tirannico che spezza il respiro, attualizza la morte. Ma non sta proprio in questo la stimmata più singolare ed autentica cha fa chiamare umana la nostra malattia?
Vincenzo Carboni
19 settembre 2015