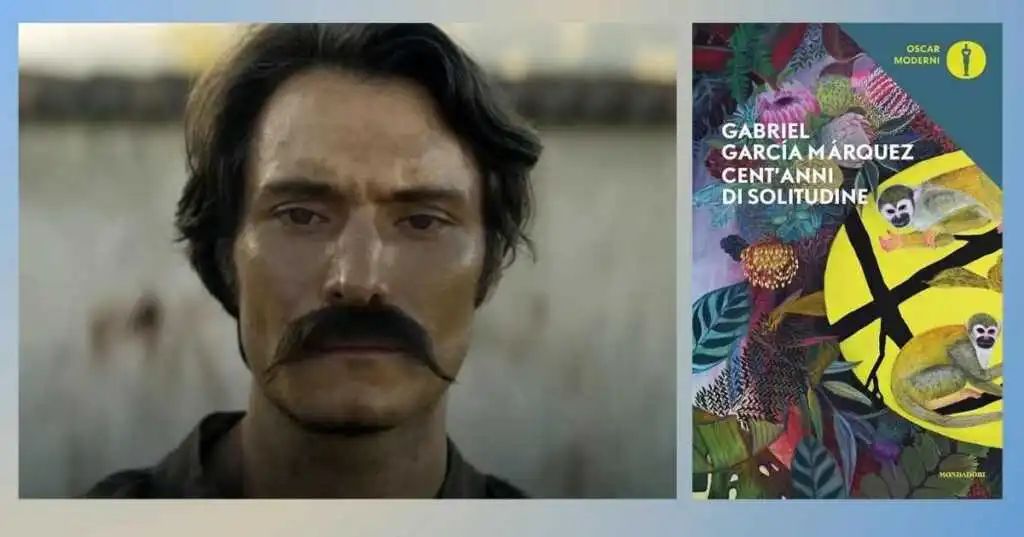Immedesimandosi nella vita di un pastore girovago sugli altopiani asiatici, Giacomo Leopardi avvia nel Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (1829) un lungo e struggente dialogo con la Luna. Al nostro satellite il poeta dischiude le domande più profonde sul senso dell’esistenza, con drammatica semplicità. Riscopriamo uno dei componimenti più belli della storia della letteratura italiana proprio in occasione dell’anniversario della nascita del suo autore, Giacomo Leopardi, che domani avrebbe compiuto 225 anni.
L’invocazione alla luna
A partire dall’interrogazione iniziale, ‘Che fai tu, luna, in ciel?‘, Leopardi inizia un confronto tra la condizione umana, assediata da innumerevoli dolori, sofferenze, noia – per poi giungere a cosa? All’abisso orrido immenso, la morte, che tutto oblia – a quella della Luna, sempiterna peregrina, superiore agli affanni mortali.
Anche la Luna in fondo, ragiona Leopardi, partecipa dello stesso struggimento del poeta: anche il suo girovagare sembra essere privo di senso, così come quello delle stelle del firmamento, e di tutti gli esseri viventi. ‘A che tante facelle? / Che fa l’aria infinita, e quel profondo / Infinito Seren? che vuol dir questa / Solitudine immensa? ed io che sono?’
Una poesia capace di interrogare nel profondo sullo scopo della vita, sul senso di inadeguatezza di tutte le “cose mortali” rispetto a quello che desideriamo. Da leggere e rileggere, uno dei più grandi capolavori di Giacomo Leopardi e della poesia italiana.
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” di Giacomo Leopardi
Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,
Silenziosa luna?
Sorgi la sera, e vai,
Contemplando i deserti; indi ti posi.
Ancor non sei tu paga
Di riandare i sempiterni calli?
Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga
Di mirar queste valli?
Somiglia alla tua vita
La vita del pastore.
Sorge in sul primo albore
Move la greggia oltre pel campo, e vede
Greggi, fontane ed erbe;
Poi stanco si riposa in su la sera:
Altro mai non ispera.
Dimmi, o luna: a che vale
Al pastor la sua vita,
La vostra vita a voi? dimmi: ove tende
Questo vagar mio breve,
Il tuo corso immortale?Vecchierel bianco, infermo,
Mezzo vestito e scalzo,
Con gravissimo fascio in su le spalle,
Per montagna e per valle,
Per sassi acuti, ed alta rena, e fratte,
Al vento, alla tempesta, e quando avvampa
L’ora, e quando poi gela,
Corre via, corre, anela,
Varca torrenti e stagni,
Cade, risorge, e più e più s’affretta,
Senza posa o ristoro,
Lacero, sanguinoso; infin ch’arriva
Colà dove la via
E dove il tanto affaticar fu volto:
Abisso orrido, immenso,
Ov’ei precipitando, il tutto obblia.
Vergine luna, tale
È la vita mortale.Nasce l’uomo a fatica,
Ed è rischio di morte il nascimento.
Prova pena e tormento
Per prima cosa; e in sul principio stesso
La madre e il genitore
Il prende a consolar dell’esser nato.
Poi che crescendo viene,
L’uno e l’altro il sostiene, e via pur sempre
Con atti e con parole
Studiasi fargli core,
E consolarlo dell’umano stato:
Altro ufficio più grato
Non si fa da parenti alla lor prole.
Ma perché dare al sole,
Perché reggere in vita
Chi poi di quella consolar convenga?
Se la vita è sventura,
Perché da noi si dura?
Intatta luna, tale
È lo stato mortale.
Ma tu mortal non sei,
E forse del mio dir poco ti cale.Pur tu, solinga, eterna peregrina,
Che sì pensosa sei, tu forse intendi,
Questo viver terreno,
Il patir nostro, il sospirar, che sia;
Che sia questo morir, questo supremo
Scolorar del sembiante,
E perir dalla terra, e venir meno
Ad ogni usata, amante compagnia.
E tu certo comprendi
Il perché delle cose, e vedi il frutto
Del mattin, della sera,
Del tacito, infinito andar del tempo.
Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore
Rida la primavera,
A chi giovi l’ardore, e che procacci
Il verno co’ suoi ghiacci.
Mille cose sai tu, mille discopri,
Che son celate al semplice pastore.
Spesso quand’io ti miro
Star così muta in sul deserto piano,
Che, in suo giro lontano, al ciel confina;
Ovver con la mia greggia
Seguirmi viaggiando a mano a mano;
E quando miro in cielo arder le stelle;
Dico fra me pensando:
A che tante facelle?
Che fa l’aria infinita, e quel profondo
Infinito Seren? che vuol dir questa
Solitudine immensa? ed io che sono?
Così meco ragiono: e della stanza
Smisurata e superba,
E dell’innumerabile famiglia;
Poi di tanto adoprar, di tanti moti
D’ogni celeste, ogni terrena cosa,
Girando senza posa,
Per tornar sempre là donde son mosse;
Uso alcuno, alcun frutto
Indovinar non so. Ma tu per certo,
Giovinetta immortal, conosci il tutto.
Questo io conosco e sento,
Che degli eterni giri,
Che dell’esser mio frale,
Qualche bene o contento
Avrà fors’altri; a me la vita è male.O greggia mia che posi, oh te beata,
Che la miseria tua, credo, non sai!
Quanta invidia ti porto!
Non sol perché d’affanno
Quasi libera vai;
Ch’ogni stento, ogni danno,
Ogni estremo timor subito scordi;
Ma più perché giammai tedio non provi.
Quando tu siedi all’ombra, sovra l’erbe,
Tu se’ queta e contenta;
E gran parte dell’anno
Senza noia consumi in quello stato.
Ed io pur seggo sovra l’erbe, all’ombra,
E un fastidio m’ingombra
La mente, ed uno spron quasi mi punge
Sì che, sedendo, più che mai son lunge
Da trovar pace o loco.
E pur nulla non bramo,
E non ho fino a qui cagion di pianto.
Quel che tu goda o quanto,
Non so già dir; ma fortunata sei.
Ed io godo ancor poco,
O greggia mia, nè di ciò sol mi lagno.
Se tu parlar sapessi, io chiederei:
Dimmi: perché giacendo
A bell’agio, ozioso,
S’appaga ogni animale;
Me, s’io giaccio in riposo, il tedio assale?Forse s’avess’io l’ale
Da volar su le nubi,
E noverar le stelle ad una ad una,
O come il tuono errar di giogo in giogo,
Più felice sarei, dolce mia greggia,
Più felice sarei, candida luna.
O forse erra dal vero,
Mirando all’altrui sorte, il mio pensiero:
Forse in qual forma, in quale
Stato che sia, dentro covile o cuna,
È funesto a chi nasce il dì natale.
Giacomo Leopardi
Giacomo Leopardi nasce il 29 giugno 1798 a Recanati, da una delle più nobili famiglie del paese. Affidato sin dalla giovane età alle cure di un precettore, Giacomo si rivela un bambino prodigio: a dieci anni riesce a tradurre all’impronta testi classici greci e latini.
Il rapporto coi genitori, in particolare con il padre Monaldo, è conflittuale. Leopardi trascorre la sua gioventù chiuso nella biblioteca di famiglia, studiando tutto lo scibile contenuto da quei libri che ben presto diventano i suoi unici amici. Nel giro di pochi anni impara diverse lingue moderne, studia storia e filosofia e si accinge alla composizione di opere erudite.
È nel 1816 che Leopardi si appassiona finalmente alla poesia e invia i suoi primi versi a Pietro Giordani, che subito lo incoraggia a proseguire nell’attività. Da questo momento, Giacomo Leopardi compone moltissime opere, fra le più diverse: lo “Zibaldone di pensieri”, il diario che raccoglie le impressioni e gli appunti dell’autore sin dall’inizio della sua produzione, le “Operette morali”, le trentasei liriche inserite nella raccolta de “I Canti” …
Leopardi si serve della prosa e della poesia per riflettere su temi importanti quali il senso della vita e della morte, la deriva delle coscienze, il ruolo della natura e l’amore.
Nel corso della sua vita, Giacomo Leopardi ha sempre desiderato viaggiare e, più verosimilmente, allontanarsi da quella casa che è per lui nientemeno che una prigione: un tentativo di fuga sventato dal padre risale al 1819, anno in cui il poeta compone il suo capolavoro, “L’infinito”. Nel 1822 riesce ad ottenere il permesso di recarsi per un po’ dagli zii a Roma.
Leopardi ritorna dopo qualche mese e nel 1825 ha inizio il pellegrinaggio che lo porta prima a Milano, dove lavora presso l’editore Stella, poi a Bologna, Firenze e Pisa.
Alla fine del 1828 Leopardi ritorna a Recanati, dove cade in depressione ma scrive alcuni fra i suoi componimenti più celebri, fra cui spiccano “Il sabato del villaggio” e “La quiete dopo la tempesta”. Nel 1830 Leopardi, aiutato da alcuni amici, lascia definitivamente il borgo natio e si trasferisce a Napoli in compagnia dell’amico Antonio Ranieri, dove scrive le liriche che costituiscono il piccolo testamento spirituale del poeta: “La ginestra” e “Il tramonto della luna”. Giacomo Leopardi muore il 14 giugno 1837.