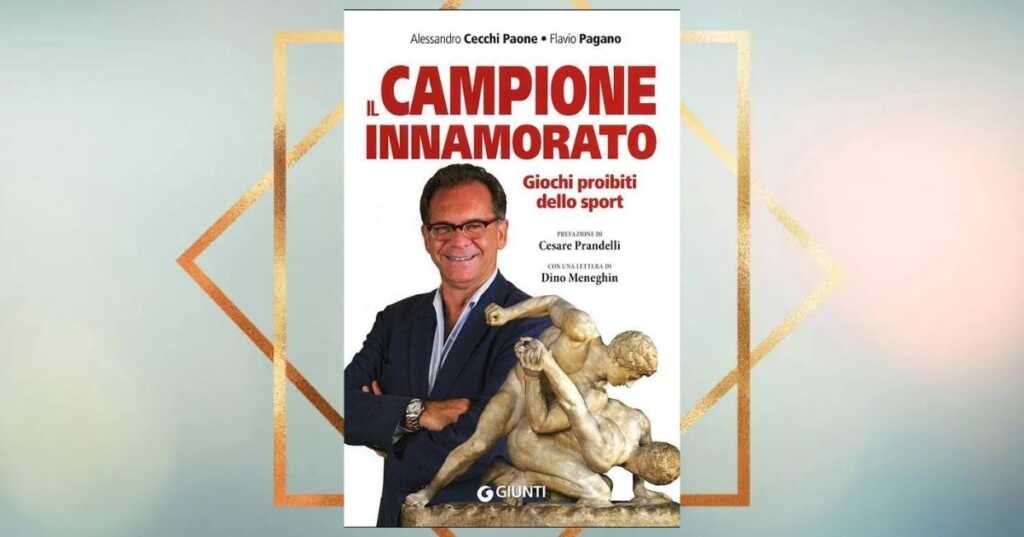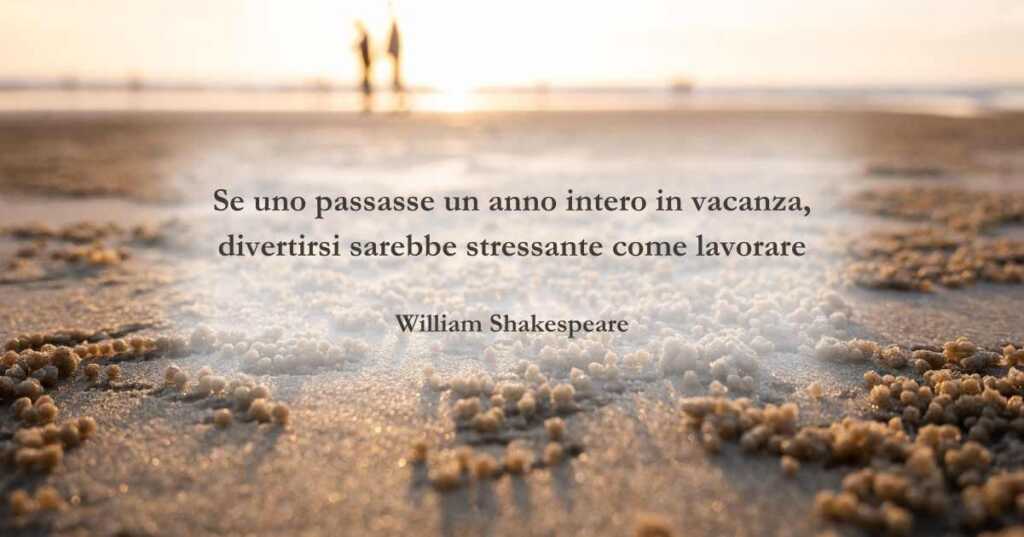MILANO – Cosa significa essere hikikomori oggi, come si declina nel mondo questa parola che illustra un disturbo tipico di una generazione di auto-reclusi? Chi sono gli hikikomori giapponesi, e quelli italiani? Possono i manga curare queste creature fragili eppure intelligentissime che dicono no alla società? E davvero internet conta molto per loro, l’età media qual è? A questa e molte altre domande cerca di rispondere Anna Maria Caresta in Generazione hikikomori – Isolarsi dal mondo, tra web e manga (Castelvecchi, pp 112), libro in cui la giornalista Rai interpella una serie di esperti e conoscitori del problema sul doppio versante giapponese e italiano. La scrittrice, ricercatrice e docente universitaria residente a Tokyo Laura Imai Messina l’ha intervistata per noi.
Come si è interessata a questo argomento? Cosa l’ha spinta, dei tanti fenomeni sociali presenti nel nostro tempo, a occuparsi proprio della Generazione hikikomori?
Per fortuna vivo in mezzo ai giovani, ai figli e ai loro amici. Ho figli che hanno attraversato da pochi anni l’adolescenza, e magari ci sono ancora un po’ dentro, e ho notato come sia loro che i loro coetanei passassero tante ore davanti al computer. A volte troppe. Ho visto poi che soprattutto i ragazzi nel fine settimana andavano a giocare nelle sale lan dove si fanno giochi on line e ci si collega con coetanei che sono come loro davanti ad un pc, ma magari all’altro capo del mondo, e che hanno le loro stesse abitudini. Ho notato che questi giochi diventano parte integrante del mondo degli adolescenti. E sono venuta a sapere di teen-ager che trascorrevano in queste sale l’intera notte. Poi un giorno ho sentito parlare da un pediatra degli hikikomori. E, per curiosità, ho iniziato a studiare, diciamo così, l’argomento. E ho scoperto che è l’estremizzazione di un problema che riguarda tutti i giovani, quindi il nostro futuro.
Ho trovato riuscitissima la struttura del libro, che tiene sempre alta l’attenzione del lettore grazie a un cambio di scena quasi cinematografico, e a una lingua a tratti evocativa ma mai supponente. Quale è stata la sua personale bussola per orientarsi nel mondo degli hikikomori ed elaborare un percorso di ricerca, strutturare le domande da porre ai vari esperti, e infine per realizzare il tutto in un racconto scritto?
Devo tanti “grazie” per questo libro. Li devo ad amici giapponesi che vivono in Italia e che mi hanno suggerito il nome di una ottima interprete, che ha saputo trovare i toni giusti, sia per le domande ai ragazzi e alle ragazze hikikomori, che per le istituzioni e, ancora, per i dialoghi e le interviste con giornalisti, medici, responsabili dei centri per ritirati sociali. Mi sono portata dietro dall’Italia un quadernino verde, che è il mio colore preferito, un regalo che mi è arrivato da casa, e su quello ogni sera preparavo le domande da porre il giorno dopo ai vari interlocutori. Per l’intervista con Tamaki Saito, massimo esperto del settore, mi ero documentata in Italia, leggendo altre interviste e ordinando on-line uno dei suoi libri tradotti in inglese. Per il resto, ho improvvisato, cercando di ascoltare attentamente quello che mi veniva raccontato e rilanciando se necessario l’argomento con altre domande. Grazie agli appunti presi, veramente tanti, e alle note che ho scritto, sono poi riuscita a ricostruire questo viaggio. Che per me è stato importante e che ha toccato corde di sensibilità. Sono abituata poi, per lavoro, a tradurre ciò che vedo in immagini. Ed è questa la struttura che ho scelto di dare al libro. Ma che, devo dire, si è scelta un po’ da sola, anche.
Esiste una lettura positiva del ritiro dalla società, che sarebbe invece reso cupo e lugubre piuttosto dalla sua mancata accettazione generale, come se idealmente potesse essere utile un periodo di pausa in una società rapidissima e colma di richieste come quella attuale. Alcuni esperti giapponesi e altri ex-hikikomori sottolineano la necessità di non disturbare questo periodo di transizione. Non è allora forse utile, persino sano, prendersi una pausa?
Certo, le pause servono. Così come servono certe volte il silenzio e la riflessione. Gli hikikomori in genere sono ragazzi intelligenti, più intelligenti di molti loro coetanei, lo dicono gli esperti. E forse hanno anche una vena critica che non viene così ben accolta dalla società. Riflettere, prendere pause, va bene, benissimo. Ma i giovani, soprattutto loro, non devono farsi male. Quindi dopo un periodo no, devono andare avanti. E credo sia bene farlo lontano dalla famiglia. Altrimenti tutti i componenti del nucleo rimangono intrappolati nel “periodo no”, che diventa troppo lungo e difficoltoso da lasciarsi alle spalle. L’isolamento poi, quando si fa irreversibile, diventa un problema.
Ad apertura del suo libro ci troviamo nel monastero buddista di Koyasan, dove è possibile celebrare il proprio funerale. I diversi ambienti e metodi di cura italiani e giapponesi tengono conto secondo lei anche di una sostanziale differenza nell’approccio al credo religioso?
Sostanzialmente credo di no. Un sacerdote italiano immagino possa dare risposte diverse rispetto alla pratica sperimentata dai preti buddisti con i genitori degli hikikomori. Ma quello che conta è il messaggio di speranza. E la lettura della realtà che c’è dietro al dolore dei ragazzi, dei loro genitori e anche di una società, sia quella giapponese che quella italiana, non più in grado di cogliere dei campanelli di allarme che rischiano di diventare problemi sociali rilevanti. Quanto ai medici, psichiatri e psicoanalisti, hanno sempre a che fare con i mali dell’anima, in entrambi i paesi. Quindi penso che ci siano più affinità di quanto si possa in genere pensare.
Più volte nel libro si evidenzia una differenza culturale tra Giappone e Italia, che fa la prima soggetta al senso di vergogna, e la seconda al senso di colpa. Da quale, secondo lei, è più semplice svincolarsi? Rinviene una soluzione più rapida in uno o nell’altro caso?
Purtroppo credo che sia difficile sbarazzarsi di entrambi questi sentimenti. L’unica è andare avanti, portandoseli dietro negli anni. Penso però che il senso di vergogna possa forse fare maggiore presa perché è tipico di una cultura, quella giapponese, dove si avverte con forza. In Italia non tutti provano sensi di colpa. E spesso le persone o fanno finta di non provarli, oppure imparano a non farci più caso, vivendo alla giornata. Da noi la filosofia del Carpe diem è molto sentita. Ci aiuta ad attutire tutto da secoli.
Lo hikikomori avverte nella società, e soprattutto nella scuola che della società si fa la più efficace promotrice nell’infanzia e nell’adolescenza, l’intollerabile pressione, come di una mano che lo spinga ad andare avanti e finisca, troppo vigorosa, per farlo cadere. Fragilità, quindi, e tuttavia, trasformandosi in hikikomori, questi ragazzi paiono sviluppare una marmorea resistenza al mondo esterno. Come si accordano le due cose?
La marmorea resistenza è la loro risposta a ciò che ritengono eccessivo. Immagino che le richieste della società giapponese siano eccessive per uno studente. Se il doposcuola finisce alle 11 di notte non c’è tempo per stare con gli amici, per scherzare, neanche per litigare con i genitori, cosa che credo sia tra gli sport preferiti degli adolescenti. Dalle interviste fatte, mi sembra che il bullismo sia molto presente in Giappone nelle scuole e che per gli studenti sia duro difendersi. Chi si chiude a riccio lo fa a volte perché pretende troppo da se stesso. Un hikikomori però non può che far finta di essere indifferente a quello che gli succede intorno, altrimenti soffrirebbe troppo.
A dispetto dei casi limite, in cui lo stato di hikikomori si unisce a un disagio psicologico più ampio che dà origine a quella definita in giapponese kateinai bōryoku (violenza domestica), accadimenti che per forza di cose salgono ai disonori della cronaca fissandosi nell’immaginario comune, i soggetti interessati sono tendenzialmente pacifici, così inermi da rendersi incapaci di reagire al proprio stato e di affrontare l’esistenza. Dei vari incontri fatti, in Giappone e in Italia, quali quelli che le sono rimasti più impressi? Ha avvertito simile questo stato di disarmo nei confronti della vita?
Sì. Ed è un aspetto che mi ha fatto molta paura. L’ho avvertito in tutti gli hikikomori con cui sono venuta a contatto. Ed ho provato dispiacere per loro. Sono due comunque gli incontri che mi hanno colpito maggiormente: il primo è avvenuto alla fine del 2015 all’interno dell’ospedale Gemelli, a Roma. Seduto su una panca in un lungo corridoio c’era una ragazzo di 18 anni, con il volto immerso in un manga. Non voleva parlare, ma dopo un po’ di domande si è sciolto e mi ha raccontato di una sorellina morta per una grave malattia, della solitudine che aveva provato e della passione sfrenata per il gioco on line che aveva sviluppato. Ora Mauro, così l’ho chiamato con un nome di fantasia nel libro, sta meglio. Spero che tutto quello che ha passato sia solo un brutto ricordo. L’altro incontro è quello con “la ragazza perbene” al centro per hikikomori a Tokyo. Mi è sembrata l’incarnazione del senso di vergogna. Mi è apparsa sola, al pari di Mauro. E ho pensato che entrambi dovrebbero meritare molto di più e di meglio dalla vita.
Famiglia, scuola, sono luoghi e tempi nevralgici della comunicazione, che scandiscono anche l’inizio e l’aggravarsi del disagio. L’uomo è davvero un animale sociale? Da tutto questo studio che ha condotto cosa ne trae?
Credo di sì, credo fermamente che l’uomo sia un animale sociale. E quello degli hikikomori è il grido di chi, in qualche maniera, per incapacità sua o altrui, è stato allontanato da questa dimensione e resta a guardare dalla finestra.
A fronte dell’immenso interesse che negli ultimi anni si è riversato a livello internazionale sugli hikikomori e delle tante pubblicazioni che ne sono derivate, cosa aggiunge secondo lei Generazione hikikomori alla letteratura sempre più ampia sul tema?
Un confronto tra l’Italia e il Giappone. E forse qualche racconto di vita.
“Peccato dire addio a Koyasan senza aver celebrato il mio funerale. Sarà per un’altra volta” scrive. Quando lo farà? Lo farà?
Mi è capitato di rileggere quella frase e di scoppiare a ridere. Ho cercato di essere ironica. Non so se potrò celebrare il mio funerale. Ma mi diverte pensare di sì.
Laura Imai Messina